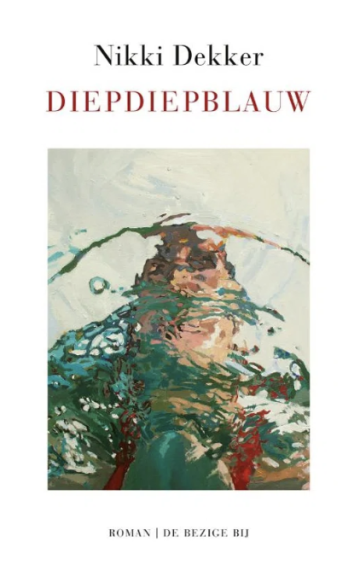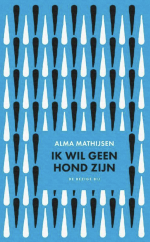Galleggio con il viso sott’acqua e resto calma. Non devo attirare l’attenzione, non devo sprecare energia. Basta stare ferma, così. Respirare piano, molto piano. Pluf! Salendo, le bollicine mi solleticano le guance.
All’ultimo momento il mio corpo sarà scosso da un fremito, la pancia si contrarrà per costringere la bocca ad aprirsi e a quel punto, con calma e decisione, tirerò la testa fuori dall’acqua e prenderò una bella boccata d’aria.
«Settantadue secondi!» griderà qualcuno.
Questa è un’abilità che nella vita non ti porta da nessuna parte. Al massimo ti avvicina a te stessa.
Sto sul fondo della piscina e guardo in su, verso la gente che nuota senza fare caso a me. Passo la punta delle dita sulle fughe ruvide delle piastrelle.
Quando l’ho saputo? L’ho sempre saputo, e ancora non lo so. Nella mia memoria succede tutto insieme. Mi vedo come una collezione di polaroid, una accanto all’altra su un frigorifero. I secondi in cui è stato premuto l’otturatore riassumono l’intera storia in un paio di immagini: lì c’è lei in braccio a me, lì ci sono io che cammino nell’atrio, lì sono a lato della pista da ballo mentre una vecchia amica di scuola mi racconta che è lesbica, e io dico: «Anche io un po’, credo».
Sono sempre stata brava a trattenere il respiro.
&
La porta sul retro è aperta e di tanto in tanto entra una brezza leggera. Sono seduta sulla sedia da ufficio ipermoderna che ha appena comprato mio padre, al computer ipermoderno che abbiamo da un anno: una pallina bianca con sopra un gambo che sorregge un grosso schermo. La scrivania è talmente larga che posso appoggiare comodamente le gambe incrociate sul piano del tavolo, accanto al computer. A parte una scatola di fiammiferi, è sgombra. I miei polpacci, lucidi di sudore, scivolano uno sull’altro.
È il 2003.
«Non c’è, non c’è vita per me.»
Accendo i fiammiferi uno a uno, osservo ogni fiammella salire verso la punta delle dita, e poi la spengo con un soffio.
Aspetto una soluzione per un problema che non sapevo di avere.
«Senza risposte ai miei perché adesso cosa mi resta di te.»
Non ho neanche quindici anni e sono già nostalgica; ascolto una canzone in italiano, che non capisco, e mi vedo bambina, sul sedile posteriore della Volkswagen: la testa appoggiata contro il finestrino, i pali della luce striano il cielo. La batteria e il coro di sottofondo sono tremendamente sicuri di sé.
Ecco come trascorro l’estate: metto su i CD di mio padre e gioco a un giochino online gratuito, in cui devo far esplodere delle palle colorate sparandoci contro altre palle dello stesso colore. Non è un gioco che si può vincere o perdere. Va avanti e basta. Ogni esplosione dà un piccolo brivido di adrenalina. Sparo ancora una volta. Canticchio al ritmo della canzone. Prendo un altro fiammifero. Apro la finestra di MSN, dove appaiono e scompaiono i nomi dei miei amici, circondati da disegnini di rose e arcobaleni. Non c’è non c’è. Jitske è offline. Thijmen è online. Anne è online.
«Ti sei baciata con Lisanne? Sul serio?»
«No» digito io.
«Lei dice di sì.»
&
Un pesce piatto riesce a imitare con precisione il colore dell’ambiente che lo circonda nel giro di qualche minuto. Gli occhi, posti entrambi sul lato superiore del corpo schiacciato, si guardano in giro attoniti, e il cervello invia segnali alle cellule del colore, che in base a tali informazioni si riempiono o si svuotano di pigmento. Se non sta nuotando, è quasi impossibile vedere un pesce piatto sul fondo del mare a occhio nudo. Diventa visibile solo quando si muove.
&
Scegliamo una famiglia, costruiamo una casa e diamo alla sorella maggiore una piscina in giardino. Ci scivola dentro, e quando i suoi seni da Barbie nel bikini striminzito toccano l’acqua e lei inizia a nuotare a rana, noi mettiamo in pausa il gioco e togliamo la scaletta. Osservo la bambolina con le mani in aria, grandi punti esclamativi sopra la testa, furiosa, impaurita, tra poco finalmente immobile.
The Sims è un’abbreviazione di The Simulated. I finti, le persone artificiali. Non sono veri. Un’intera generazione è cresciuta torturando e ammazzando degli alter ego. Ci sono forum in cui si discutono i metodi più inventivi e diffusi. Attacchiamo briga, diamo fuoco alla casa, prendiamo ventitré cani e chiudiamo il papà in camera da letto, come esercizio per la vita adulta. Ci siamo quasi. Stiamo diventando persone. O almeno facciamo finta, in modo estremamente convincente.
&
Un foglietto accartocciato sullo zerbino: non siamo più amiche. Le ragazze parlano tra loro di quello che hanno detto le altre. Alle elementari andavamo già di casa in casa, infilando nella buca delle lettere dei bigliettini con scritto a chi stava antipatico chi. A volte ci vai anche tu, a volte sei tu a scrivere quelle cattiverie. L’amicizia è una collana che certe mattine puoi indossare e altri giorni lasci nell’armadio.
Anne dice: «Le ho chiesto quante persone aveva baciato, e lei ha detto tre: Jordy, Bas e te».
O magari quello viene dopo. Magari sono semplicemente al computer, dalle casse esce l’insulsa musica da ascensore dei Sims. Sto arredando una casa per Tony, che porta una collana d’oro ed è timido. Gli metto un flipper in cucina.
Mio fratello più piccolo torna a casa. Il suo borsone da calcio sa di fili d’erba strappati, deodorante per adolescenti e sudore stantio. Lo appoggia vicino a me.
«I ragazzi della squadra dicono che sei lesbica».
Lo guardo corrugando la fronte.
«Che cavolate» dico.
&
Alla nascita, un pesce piatto è come un pesce qualsiasi: un corpo ovale con due pinne e una coda, la bocca sulla parte anteriore della testa, un occhio su ciascun lato. Quando entra nella pubertà, gli occhi cambiano posizione. Mentre le ossa si spostano per renderlo più piatto, l’occhio sinistro si muove verso il lato destro. In un paio di giorni la pelle cambia colore: il lato di sotto è bianco, il lato di sopra è color sabbia, granulare, per mimetizzarsi alla perfezione nell’ambiente. Giace sul fondo del mare, irriconoscibile sulla sabbia. Gli occhi sono due sassolini neri che adesso vedono tutto in modo diverso.
&
Compongo una fila con i fiammiferi mettendo le capocchie annerite verso l’alto e verso il basso, alternate. Dondolo i piedi sul tavolo e tamburello con le dita sul legno per non dover battere sulla tastiera.
«Cosa avrei dovuto fare?»
Avresti potuto corrugare la fronte. Fare appello al tuo diritto alla privacy. Avresti potuto inventarti qualcun altro. Chiudere la chat e dire che Internet era saltato. Sarebbero potuti entrare i tuoi genitori. Avresti potuto fare i compiti. Rifiutarti di rispondere. Avresti potuto dire “due”. Fare violenza a quella parte di te, zittirla, tapparti la bocca con la forza. Con un pugno. No, avresti potuto dire: non sta succedendo davvero. No, avresti potuto dire a te stessa: tu non esisti. Avresti potuto tenere la bocca chiusa e sorridere.
&
La BBC ha ricostruito un salotto in un acquario marino: mattonelle bianche e nere, carta da parati a strisce e una chaise longue cosparsa di puntini. Rappresenta una sfida per le seppie: maestre della mimetizzazione in grado di cambiare non solo colore ma anche struttura. La seppia allunga le gobbe o pinne quando l’ambiente lo richiede e assume l’aspetto di un mazzetto di alghe, un pezzo di corallo, un fondale sabbioso o una roccia con sopra degli anemoni.
La seppia si distende per terra, diventa bianca e nera e prova diverse fantasie: un tappeto zebrato, o un triangolo bianco sul dorso. Continua a cercare e vede che il posto dove si mimetizza più facilmente è la chaise longue. Il suo lato superiore si trasforma in un motivo a fiorellini.
Non si tratta di un esercizio innocente: la seppia si adatta per poter colpire. Scivola invisibile sul fondale marino e soffia sulla sabbia. Cattura gli animaletti spaventati con uno dei suoi veloci tentacoli e li fa sparire nel muso a forma di becco.
&
Mentre percorro il grande atrio, con in spalla lo zaino blu Kipling pieno, mi vengono incontro uno dopo l’altro: se è vero, se ho davvero, che hanno sentito dire, se forse io – e li zittisco tutti. Racconto quello che è successo: che lei ha cominciato a baciarmi, dal nulla, e ha tentato addirittura di farmi un ditalino, mentre era proprio l’ultima cosa che avrei voluto. Che non l’avevo detto a nessuno perché non volevo che la prendessero in giro, ma adesso ero costretta a mettere un po’ di cose in chiaro. L’unica lesbica in quella scuola era lei. Io non avevo mai chiesto di fare niente.
Non è che io sia popolare, ma ho più amici di Lisanne, e prima dell’inizio della pausa pranzo tutti sanno la storia. Prendo un KitKat Chunky dal distributore, butto i miei panini nel cestino dell’immondizia e racconto tutto ancora una volta. Finché il mio pubblico è interessato, io metto in scena il monologo.
«Non voglio sembrare stronza» dico. «Per me non c’è proprio niente di male a essere lesbica, e non è nemmeno un problema se lei ci ha provato con me. Ma che vada a raccontarlo in giro come se fosse stato reciproco... non è vero, tutto qui».
&
La vergogna è più grande e insidiosa di quello che mi aspettavo. Non si esprime con occhi bassi e guance rosse o un balbettio, ma con formulazioni precipitose — «mi dispiace se hai l’impressione che» — e con l’intreccio di storie che tiene insieme. Mi vergogno per quello che è successo con Lisanne, e mi vergogno per quello che ho fatto a Lisanne, e mi vergogno perché lei me l’ha lasciato fare, e mi vergogno per quello che sono diventata, e per come ho fatto diventare Lisanne.
Sei mesi dopo viene a scuola con dei cerotti ai polsi. Sussurri, fruscii di colli che si girano di colpo nelle giacche a vento, e poi le risate quando qualcuno la blocca nel corridoio, stacca il cerotto e tutti vedono che sotto non c’è niente. Pelle bianca e intatta.
E io che mi ricordo ancora quanto era morbida contro la mia pancia.
&
Ogni ricordo è ambientato nel grande atrio della mia scuola superiore, un edificio che non esiste più. Mi sogno quell’atrio. Le piastrelle giallo verdastro sulle pareti. Non devo fare test, non ci sono materie che devo avere studiato. Sono fuori posto. Perché sono qui, allora? Fisso l’orario e non so dove devo andare. L’atrio è di pietra, ogni suono si lascia dietro un’eco. Le piastrelle, gli attaccapanni, il punto in cui confluiscono quattro corridoi, in modo che da ogni direzione possa arrivare uno spettatore, qualcuno che passando mi guardi e dica: è stata la prima ragazza che hai baciato e l’hai fatta passare per una bugiarda.
Ripenso al passato e mi vedo scompormi in tante goccioline che si sollevano e cominciano a girare l’una intorno all’altra, e io mi muovo nella memoria, sul linoleum verde del pavimento della palestra, dove sono già tracciati i contorni dei campi da calcio, pallacanestro, pallavolo, badminton e hockey, ma le linee dentro le quali devono entrare i ragazzi rimangono invisibili. Sento il bruciore delle sbucciature che ci procuriamo giocando a palla avvelenata, e comincio a ruotare così veloce che divento magnetica, proprio come la Terra, attiro verso di me tutta la storia e il mondo si tira indietro – questo non ti riguarda, è al di fuori di te – ma tutto scomparirà nella mia bocca che continua a ripetere la stessa frase: «Per me non c’è proprio niente di male a essere lesbica», sollevo le braccia e apro un varco nel mare e guardo: ecco il pesce piatto, che lotta per respirare.