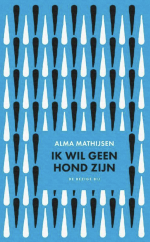Ci sono mondi interi sotto la nostra pelle. Almeno, se posso fidarmi delle illustrazioni. A volte non ne sono sicura. Mi afferro la clavicola, che sporge all’infuori se sollevo le spalle. Lo faccio spesso. La clavicola è un osso forte, ma sottile. Potrei romperla. Magari non a mani nude, ma se ci sbatto contro qualcosa di pesante, quella scultura di pietra massiccia per esempio, si rompe di sicuro. Non serve molto per finire male. Basta mandare qualcosa di traverso una sola volta ed è fatta. Dove sono finiti i pezzi che si infilano nel buco sbagliato?
Oltre alle tonsille che mi penzolano in fondo alla bocca, non vedo niente.
Sono stesa sul divano con il portatile caldo sulla pancia, troppo caldo, veramente, e vedo le mie dita battere sui tasti, ma chi dice che sono le mie dita? Se mi guardo le mani adesso, mi sembrano troppo lontane dal corpo. Un metro e mezzo più in là, direi. Ma le mie braccia non sono così lunghe. Mi tocco il sopracciglio con la mano destra. Ci riesco. Ho superato senza fatica una distanza di un metro e mezzo, se non di più. Ho un braccio elastico?
E mentre penso a tutte queste cose, un’altra parte di me osserva distaccata e dice: «Ecco, adesso sì che sei andata del tutto fuori di testa, non negarlo».
Guardati intorno e dimmi ancora una volta che è uno squilibrio chimico nel cervello. Guarda le felci che diventano marroni e si arricciano all’ennesima ondata di calore; i bombi che si ammalano per l’insetticida ancora nel terreno dopo quarant’anni; i polli che facciamo scorrere in fabbrica appesi a testa in giù a dei cavi, come un fenomeno da circo; la gente in tuta bianca che gli taglia la gola con gesti di routine; quelli che si nascondono in cantina quando sentono di nuovo i missili, quelli che scendono in strada con cartelli ritagliati da vecchi scatoloni: non dimenticate che usano carri armati, elicotteri, soldati e fucili – non contro dei narcotrafficanti, ma contro la loro gente; quelli che gridano: «È mia figlia! Mia figlia!» al poliziotto nel blindato, che continua ad avanzare come se non avesse sentito niente.
All’improvviso il computer sulla mia pancia emette un ronzio. Dal colpo di stato di tre mesi fa, l’esercito birmano ha assassinato più di settecento cittadini. Durante le proteste in Colombia, trentasette manifestanti sono stati uccisi dalla polizia nel giro di due settimane. È il 9 maggio 2021. In Israele celebrano il Giorno di Gerusalemme, il che significa che gridano slogan anti-arabi per le strade e prendono d’assalto una moschea. «Oggi ha fatto bel tempo» dice il sindaco di Lampedusa, dove arrivano oltre 1.400 migranti in un giorno solo. Tutti entrano in camera mia dallo schermo. Non c’è più neanche una sedia libera. La distanza tra quello che so e quello che posso toccare è troppo grande.
Da adolescente usavo solo pantaloni di poliestere in tinte pastello: verde chiaro, celeste, rosa pallido. Nel momento in cui ho cominciato a perdere sangue, ho dovuto fare attenzione. È stato il segreto a fare di me una donna. Se si fosse visto, sarei diventata un mostro. Rovistando negli armadietti del bagno ho trovato una confezione di assorbenti interni di mia madre, formato Super. Questa sì che era roba seria. Non i miei Mini infantili, con il motivo a fiorellini sulla plastica.
«Quelli non sono per te» ha detto mia madre. «Sono per donne adulte, che hanno già avuto figli.»
Non capiva che avevo qualcosa di sconcio che dovevo nascondere a tutti i costi. Ho cominciato a rubare i Super, uno alla volta, e a conservarli per i momenti importanti: l’ora di ginnastica, il campo estivo, le giornate in piscina con le amiche. Non credo che lei se ne accorgesse. Finché una sera mi sono seduta sul water, ho attaccato il salvaslip sulle mutande e ho tirato la cordicella. Non è successo niente. Ho tirato un’altra volta. Non si muoveva.
Qualcosa dentro di me si era bloccato e non voleva più rilassarsi.
Mia madre ha steso un asciugamano sulle piastrelle del pavimento. Io mi ci sono messa sopra di schiena, con le piante dei piedi appoggiate per terra e le ginocchia sollevate e divaricate. Ero stesa lì proprio come lei quattordici anni prima, quando un altro le aveva guardato tra le gambe per controllare se si intravedeva già la mia testa. Adesso il mio occipite toccava il pavimento grigio e freddo. Mia madre mi ha teso la pelle premendo delicatamente verso i lati e verso l’alto, ma niente.
Qualche minuto dopo ero seduta in macchina sul sedile davanti, con addosso dei pantaloni della tuta larghi, in viaggio verso l’ospedale. A ogni dissuasore di velocità gemevo per il dolore. Nella sala d’aspetto del pronto soccorso ho accavallato le gambe. Nessuno doveva vedere cosa stava succedendo dentro di me. Ho sfogliato il mucchietto di riviste femminili spiegazzate. Diete, vestiti, cantanti pop, posizioni sessuali.
«Signora?»
Il dottore era giovane e bello, e aveva molta comprensione per la situazione delicata nella quale mi trovavo. Un po’ troppa comprensione.
«Devi dire se preferisci che venga un medico donna» ha detto. «Sei sicura che sei pronta? Fa male? Dobbiamo fare una pausa?»
Io volevo solo che tirasse fuori quell’affare. Certe volte mi sembra che sia ancora così. Che dentro di me ci sia qualcosa che deve uscire.
«Ieri, con El Gordo in palestra, ho avuto di nuovo quella sensazione» dice J Balvin. L’artista di reggaeton viene seguito per una settimana, per un documentario. «E ho pensato: maledizione, di nuovo questo schifo. Come se non ci fossi. Non sei nel tuo corpo. Fuori va tutto bene, ma nella tua testa no. Perché devo sentirmi così da schifo?»
Parla apertamente della sua gioventù, dei suoi demoni e del totale disinteresse per la politica.
«Non sono di destra, non sono di sinistra, vado dritto e basta» dice facendo involontariamente l’eco a una famigerata politica olandese. La politica non gli interessa, ripete. Come se il dolore gli nascesse da solo nella testa e non lo respirasse quando cammina per la strada, dove l’asfalto è ancora umido per gli idranti e l’aria è pervasa dal sudore dei manifestanti.
«Esquina a esquina, de ahí nos vamos / el mundo es grande, pero lo tengo en mis manos» dice J Balvin. Alzo la musica così tanto che non sento più nient’altro, chiudo gli occhi e scuoto il bacino avanti e indietro.
A metà giornata, quando il manto grigio mi cade sugli occhi e gli animaletti che mi fanno il solletico nella cassa toracica cominciano ad agitarsi, c’è un unico modo per arrivare in fondo: il dem bow. Il bum-ci bum-ci caratteristico del reggaeton. Il ritmo è arrivato dall’Africa a Panama e Puerto Rico, portato da schiavi e immigrati, e adesso dei mulatti come J Balvin ci fanno su miliardi. Non bisogna pensarci troppo sopra; è un labirinto di rapporti di potere da cui non si viene più fuori. Non fai a tempo a rendertene conto e sei di nuovo incastrata.
È come con l’influenza: finché stai bene non riesci quasi a immaginare come ci si sente quando si è malati, ma appena te la becchi di nuovo e ti ritrovi a letto con la nausea e la febbre alta senza riuscire a muovere neanche un muscolo, pensi: ah sì, cazzo. E non ti ricordi più com’era non avere dolore. La depressione viene descritta come una nebbia, uno stato d’animo, una sensazione che ti precipita addosso ed eclissa tutte le altre emozioni. Sì, quel buco nero. Sì, il vuoto. Come se fossi seppellita sotto terra, aspettando nel freddo umido di avere la forza per risollevarti a tentoni dall’erba.
Ho in mano un caffè del distributore e sono seduta in un banco in seconda fila nell’aula. Di fianco a me c’è un astuccio nero con la cerniera chiusa. Davanti a me, su un giornale aperto, una talpa morta. Le zampe scavatrici pendono inerti sopra l’articolo sulla Banca europea. Di colpo si accende il proiettore.
«Bene» dice il signor Vos. «Per cominciare, prendete tutti subito lo scalpello, e poi tagliate con cautela dal puntino sotto il collo, sopra la cassa toracica, e arrivate giù fino all’ano. Attenzione: dovete fare un po’ di pressione, la pelle è dura, ma se premete troppo tagliate la pancia, toccate gli intestini e viene fuori un pastrocchio.»
Attraverso i guanti di lattice sento quanto è freddo l’animaletto, sotto la sua pelliccia
soffice. Vorrei appoggiarci la faccia, come con i miei gatti. Ogni volta che vado avanti di un paio di centimetri con lo scalpello, devo buttare della segatura nella ferita. Assorbe umidità; sangue e muco.
Premo troppo, naturalmente. Trapasso la membrana dell’addome e le interiora schizzano fuori dal taglietto. Nessun problema, basta continuare a fare leva. Tentare di tirarlo fuori dalla sua giacca. Tagliare le zampine dalle anche, con una forbice. Lo scheletro sembra una fascetta stringicavo: saldo, indistruttibile, finché di colpo si arrende. Quando arrivo al cranio devo prendere di nuovo le forbici, per staccare attentamente la pelle ai lati degli occhi.
Estraggo il cervello con una pinzetta. Fisso il controsoffitto, cerco di respirare calma. Non riesco a guardare la poltiglia rosa chiaro che esce fuori da dietro. Al pomeriggio nell’aula si sente un odore. Non di putrefazione, non di carne. Ha un che di sterile, con un sentore di ferita vecchia. Questo è l’odore della morte, penso tra me e me, prendo dalla vaschetta con le sostanze chimiche la pelle staccata e la rovescio. Mi siedo sullo sgabello della spazzolatrice, premo il pedale con un piede e tengo l’interno della talpa contro la spazzola che gira con accanimento.
«Molto bene» dice il signor Vos. «Assicurati di rimuovere tutta la carne, anche in quegli angolini. Guarda lì, vicino alla zampetta, ecco, proprio lì.»
Un paio di settimane dopo quella notte al pronto soccorso sono dovuta tornare in ospedale.
Avevo appuntamento con un ginecologo. Il mio imene era troppo teso. Dovevano inciderlo, altrimenti mi avrebbe causato problemi. Non mi ha fatto molto male. Alla fine, ho potuto scegliere un regalo al negozio di giocattoli. Ho scelto un piccolo mulino a vento rosso, che ho messo sul davanzale davanti alla finestra aperta. Per anni ho detto in giro che ero stata sverginata in ospedale, con una forbice. Facilissimo, ridevo. Non dovevo scegliere quello giusto per strapparmi, era già stato organizzato tutto. In maniera clinica e pulita. Come tanti altri artisti, J Balvin si è diviso in due. Da un lato c’è la star mondiale, una personalità di successo, circondato da donne, con i vestiti più costosi, su moto e motoscafi – e dall’altro lato c’è José, un uomo cupo che a volte non si alza dal letto per giorni. Non hanno molto in comune. La loro voce è uguale, e abitano lo stesso corpo. La stessa testa.
Non è così facile uccidere qualcosa e fare in modo che resti morto. In men che non si dica arrivano le larve, inizia a marcire, cresce e continua a respirare. La talpa deve dare l’idea di essere appena sbucata fuori da un cumulo di terra, ma deve essere pulita come una bambola di plastica. Ha bisogno di un interno nuovo, di lana di legno e fil di ferro. Ripassi il contorno con la matita, per avere le misure giuste. Premi il fil di ferro con l’argilla nel cranio, e poi stringi il filo alla sagoma. Ci fai passare intorno la pelle come una federa attillata. Chiudi il buco cucendolo con il filo interdentale. Quando l’animale è imbalsamato del tutto, fissi con degli aghi le parti staccate: le mani, i piedi, la coda. Tutto quello che si secca, si restringe.
Accarezzo il pelo vellutato della mia talpa. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Oggi, il mio braccio è della lunghezza giusta. Il dem bow vibra dagli auricolari che ho attorno al collo. ¿Y dónde está mi gente?