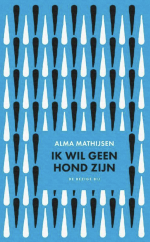Insomma, ci vuole un po’ di tempo perché si formi del calcare su un soffione della doccia come questo. Adesso che me ne sto appeso per metà nel corridoio e metà sulle scale, con il tubo della doccia avvolto attorno al collo, penso: se i miei amici avessero visto il bagno, avrebbero capito. Se fossero saliti tutti di sopra anche solo una volta, come Emma quel pomeriggio, avrebbero visto il soffione della doccia, avrebbero aperto e chiuso il rubinetto, avrebbero notato la parete di vetro della doccia sporca di calcare, i miei peli della barba rasati frettolosamente e abbandonati nel lavandino, e avrebbero capito: quel ragazzo è partito del tutto, dobbiamo salvarlo. Il bagno è stato il culmine, ma insomma, c’erano anche altri segnali d’allarme, naturalmente: non portavo più jeans da un pezzo; non avevo più le tempie ben sistemate, l’orlo dei capelli sulla nuca non era più ben delineato e accorciato con cura, ma era uno straterello confuso che spariva piano sotto il colletto. Ogni tanto avevo una breve ripresa, di solito dopo che Emma era passata da sola a casa mia e mi aveva fatto capire scherzando che sembravo un barbone e che una volta non era assolutamente così, quando stavo tanto bene con la testa sempre in ordine; allora tiravo fuori il rasoio dal cassetto della cucina – dove l’avevo messo qualche mese prima, perché riportarlo in bagno era un compito troppo difficile per me – ed eliminavo furiosamente un paio di millimetri. E neanche quello era bello a vedersi, ma era meglio di niente. Erano qualcosa di cui essere soddisfatti, quei pezzetti di capelli disordinati. Adesso mi solleticano il collo, sotto il bordo di plastica del tubo, ma non riesco a muovermi. Posso pure pensare che voglio sollevare il braccio, ma farlo davvero mi sembra un compito impossibile.
Ma va bene, i miei amici hanno preferito non cogliere i segnali, credo io. Da quelle rientranze disordinate sulla mia nuca avrebbero potuto capire: il nostro amico sta sempre peggio. Molti di loro all’inizio hanno solo pensato: sarà questo inverno così buio, e infatti, quell’inverno è stato davvero terribilmente buio. Il sole non si è visto per quattro settimane di seguito. Ha piovuto senza sosta. Io sono tornato lentamente, come ogni inverno, al mio corpo di adolescente di dieci anni prima e ho sentito un buco nero risucchiarmi con una forza enorme in un’oscurità profonda e riconoscibile. Restavo dentro più a lungo, mi dimenticavo di tirare le tende, bevevo troppo poca acqua, mi facevo la doccia meno di frequente, prendevo sempre più caffè per tenermi in piedi, non riuscivo più a far andare il riscaldamento perché dovevo sfiatarlo ma non trovavo da nessuna parte quella stupida chiave e non osavo chiedere a nessuno dei miei amici se me ne prestavano una (neanche a Emma, perché lei mi aiutava già troppo, pensavo), per cui mi aggiravo per la casa come un Inuit avvolto in coperte di pile.
Fuori, per strada, la gente andava in giro come zombie e per quello io sembravo adattarmi alla perfezione al quadro, solo che questa per me non era una stagione, ma una condizione normale in cui mi trovavo, tutto l’anno – e quell’inverno stavo toccando il fondo dell’abisso.
Questo corpo, posato sui primi gradini della scala come un triste ramo di salice, appeso al tubo della doccia che esce dal bagno e passa teso sul pianerottolo, è il corpo che mi porto dietro ormai da anni. Moscio, vuoto e irrigidito dal panico, perché non so più da dove cominciare.
A un certo punto, quando ho smesso di buttare nel cestino le vaschette delle lenti a contatto e ho iniziato ad ammucchiarle sul pavimento di piastrelle del bagno, mi ha assalito il pensiero che molti dei miei amici sembravano accettare che ormai ero solo una versione lenta e rammollita del tizio con cui una volta andavano a feste e festival, che offriva giri a un ritmo vertiginoso, raccontava barzellette divertentissime, indossava cappellini improbabili, si fregava i bicchieri più belli dal bar per usarli a casa – forse era quello, conoscevano qualcuno che non c’era più. Adesso c’era un ragazzo polveroso e sbiadito, che quando venivano a trovarlo buttava giù con poco entusiasmo una birra dopo l’altra sulla sua poltrona moderna con lo schienale ricurvo. Non c’era più gusto, niente scherzi, poche battute, c’erano soprattutto molti silenzi imbarazzanti e qualche mia pessima battuta da cui trapelava che mi sentivo uno sfigato a pezzi. Per quante battute facessi, non sembravano cogliere nel segno con nessuno, rimanevano sospese in aria, da qualche parte sotto il soffitto, come vignette che non sapevano dove andare. Nel disagio del dolore o del possibile fallimento di un altro, presto mi sono reso conto che i miei amici non avevano più il coraggio di fare domande. Oppure se ne dimenticavano, perché avevano determinato per me una specie di status che poi non era più cambiato. Il mio status era il seguente: va già molto meglio che x anni fa. Non facevano che ripetersi quella frase: «va già molto meglio che due anni fa», «va già molto meglio che tre anni fa», e così via. Se il momento di verifica non si sposta e quel momento di verifica coincide con il pozzo più buio e profondo della tua vita, in confronto tutto è un miglioramento. In confronto, tutto quello che scivola solo un po’ via e non sfugge totalmente di mano non rappresenta un problema.
Quando sono passati tutti da me per il mio compleanno, in qualche momento della fine di quell’inverno da sfigato a pezzi, abbiamo parlato un po’ delle pastiglie di vitamina D e di quanto poco senso sembra avere il buttar giù tutta quella roba. Io tacevo, pensando: prendo quelle pastiglie ogni mattina, da anni ormai, più per l’idea che perché senta che mi servono a qualcosa, ma vabbé. Emma mi aveva detto che se hai la sensazione che qualcosa ti serva, devi sempre farlo, per quanto idiota possa sembrare. Potevo anche prendere un criceto per esempio, ha detto una volta, «o un pesce, o un cane, così non sei da solo, e vi tenete compagnia». Lei era l’unica che faceva suggerimenti e poneva domande.
«Anche noi siamo stanchi, a volte» hanno detto i miei amici, prendendo un sorso di birra e cercando di non fissare tutto il tempo gli scaffali impolverati della mia libreria. A volte passavano sere di fila stesi sul divano come stracci consumati a guardare l’ennesima serie tv, dicevano. A volte ordinavano anche loro cibo pronto o rimanevano senza mutande pulite. Poi hanno riso e uno di loro ha guardato i ciuffetti di capelli sul mio collo, che stavano dritti grazie all’ultimo spruzzo di gel out of bed look che avevo trovato quella mattina da qualche parte sotto il letto, in un vasetto appiccicoso.
«Certo, può essere» ho risposto io, «da voi, però, il soffione della doccia funziona ancora bene.»
Quando l’ho detto, mi hanno guardato tutti con un’aria sorpresa e insieme colpevole.
Avrei voluto dare una manata al tavolino e sputare e gridare che neanche io sapevo più che pesci pigliare, ma non l’ho fatto. Perché qualcuno avrebbe attaccato a parlare di aiuto professionale o di uno psichiatra e non ne avevo voglia – ci avevo già provato, ma quella donna mi aveva detto che ogni mattina, prima di alzarmi, dovevo provare a sentire «cosa volevo» e io ogni mattina non lo sapevo, per cui andavo fuori di testa. E così non ho fatto niente e ho guardato come un cane bastonato verso la stanza attigua della quale, con mio grande sconforto, avevo lasciato la porta aperta. Di colpo, vedere quell’ammasso di cartoni di pizza e casse di birra mi ha fatto venire la nausea, mi ha lasciato senza fiato e con le vertigini. Una sensazione simile a quella che ho adesso, con questo coso attorno al collo, anche se pensavo che sarebbe stato più veloce, che questo tubo mi avrebbe subito spedito all’altro mondo, che mi avrebbe spezzato subito il collo, invece no. Forse è colpa di questo tubo di plastica, forse è troppo scivoloso.
Emma sì che sapeva quello che volevo dire a proposito del soffione della doccia. Un pomeriggio si è presentata all’improvviso sulla porta di casa ed è filata dritta di sopra. Lì ha sfilato il soffione dal supporto e ha guardato i dischetti di calcare giallastro che si erano annidati nei morbidi anelli di gomma. Ha scrostato il calcare con le unghie, un dischetto dopo l’altro. Quando ha finito ha aperto il rubinetto della doccia e mi ha fatto vedere che l’acqua aveva ripreso a scorrere normalmente dal soffione. Mentre lo faceva mi è sembrato semplicissimo.
«Ti dà subito la sensazione di avere davvero fatto qualcosa, esattamente come pulire la porta della doccia con un panno, a volte è piacevole poterci guardare attraverso», ha detto sorridendo, e mi ha passato il soffione della doccia, perché ci dessi un’altra occhiata. «Puoi farti la doccia almeno per un paio di settimane senza pulire di nuovo. Si otturano un paio di buchi al massimo, e in teoria non c’è nessun problema. Puoi ancora lavarti i capelli, insaponarti le ascelle e pulire per bene la parete dopo la doccia. Bello, no? Hai un panno? Così lo facciamo subito.» Quel pomeriggio abbiamo pulito tutta la casa.
Dopo il mio compleanno, dopo che tutti sono usciti e io ho chiuso la porta, ho fatto come facevo sempre: ho finto di avere qualcosa da fare in casa, e poi mi sono mosso a carponi sul pavimento del salotto verso il davanzale. Ho aperto uno spiraglio della finestra facendo meno rumore possibile e li ho ascoltati parlare per la strada.
«Cosa vuoi farci, c’è gente che va avanti così per sempre.»
«Comunque la vita è la sua, ragazzi, non possiamo fare più di tanto.»
«Io sono contento ogni volta che vedo che è ancora vivo.»
«Magari lui sta bene così! Non ci hai mai pensato? Magari non vuole una ragazza e neanche tutte le cose che vogliamo noi, non può essere? Voglio dire, noi siamo sempre incasinatissimi. Magari è quello che facciamo noi che è assurdo.»
«Ah certo, lascia stare. Hai totalmente ragione. E ti ricordi com’era prima, no? Aveva il letto pieno di mozziconi di sigaretta, la stanza era piena di casse di birra vuote. Ha fatto grandi progressi.»
«Però, se la prossima volta è peggio, dobbiamo fare qualcosa, okay?»
«Certo, facciamo così. D’accordo.»
Anche prima dicevano cose di questo tipo, ma dopo il mio ultimo compleanno, un paio di mesi fa, di colpo mi sono sentito diverso. Mi sono sentito come un cane randagio che le persone guardano con simpatia quando è abbastanza lontano, ma al quale non si avvicinano per paura di beccarsi un morso. Mi sono messo a pancia in su, ho fissato il soffitto per un po’, poi mi sono alzato e ho buttato l’occhio sulle finestre impolverate: la luce dei lampioni metteva in risalto la sporcizia. Poi sono andato in cucina e ho guardato le scatole vuote di muesli croccante sul ripiano. Sono troppo stanco per mordere, ho pensato, veramente troppo stanco. Ma la vita non può davvero essere questa.
Da quando è passata Emma ho tenuto il conto. Potrà sembrare un’occupazione futile, ma ogni volta che pulivo quei singoli buchini da dove esce l’acqua, mi sentivo come quella sera dopo che avevamo messo in ordine insieme tutta la casa. Per un attimo ero un altro ragazzo in un altro corpo. Emma mi aveva addirittura convinto a mettermi un paio di jeans. Avevo paura di non entrarci più, invece mi andavano ancora bene. Lei aveva un’aria molto contenta quando ho infilato le gambe nei pantaloni come un pagliaccio, ho tirato su la cerniera e ho chiuso il bottone. «Ecco» ha detto soddisfatta, «sei tornato.» Il soffione della doccia mi preme da un po’ contro la guancia destra, da vicino vedo perfettamente che non si è più otturato neanche un buco.