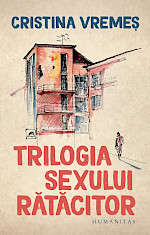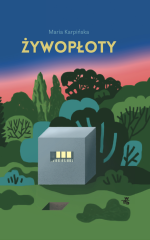In treno, nell’ultima tratta del viaggio, aveva visto attraverso il finestrino sudicio i margini del cielo. Si è alzato per guardare anche dall’altra parte del vagone e si è avvicinato all’uomo addormentato con il volto nascosto dietro la tenda e con la mano destra poggiata saldamente sopra la piccola borsa da viaggio, che stava sul sedile a fianco. Sì, anche dal suo finestrino la vista era uguale. Una coperta compatta, indaco, su un piano parallelo al campo esteso, pieno di vegetazione secca. E al suo margine, un azzurro chiaro e limpido, come un mare lontano, sospeso tra cielo e terra.
Da qualche parte, sopra la coperta indaco, c’era il sole.
Quando si è alzato, ha percepito d’un tratto l’agitazione del vagone, gli altri hanno avuto la sensazione che lui si preparasse a scendere, così hanno iniziato tutti come a un segnale a tirare giù i bagagli, a vestirsi, ad abbottonarsi.
Si è seduto al suo posto e ha controllato il telefono. Tre chiamate perse di suo padre e un messaggio vocale:
«Bogdan, quello che volevo chiederti…»
Gli chiedeva di nuovo cento lei in prestito, la tassa per una gara di pesca.
Il cardiologo gli aveva suggerito di andare a pesca.
Anche a casa, in cortile, c’era aria pulita, ma non per l’aria glielo aveva detto, quanto per la tranquillità.
Il cardiologo non aveva idea di quanta tranquillità ci fosse da loro.
Bogdan aveva detto ai suoi che sarebbe passato da loro tornando da Bucarest. Abitavano molto vicino alla stazione. Doveva installare di nuovo sul telefono del padre l’applicazione per la videocamera di sorveglianza del cortile.
Quando è sceso dal treno, ha cercato di nuovo i margini del cielo, ma non li ha più visti, e si è sentito d’un tratto oppresso, schiacciato dalla coperta ora nera, che sembrava non superasse il tetto della stazione.
Si è incamminato per il quartiere in cui aveva trascorso l’infanzia ed è passato vicino alla fabbrica di latte abbandonata da cui usciva sempre un aroma nauseante di vaniglia, visto che là, non si sa a quale delle finestre opache, dietro quale porta arrugginita, da qualche parte in quel rudere, si trovava un “laboratorio” di pasticceria. Prova ne era quell’eterno odore dolce e l’altrettanto eterno branco di cani, nutriti probabilmente tutta la loro vita a biscotti. Un branco troppo numeroso per fare da guardia solo a un laboratorio di dolci.
Bogdan era stato a Bucarest a una fiera di automezzi, a vedere dei veicoli per il trasporto dei maiali vivi. Era veterinario in una fattoria della regione e voleva da qualche anno staccarsi, come diceva lui, cioè avviare qualcosa in proprio. Avrebbe voluto gestire una piccola attività in cui non avrebbe più lavorato direttamente con gli animali e per cui avrebbe piuttosto utilizzato i dettagli amministrativi colti al volo nei dodici anni di lavoro alla fattoria, una delle più grandi del paese.
La situazione era, però, incerta a causa della peste suina che aveva causato un grande panico, dagli allevatori fino ai paesani che allevavano qualche maiale in cortile e che ora sacrificavano presi dalla disperazione.
E così questa fiera, che aveva atteso per circa quattro mesi e a cui era andato per inerzia, ora gli sembrava uno scherzo. La sua presenza lì era uno scherzo. Anche in un mondo senza malattie, sarebbe comunque stato impossibile ottenere un prestito per delle macchine.
Era stanco e turbato e le preoccupazioni di suo padre riguardo i laghetti da pesca erano irritanti. Non chiedeva molto il vecchio, solo un centinaio di lei di tanto in tanto, che gli chiedeva sempre di nascosto, senza che sua madre lo sapesse, chissà per quale ragione.
Quando è arrivato di fronte alla porta, Bogdan si è reso conto di non avere più la loro chiave all’anello. Si è ricordato di quando l’ha tolta, ma non sapeva più cosa ne avesse fatto. Ha suonato al campanello, ha guardato attraverso la recinzione e ha subito visto sua madre fiondarsi dalla porta e correre, con la vestaglia pesante di peluche, che metteva sempre per uscire, sbottonata.
«Non correre, che mi stressi!», ha gridato lui verso la porta di ferro verde.
Sua madre gli ha aperto contenta.
«Vi siete dimenticati che venivo?»
«Ma no, come dimenticarselo!», ha risposto lei.
«Non ti ho già detto di non correre più così? Posso aspettare un minuto in più, mica c’è un incendio.»
«E la chiave? Non ce l’hai?»
«L’ho dimenticata», ha detto.
Sua madre l’ha abbracciato e l’ha stretto fortissimo e ha chiuso gli occhi. Era piccoletta e gli arrivava solo al petto, lui ha abbassato la testa e ha guardato i suoi capelli bianchi e radi, che emanavano un profumo fresco di shampoo.
«Basta, lasciami andare», le ha detto.
«Perché?» si è sentita la voce della madre soffocata nel suo cappotto.
Bogdan ha sorriso e l’ha lasciata così ancora un secondo.
Non era più passato a trovarli da tanto, anche se viveva in città. Suo padre a volte andava a trovarlo, ma sua madre non era mai venuta negli ultimi due anni, da quando si era sposato con Alina.
«Dov’è papà?» ha chiesto lui. Non posso fermarmi molto.
«Credo sia alla palestra, da Mircea», ha risposto lei.
*
Con indosso una tuta spessa, con la giacca e il berretto in testa, Grigore si è seduto sulla sua panchina preferita, che guarda il Danubio. Tirava vento e gli piaceva stare con gli occhi chiusi e ascoltare lo scricchiolio dei pontili. Da lontano si sentivano i rumori metallici del cantiere navale. Si sentivano anche i gabbiani. E si sentivano anche le onde.
Lì si sentiva tutto alla perfezione, solo su quella panchina. Era l’ultima della fila sulla riva, le altre andavano in su, a monte, fino alla piscina abbandonata, in una zona con i tavolini di alcuni locali all'aperto dove scendeva comunque anche qualcosa della frenesia della città. C’erano ancora ragazzi sui pattini e persone che portavano a passeggio il cane.
Veniva ogni settimana da Mircea, l’amico di una vita, che era allenatore di boxe in una palestra vicino alla riva. Faceva volontariato con alcuni bambini.
Mircea aveva sessantotto anni. Grigore ne stava per compiere settanta.
Se c’era vento – e lì, sull’argine, la maggior parte delle volte c’era un vento meraviglioso –, Grigore scendeva a valle sulla stradina di ghiaia, verso l’edificio della stazione fluviale, che era stato a lungo un rudere, poi, ristrutturato, era diventato un casinò, mentre ora era chiuso col lucchetto. Passava vicino a una croce votiva decorata con fiori di plastica, davanti alla quale si trovava una fontanella che, stranamente, funzionava sempre. Se non c’era nessuno nei paraggi, si faceva un ampio segno della croce e beveva dalla fontanella, come se l’acqua fosse benedetta.
Grigore in vecchiaia era schivo con le persone.
Aveva una moltitudine di gesti che compiva di nascosto. Erano cose piccole e insignificanti e proprio per quello gli sembrava facile nasconderle, ma se ne erano accumulate parecchie.
Non voleva si pensasse che si era rammollito.
Era stato coraggioso in gioventù, ma il suo coraggio è stato limitato. Si è consumato in fretta.
Non era credente, ma sentiva una certa emozione quando passava vicino a una croce votiva. Una sorta di rispetto verso qualcosa più grande di lui, una forza che un bel giorno gli si mostrerà come un vortice e lo trascinerà in cielo. Così s’immaginava la morte. Come un innalzamento tempestoso e pieno di paure, ma un innalzamento, non un sotterramento. Una polverizzazione nella luce, non una decomposizione nelle tenebre.
Ogni tanto sentiva un ronzio nelle orecchie. A volte solo nell’orecchio destro, a volte in entrambe. Lo aveva avuto per tutta la vita, lo abbandonava e tornava periodicamente. Lo sentiva soprattutto la sera, prima di coricarsi, quando si metteva a letto e spegneva la luce e c’era così tanto silenzio che il ronzio gli inondava la testa. La maggior parte delle volte era come un monotono mormorio industriale, come un coro di macchinari grandi e pesanti che lavorano per conto proprio. Altre volte era come lo scorrere di un fiume potente, qualcosa di violento e pericoloso, che aveva la forza di provocare un danno irreparabile. Di distruggere qualcosa nel suo cranio.
Il rumore gli era tornato da qualche settimana e quanto più ci pensava, tanto più era potente. Si svegliava, d’istinto, coprendosi le orecchie, con un cuscino o con le mani, ma sapeva che non viene dall’esterno e che, comprimendosi la testa, non fa altro che stringere la corda attorno al collo di quel mostro che urlava ancora più forte.
Non ha mai fatto una visita medica.
C’erano problemi più grandi al mondo.
Aveva preso molti pugni in testa in gioventù, era impossibile che non gli rimanesse nulla.
Lì, sulla sponda del Danubio, c’era pace e allo stesso tempo c’era abbastanza rumore da non sentire più l’interno della sua testa e questo gli piaceva.
«Papà, perché sei uscito di casa, non ti ho detto che passavo?» gli ha chiesto Bogdan.
«Non ricordavo più a che ora arrivavi esattamente», gli ha detto nel panico. «Aspettami. Aspettami!»
«Aspetta, non correre», gli ha detto il figlio. «Ti lascio i soldi lì, sai tu dove. Alla cuccia del cane. E vengo un’altra volta per il telefono. Sei sul traghetto, dove sei?»
«C’è vento», ha detto Grigore. «Perché non mi aspetti?» ha chiesto deluso.
«Papà, sono stanco.»
Grigore non ha più detto nulla.
«Mi credi che sono stanco?» ha chiesto Bogdan.
E Grigore ha detto che sì, gli crede.
*
Strada Traian scendeva da piazza Traian fino al Danubio. Misurava qualche centinaio di metri, non era una via lunga, ma appariva molto diversa da un’estremità all’altra. Iniziava in centro, e nell'estremità superiore c’erano degli edifici alti e belli, che erano stati ristrutturati di recente, perciò apparivano puliti. Solo che, in questa città, i restauri non durano a lungo, l’imbiancatura inizia a scrostarsi in fretta. Quando avranno ristrutturato tutta la strada, probabilmente nella parte alta le facciate inizieranno a sgretolarsi di nuovo. Qui la rovina non si lascia mascherare.
Gli edifici in alto erano appartenuti ad alcune istituzioni che non esistevano più e, anche se avevano un bell’aspetto, erano vuoti. Seguiva un tratto con alcuni edifici decenti, poi, abbastanza velocemente, entravi alla zona decrepita della via, con case fatiscenti, inagibili, e aree piene di rifiuti. Alla fine di tutto, un edificio alto, socialista, abbandonato anche quello, squilibrava completamente il paesaggio.
Dopo, seguiva una croce votiva con una fontanella e, un po’ più a valle, il Danubio, che scorreva sempre a una velocità vertiginosa, da destra a sinistra, anche se dal modo in cui leggevi quello spazio, ti saresti aspettato che scorresse al contrario.
Il Danubio visto dopo un periodo di lontananza riusciva a capovolgere per qualche secondo la tua percezione dello spazio. Scorreva al contrario. E scorreva incredibilmente veloce per quel luogo immobile in cui ti si svelava.
La palestra di boxe dove Mircea teneva le sue lezioni con i bambini era in questa zona degradata della strada, al piano terra di una casa a due piani. Proprio sopra la porta rinforzata da alcune sbarre c’era un balcone che sembrava una torta tagliata, con tutti gli strati a vista, da questo uscivano mattoni e dai mattoni cadeva una polvere rossiccia. Nel pavimento del balcone cresceva un albero sottile e giovane e, anche se lo spazio sopra la sala era abitato, nessuno aveva ritenuto opportuno estirpare l’alberello, che sembrava un’albizia.
Tutte le volte che veniva a trovare Mircea, Valer scendeva dall’autobus 4 alla fermata di fronte all’hotel Traian, poi si incamminava su strada Traian. Sentiva già la corrente prodotta dal fiume ancora invisibile e guardando in giù tutta la strada sognava a occhi aperti come sarebbe stato se un giorno questa strada avesse portato il suo nome.
Desiderava davvero molto che una strada in città portasse il suo nome. Se l’era più che meritata.
Guardava le targhe sugli edifici e non doveva nemmeno chiudere gli occhi per vedere la scritta: “Valer Pataki, pugile”. Oppure: “Valer Pataki, pugile campione”. Oppure: “Valer Pataki (1952- ), campione di boxe”. No, senza l’anno di nascita, per non creare aspettativa sull’anno della morte. L’angelo nero non va invocato, pensava, non dobbiamo ricordarglielo.
Ora, però, scendendo su strada Traian verso la palestra, gli si stava piantando in testa una nuova idea: “Valer Pataki, pugile e scrittore”.
Il suo libro di memorie era quasi pronto. Di lì a una settimana doveva andare in tipografia a ritirare i suoi pacchi.
Voleva un lancio grandioso, in un grande ristorante della città, dove avrebbe invitato altri ex pugili della sua generazione da tutto il Paese, avrebbe dato autografi, chiamato la stampa e organizzato un evento dimostrativo con i giovani. Per questo doveva parlare con Mircea.
Questo lancio era diventato da qualche anno il suo più grande sogno ed era sul punto di realizzarsi. Aveva venduto un terreno in campagna per questo.