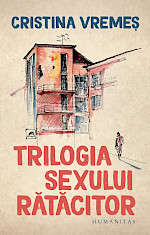Basta. Ho raccolto le mie cose, il completo nel portabiti, il calzascarpe e ho consegnato la chiave. Fino a casa ci vogliono sei ore di guida, ma la strada è più breve al ritorno. Abbasso il finestrino e, con la testa fuori, percorro sempre più velocemente il viale principale della città. Rinfrescata dalla sera e dalla velocità, l’aria mi rade le guance e mi ricorda l’asprezza di una spugnetta struccante. Ho una pelle sensibile e non sopporto facilmente il trattamento di cui sono oggetto i presentatori televisivi per non apparire come una luna piena sullo schermo – che gli si applichi sul viso uno strato di cipria, da raschiare poi con quelle spugnette piene di pelucchi. Quando non ho più sopportato la sensazione, ho chiuso il finestrino e ho premuto più forte l’acceleratore. La strada è libera. Potevo partire all’alba e guidare sbronzo o rimanere ancora una notte, ma a quel punto sarei mancato al lavoro lunedì, e questa sarebbe stata un’anteprima indesiderata, visto quanto ho sgobbato per diventare presentatore, e visto quanto è facile essere sostituito con un collega o una collega che trascorre pure le ferie in studio, così magari ti fanno un primo piano. Che io mi sia preso un weekend libero dev’essergli sembrato un atto di arroganza e davvero mi sento in colpa per essere scappato due giorni. Cosa sono diventato! Oppure sono stato così dai tempi della scuola, quando mi si stringeva lo stomaco al pensiero di marinare una lezione e invidiavo Marcus, il bullo della classe, che non aveva alcuna nausea a scomparire per giorni. Ed ecco che pure lui è arrivato. Vicesindaco e uomo sposato. Già, mi son detto e ho premuto il pedale fino in fondo. Quel che è certo è che tutto questo diventerebbe una notizia se per strada mi schiantassi contro un parapetto. Sento pure la direttrice del notiziario chiedere in redazione come ogni volta che si annuncia un incidente: «Carogne ce ne sono?» «Sì, una.» «Solo una? OK, mettila nel notiziario delle 17, nel mezzo.» «Sì, ma è un nostro collega.» «Allora mettila alle 19, in apertura.» Ed ecco come diventerei notizia, presentata dal mio sostituto, che a stento riuscirebbe a trattenere un sorriso compiaciuto. Che io abbia partecipato al raduno degli ex alunni e che abbia rivisto Marcus, è un fatto meno interessante per la mia direttrice e per il largo pubblico di quanto lo sia la notizia di un uomo morso da un cane.
Il raduno ha avuto luogo sabato, alle 10 del mattino. Venerdì sera, dopo la trasmissione, sono passato dallo struccaggio e sono partito in piena notte. Verso le 5 del mattino ero nella città in cui sono nato e ho trascorso la mia adolescenza. Ho percorso il viale con i castagni che divide in due la località, poiché di giorno è un segmento trafficato di strada europea, che semmai taglia la comunità più che unirla attraverso i pochi attraversamenti, e ho accostato all’unico hotel che si merita le sue tre stelle. Sono salito in camera, ho fatto una doccia, ho acceso la tv e mi sono addormentato all’istante.
Due ore dopo ero in piedi e mi sono detto di passare anche da mia madre, a cui non avevo annunciato il mio ritorno. È meglio prenderla alla sprovvista, non darle il tempo di agitarsi, per poi battere velocemente in ritirata, lasciarla nella sua tranquillità.
Mio padre è morto da tempo, lo conosco solo dalle foto, e mia madre si comporta come se la nostra casa fosse un mausoleo. Sta con le tende tirate, non sia mai che il sole scolorisca le foto alle pareti, e con le finestre chiuse, che non entri la polvere. Mi chiedo che aria respiri. L’aria che penetra nel corridoio, nel tempo che apre e chiude la porta quando va e torna dal mercato? Arrivato alla soglia, ho bussato alla porta. «Prego, entra», ha detto la mamma, senza abbracciarmi o baciarmi – non è da lei, come me, che non le posso parlare senza darle del voi. Ho tolto le scarpe e sono andato nel soggiorno, dove la TV era accesa su un canale concorrente. Ho preso posto con cura – so quanto ci tiene la mamma al divano su cui mi ha concepito. Forse per il resto i miei hanno fatto l’amore solo sul pavimento o in piedi. O non l’hanno fatto. Perché il letto in camera era per dormire, vegliato dal quadro della Vergine Maria, e sempre per il sonno era anche il divano, quanto meno dopo che sono nato io e fino a quando non ho avuto la prima ragazza. Non so se la mamma ha mai sospettato che ogni tanto le infilavo qualche tipa in casa – non me l’ha chiesto, non le ho detto nulla. Avevo però cura che la ragazza non mettesse il profumo e alla fine raccoglievo dal cuscino e dal parquet tutti i capelli. Alle 17, quando la mamma tornava dal lavoro – e non è mai successo che tornasse prima in tutta la sua carriera da contabile alla fabbrica di cemento –, tutto era picobello. Ho continuato così fino a quando sono andato all’università nella capitale. Solo là, nello studentato, ho passato la mia prima notte tra le braccia di una donna. La mattina, per riflesso, ho iniziato a raccoglierle i capelli. «Hai un’altra o cosa?» mi ha chiesto. Mi sono bloccato e non ho potuto fare altro che osservarla mentre si vestiva e se ne andava sbattendo la porta. Sono passati alcuni anni da allora e dall’ultima relazione stabile – al di fuori di quella con la televisione, che mi offre abbastanza scopate.
Non ho fatto in tempo a sedermi per bene, di fronte all’armadio con la vetrina in cui luccicavano decine di statuine in porcellana, che la mamma è venuta dalla cucina con un piatto di salumi, me l’ha messo davanti, sul tavolino basso, su cui ha steso un tovagliolo perché l’impiallacciatura non si macchiasse, e si è seduta nella poltrona, vicino alla finestra nascosta dietro le tende. Si è messa le mani in grembo sulla vestaglia, guardando abulica le immagini sullo schermo. «Su, mangia», ha detto, e quando ho iniziato a masticare ha rivolto lo sguardo verso di me. Come al solito, ho abbassato gli occhi sul piatto e ho fatto finta di non notare come mi fissava. Poi ho ringraziato per il pasto e mi sono alzato. «Devo correre, ho il raduno al liceo. Non so quando vi rivedrò, ma ci sentiamo» le ho detto in corridoio, piegato a infilarmi le scarpe. La faccenda del sentirsi è che ci parliamo per telefono una volta al mese e allora mi racconta di cos’altro hanno fatto i vicini. Non più di cinque minuti, alla fine dei quali ha luogo questo scambio di repliche: «E voi come state?» «Bene. Tu?» «Anche io». «Bene allora, ci sentiamo.» «Sì mamma, ci sentiamo.»
Ero quindi già in corridoio e mi mettevo le scarpe. Mia madre era venuta sulla soglia del soggiorno e si era appoggiata allo stipite della porta. «Solo questo ti chiedo: non vendere l’appartamento!» mi ha detto. Mi sono raddrizzato all’improvviso e, con il calzascarpe in mano, le ho lanciato uno sguardo che l’ha quasi fatta sorridere. «Sei tutto tuo padre! Su, vai e riguardati» ha aggiunto, con una voce calda e pastosa che non le avevo mai sentito. «Stammi bene, mamma!» le ho detto e sono uscito sul pianerottolo, scendendo velocemente le scale. Avrei avuto tempo più tardi per pensare al modo in cui mia madre mi ha salutato. Ma non ho più avuto il tempo o l’umore per tornare e lasciarle il calzascarpe che avevo in mano quando sono andato via.
In classe eravamo in trenta. Alla riunione ne sono venuti diciotto. Gli altri erano spariti per il mondo e Marcus non ha saputo come rintracciarli. Perché proprio Marcus si era occupato dell’organizzazione del raduno. Proprio lui, l’attaccabrighe e l’assenteista della classe, che aveva finito il liceo copiando i compiti da uno le tesine da un altro, mangiando il sandwich che gli sembrava migliore quel giorno. Con i soldi delle nostre paghette usciva al bar con le tipe più fighe della scuola e ti faceva un favore a far pagare a te il gettone del biliardo per giocare con lui. In cambio, interveniva per te se avevi problemi con altri di altre classi. A me però non ha mai dato problemi, forse perché eravamo vicini di bloc. Passavo spesso da lui, visto che da me era proibito giocare, per evitare di graffiare il parquet, rompere una porcellana o, in generale rovinare l’atmosfera pesante che ha seguito la morte di mio padre. E così prendevo i miei indiani di plastica e scendevo da Marcus, dove potevi saltare anche dalla biblioteca sempre piena di statuine, ma in ghisa, che non ci rimaneva male nessuno. Conoscevo i suoi, anzi le abbiamo pure prese insieme da suo padre una volta. Grande pescatore, il giorno prima della pesca stava riempiendo la vasca da bagno con pesciolini da esca e ci ha beccati mentre li cacciavamo per la vasca con un barattolo, che svuotavamo nel gabinetto e tiravamo l’acqua gridando «free Willy!». Abbiamo condiviso allora schiaffi e pedate fino alla nausea. Almeno così ho scoperto anch’io com’è prenderle da papà. E forse da qui è nata anche la relazione speciale con Marcus, il terrore della classe e della scuola, che poi ha reso possibile il nostro incontro.
La vecchia coordinatrice ha fatto l’appello, ci siamo alzati dai banchi e ci siamo raccontati gli ultimi dieci anni. Tra le ragazze, la maggior parte era sposata, aveva figli e lavorava al nastro, nella fabbrica di manubri. Solo una, la secchiona della classe, aveva fatto medicina e aveva aperto uno studio come medico di base in città. I ragazzi erano tutti sposati, padri, e lavoravano alla fabbrica di cemento, tranne Vlad, il proprietario di un autolavaggio che si occupava anche di lavori di asfaltatura stradale, e me, lo scapolo considerato il tipo della TV, e Marcus, il signor vice, che ha provocato una valanga di applausi. A malapena si è sentito quel «Amico, ma a me quando asfalti la strada?», che ha portato Vlad e Marcus a lanciare un’occhiata al compagno. Che si è scusato poi, durante la cena al ristorante, che voleva solo fare una battuta.
Quel ristorante è nell’hotel in cui ho preso alloggio. La caposala è la moglie del capo della polizia della città e l’amante di Marcus, il proprietario dell’hotel, anche se nei documenti è intestato alla moglie. La moglie che non è riuscita ad arrivare alla cena festiva perché era uscita con le amiche. Per il resto, tutti sono venuti accompagnati e si sono affrettati all’open bar, disponibile a fronte di un modesto contributo. Avevano, al contrario, l’intenzione di fare un danno quanto più grande. «Tutto torna», ha riso Marcus rivolto a me e Vlad. Stavamo a un tavolo separato, e vicino a noi, in piedi, la caposala aspettava un segno per versarci altro whisky. Dopo mezzanotte volevo salire a dormire. Marcus e Vlad si parlavano all’orecchio, in modo che non li sentissi o che si sentissero attraverso la musica alta, e io mi ero stufato del ballo dei compagni che gridavano felici, stretti in una hora con le mogli al collo. La loro allegria aveva qualcosa della frustrazione accanita di quelli che hanno perso il treno e non hanno più la speranza che ne arrivi un altro, soprattutto perché non dipende da loro. Se mai fosse dipeso da loro. Ma non sembravano nemmeno il genere che si sarebbe buttato davanti alla locomotiva. So di cosa parlo. Una delle mie prime notizie era stata su un ragazzo che ha messo la testa sulle rotaie. Non gli importava da dove venisse il treno e in quale direzione andasse, solo che esiste e passa di lì. Mentre i miei compagni si accontentavano di ballare sulla banchina, di dimenticare di essere in una stazione.
«La notte è giovane», mi ha detto Marcus quando ho fatto per alzarmi. «Abbiamo ancora da fare.»
Sono uscito sul viale con i castagni e mi sono avviato verso il centro con Marcus. A un certo punto ci siamo sdraiati in mezzo alla strada e abbiamo fatto una gara di flessioni. Poi siamo arrivati al club di striptease, dietro la chiesa. «Ah, signor vice!» Ha sorriso il barman. Ci siamo buttati sui divanetti e abbiamo guardato le ragazze che hanno lasciato i loro bicchieri di vodka e hanno provato a tenersi al palo mentre muovevano i fianchi. Ci hanno rinunciato presto e sono venute a ballarci addosso. Quando una mi si è addormentata sopra, mi sono alzato per tagliare la corda. Speravo ancora di avviarmi al mattino verso casa. «Andiamo da me, a bere ancora qualcosa!» mi ha detto Marcus. «Non mi scappi così!»
E sono arrivato da Marcus. Al margine della città si era costruito una villa con piscina. Sono entrato in soggiorno e, mentre riempiva i nostri bicchieri, ho visto il paio di mutande sul tavolo con un bigliettino: “cucile”. Questo era scritto su un pezzo di carta strappato da un’agenda con l’intestazione del comune. Abbiamo brindato, ho vuotato il bicchiere e mi sono lasciato cadere su una poltrona. Marcus credeva che mi fossi addormentato quando ha messo il filo nella cruna e ha iniziato a cucire le mutande della moglie. E a un certo punto si è fatto tutto buio. Mi sono svegliato nella camera d’hotel verso le otto di sera. Allora ho fatto i bagagli e ho detto basta.