La mamma è morta sola e lentamente.
La causa della morte, secondo i medici, è stata un’intossicazione. La mamma intossicata.
Che idiozia.
Non ho voluto discutere con i medici, mi sono limitata a firmare i documenti e ad occuparmi del funerale. Se c’era una cosa che mia madre conosceva bene era la sua dispensa delle erbe. Era sempre stata precisa con le dosi. Non si sbagliava. Alla bambina, per adesso, ho raccontato la ver sione ufficiale, quella dell’intossicazione. Un giorno le dirò io stessa che sua nonna si è suicidata.
La bambina è stata sempre presente. Dopo averle dato la notizia l’ab biamo portata all’obitorio. È rimasta incollata alle mie gambe per tutta la durata del funerale e anche durante la messa che Raúl si è ostinato a orga nizzare. Non abbiamo smesso nemmeno per un attimo di spiegarle con precisione cosa stava succedendo, perché potesse comprendere che sua nonna era morta. Accettarlo. Raúl aveva proposto di lasciarla qualche giorno con la baby-sitter, ma io so bene che la cosa migliore in questi casi è vedere tutto. Per assimilare le morti bisogna vederle, bisogna toccarle. Quando è morto Adrián nessuno mi ha lasciato vedere il suo corpo. Se muore qualcuno e non ti lasciano vedere il corpo, è peggio. Si formano dei buchi neri colmi di dubbi che si trascinano via per tutta la vita e che pesano come mattoni. Con il tempo si accumula sporcizia all’interno, e arriva un momento in cui pulirli è impossibile.
Sono come l’appartamento della mamma: stipato.
Non so se riuscirò a svuotarlo o a pulirlo in soli quattro giorni. Ci restano quattro giorni per andarcene da Madrid, e oggi è di nuovo giovedì. È trascorsa una settimana dalla morte della mamma. Raúl si è offerto di aiutarmi, ha insistito per fare svuotare ai ragazzi del trasloco anche l’appar tamento della mamma.
Ma è qualcosa che devo fare da sola.
Con le mie mani.
L’appartamento l’abbiamo venduto così in fretta che non ho avuto nemmeno il tempo di abituarmi all’idea di ciò che stava succedendo. L’unica cosa che mi piacerebbe conservare è il pianoforte. Voglio tenermi il piano e, semmai, i barattoli della dispensa della mamma. Mi sono sempre piaciuti quei barattoli. Ricordo che da bambina leggevo le scritte a voce alta e che quando le pronunciavo tutte di fila erano come musica per le mie orecchie.
Borace. Cremore di tartaro. Balsamo verde.
Le pronunciavo come un incantesimo. Mi piace ancora leggere quelle parole, dipinte di nero sulla porcellana dei barattoli, con una calligrafia da esperta, toccare la fine delle lettere curve che si arricciano verso l’e sterno.
Non mi porterò via tutti i barattoli perché occupano una parete intera. Ora sono vuoti. La prima cosa che ho fatto, dopo aver trovato la mamma morta nel suo letto, è stata svuotare la dispensa. La mamma si era curata per tutta la vita da sola con quelle erbacce. Per le ricette usava i barat toli dello scaffale superiore. Il resto dei barattoli li aveva svuotati quando sono rimasta incinta. Perché la mamma, se aveva fatto dei cambiamenti in casa, era per non far correre rischi a Sara. Aveva istallato nei cassetti le chiu sure di sicurezza per bambini, aveva inchiodato gli scaffali alla parete e co perto gli spigoli dei tavolini bassi con dei pezzi di sughero. Senza dubbio i barattoli saranno l’unica cosa della mamma che conserverò. Insieme al piano.
Metterò tutto nello studio della nostra casa nuova a Barcellona. Dovrebbero entrarci fino a cinque barattoli attaccati; uno accanto all’altro, sopra il coperchio ribaltato del piano.
Sambuco bianco. Belladonna. Foglie di bosso.
Prima di svuotare il salone devo passare dal resto dell’appartamento della mamma. Devo seguire un ordine logico, se voglio farlo correttamente. Come sarebbe piaciuto a lei. Per evitare che la casa mi crolli addosso. Iniziare dalla cucina, che si trova alla fine del corridoio, da lì – il punto zero – ripercorrere al contrario le stanze della casa, dall’ultima alla prima, svuo tarle di tutte le cose accumulate, come se passasse da lì una piaga di locuste. E poi arrivare al salone.
Lasciare la stanza di Adrián alla fine.
Come avrebbe fatto lei.
Quando sono entrata nell’appartamento il giorno della morte della mamma, tutte le finestre erano aperte. Sono sette stanze e ognuna ha due, tre o quattro finestre. Il salone, al posto di vere e proprie finestre, ha delle porte vetrate che si aprono su un balconcino e che sono protette da contro finestre di legno. Questa parte della casa si affaccia sulla strada. Se le porte dei balconi sono spalancate, le controfinestre sbattono sui vetri. Dolcemente. Quando giovedì sono entrata nell’appartamento della mamma, si muoveva tutto al ritmo della brezza, come se fosse vivo e stesse gridando. Quando sono entrata, la corrente e il freddo erano parte della casa. La mamma era sul letto, e sembrava addormentata. Ma ho capito che era morta ancora prima di vederla, non appena sono entrata. L’ho capito appena ho sentito come mi respingeva il vento quando ho aperto la porta con il mazzo di chiavi.
Ho dovuto spingere la porta con tutte le mie forze.
Perché la mamma, per permettere alla sua anima di andare diretta mente in cielo, aveva avuto l’accortezza di morire con tutte le finestre aperte.
Dopo circa tre ore, metà della cucina è dentro gli scatoloni. Non ho imbal lato con attenzione perché tanto andrà tutto nella spazzatura. Se si rompe una tazza non fa niente.
L’appartamento della mamma ha sette stanze e sono tutte piene di oggetti. La mamma aveva la tendenza all’accumulo compulsivo. Conservava di tutto in casa, riempiva le pareti, le rivestiva di scaffali stra pieni, traboccanti. E, dalla prima diagnosi, negli ultimi mesi, le era presa la mania di conservare le cose nei posti sbagliati. I soldi dentro le teiere, per esempio, o gli aghi da cucito tra le posate della cucina.
Ma di certo non mi aspettavo di trovare qui, nella dispensa della cucina, proprio sopra le ceste stracolme di mele e arance, le mie scarpe di vernice. Sono dovuta salire su uno sgabello per prenderle. Sono intatte, lucide come se le avessi lustrate il giorno prima. E i lacci, duri come pietre, sono legati in un fiocco perfetto.
Erano le mie scarpe della domenica, quelle che mi mettevo per andare a far visita prima alla tomba di papà, poi a quella di Adrián. Nell’anno delle morti. Me le misi per la prima volta durante il funerale di papà; di quel pomeriggio ricordo che trascorsi ore a pulire le scarpe con uno straccio, per renderle lucide. Perché, ogni volta che finivo di lustrarle, Adrián me le pestava per macchiarle di nuovo. E allora dovevo ricomin ciare. Di quel pomeriggio ricordo anche che il nonno tedesco si avvicinò e mi disse che erano delle scarpe perfette. E che riuscì, grazie a una specie di incantesimo che usava su Adriàn, a fare in modo che mi lasciasse in pace. Era la prima volta che lo vedevamo di persona. Ricordo la sua voce grave, il modo in cui pronunciava le consonanti. Il tedesco che parlava lui non era come quello che ci insegnavano a scuola e aveva una pronuncia diversa da papà, come se fosse a scatti. Quel pomeriggio il nonno passò tutto il tempo con mio fratello, che lo seguiva come un cagnolino obbediente.
Quando ci salutò e si portò con sé Adrián, si inginocchiò per par larmi. Mi guardò negli occhi. Mi disse che mio fratello sarebbe stato bene, che si sarebbe preso cura di lui. Ma Adrián morì pochi mesi dopo il fune rale di papà. Mandarono il suo corpo dalla Germania in una bara artigia nale, fabbricata in uno dei laboratori del nonno. E così abbiamo avuto un altro funerale, un’altra tomba.
Nell’anno delle morti.
Credo che da quel momento sia iniziata la crisi della mamma. Non faceva che ripetere che la famiglia di mio padre, a furia di fabbricare bare, era maledetta. E che questa maledizione era la causa di tutto. Che era meglio che Adrián fosse morto piuttosto che dedicarsi alla costruzione di bare e ad abbellire cadaveri. Quando diceva questo si faceva immediata mente il segno della croce.
L’anno delle morti andavamo tutte le domeniche al cimitero. L’unica cosa che ricordo di quelle passeggiate erano queste scarpe nere, quanto era diventato importante per me mantenerle pulite. Se riuscivo a renderle abbastanza lucide, le scarpe si muovevano da sole, io non dovevo fare alcuno sforzo per muovermi.
Non dovevo fare alcuno sforzo.
Ricordo il rumore e l’eco che facevano i tacchi quando camminavo con le scarpe di vernice sul sentiero asfaltato. Al cimitero era meglio fare rumore con i piedi ‒ per permettere ai morti di sapere sempre dove ci tro vavamo ‒ e camminare in fretta, molto in fretta, per evitare che, nemmeno per errore, ci fermassimo su un morto diverso dal nostro. Ricordo che le dita dei piedi mi premevano contro la punta delle scarpe, soprattutto quando le domeniche diventarono più lunghe e iniziò a far caldo. Quell’anno non andammo in vacanza.
Di tutti i vestiti neri che avevo, le scarpe di vernice erano l’unica cosa che mi piaceva. Mamma, l’anno delle morti, mi obbligò a vestirmi di nero, soprattutto dopo il funerale di Adrián. L’unica cosa che potevo indossare che non fosse nera, era l’uniforme della scuola. Ora che ho le scarpe in mano mi sembrano ridicole.
Odorano pure di frutta guasta.
Mi piaceva lucidarle fino a vederci il riflesso del mio volto. Erano scarpe specchio. Quando camminavamo per il cimitero la mamma non mi permetteva di fermarmi, nonostante tutta la polvere che si sollevava mentre camminavamo. Quando volevo fermarmi per scuotere le scarpe, mi stratto nava. Avevamo molta fretta, anche se a casa non c’era nessuno ad aspet tarci. Gli strattoni mi lasciavano segni rossi sul braccio. La mamma portava sempre un mazzo di tre fiori. Quando camminava portava il mazzo all’in giù, con i tre fiori rivolti al suolo che si riempivano di polvere. Un fiore era per mio fratello, l’altro per papà.
Sui lacci, ora che li tocco, si notano gli anni; sono rigidi, quasi fossi lizzati, come se si trovassero da molto tempo nella stessa posizione. Avevo i piedi così piccoli quando li calzai per la prima volta che ad Adrián, che allora aveva i piedi solo un paio di centimetri più lunghi dei miei, non en travano. Il giorno del funerale di papà provò a mettersele solo per darmi fa stidio. Fin quando non arrivò il nonno per portalo via con sé. Fu l’ultima volta che lo vidi.
Quando ci penso mi sento le mani calde, mi nasce un impulso nelle mani, si vogliono muovere per fare il segno della croce, come faceva la mamma. Ma le scrollo con forza, le distraggo, non ci penso più.
I lacci, tesi in mano, sembrano due bisce sottilissime. Li arrotolo su sé stessi, li metto dentro le scarpe, uno in ogni scarpa, e spingo la palla di lacci fino in fondo, li spingo verso la punta. Da fuori non si vedono più. Adesso sono solo scarpe senza lacci. Inoffensive.
Mentre sto per buttare le scarpe nella stessa scatola in cui sto but tando tutto il resto, cambio idea. Le lascio per terra e preparo una nuova scatola. Per far reggere meglio la scatola nuova metto del doppio nastro da imballaggio. Prendo le scarpe di vernice – che, a furia di toccarle con le mani sporche, si sono macchiate di polvere – e le metto dentro questa sca tola vuota. Non le pulisco. Questa scatola la separo dal resto e la etichetto con un pennarello. Scrivo di rosso, in maiuscolo: mamma.
View Colofon
Original text
"Los seres vivos" written in Spanish by
Mariana Torres,
Other translations
- "Ființele vii" translated to Romanian by Oana-Dana Balaş,
- "De levenden" translated to Dutch by Heleen Oomen,
- "Os Seres Vivos" translated to Portugese by Matias Gomes,
Gli esseri viventi
Translated from
Spanish
to
Italian
by
Valeria Parlato
Written in Spanish by
Mariana Torres
This text has been made possible thanks to the collaborative efforts of the CELA network. Are you interested in reading more translated chapters of this writer? Please reach out to us!
More by
Valeria Parlato
Comunione
Translated from
Spanish
to
Italian
by Valeria Parlato
Written in Spanish by Roberto Osa
7 minutes read
Non dare da mangiare alle scimmie
Translated from
Spanish
to
Italian
by Valeria Parlato
Written in Spanish by Roberto Osa
7 minutes read
Distorti
Translated from
Spanish
to
Italian
by Valeria Parlato
Written in Spanish by Matías Candeira
7 minutes read
Idro (estratto di un romanzo)
Translated from
Spanish
to
Italian
by Valeria Parlato
Written in Spanish by Matías Candeira
11 minutes read
Albero mostro bambino albero
Translated from
Spanish
to
Italian
by Valeria Parlato
Written in Spanish by Mariana Torres
9 minutes read
You might also like
Il raduno
Translated from
Romanian
to
Italian
by Andreaa David
Written in Romanian by Alexandru Potcoavă
9 minutes read
L'avvento
Translated from
Romanian
to
Italian
by Andreaa David
Written in Romanian by Alexandru Potcoavă
6 minutes read
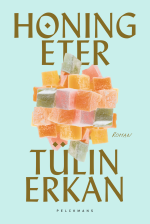
ARRIVALS / GELIȘ (Mangiamiele)
Translated from
Dutch
to
Italian
by Matilde Soliani
Written in Dutch by Tülin Erkan
7 minutes read