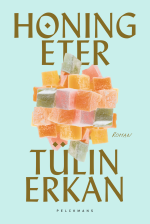DISCLAIMER: MONDOBOIA è una raccolta di racconti composta da sei cicli (Jedna neobična vest, Ptice ne preleću prigradska naselja, Crtice iz minibusa, Skorosmrtnica, Na usta, Ako ste nas bombardovali). Ogni ciclo comprende cinque racconti che ci introducono ai personaggi e agli eventi delle loro vite, hanno finali aperti, sono spesso privi di introduzione e si collegano l’uno all’altro a livello spaziale. Nel complesso, la raccolta di racconti MONDOBOIA tende ad avere un approccio umoristico e ironico alle tematiche serie della vita quotidiana di persone che vivono un momento storico o intimo di passaggio.
Ciclo Gli uccelli non volano in periferia
La casa della cultura di ogni paesino si è trasformata in un negozio davanti a cui tre o quattro tizi in ciabatte Abibas di gomma bevono birra. Uno dice che i politici sono stronzi il secondo impreca il terzo sputa di lato e il quarto, se c’è, si limita a pestare l’orlo di latta di una vecchia grondaia, in silenzio. In una compagnia del genere non incontrerete mai Jovan Vokanović, figlio unico di una grande famiglia di Desimirovac, quasi laureato, con interessi sofisticati e vacanze sul litorale greco. Jovan non compra in quel negozio pieno di prodotti locali di serie B, tra i quali quello che più gli fa schifo è forse il cestino di uova ancora sporche di merda di gallina che sta proprio vicino alla cassa. Eppure, quando poi gli scoccia andare in città alla ricerca di prodotti raffinati di distributori tedeschi e francesi che, essendo un economista mezzo laureato, conosce abbastanza bene, raccoglie in qualche modo le forze e si mette a girare tra quegli scaffali squallidi. Certo, sarebbe più semplice se non dovesse incontrare la cassiera Jagoda Velikić, alta come la croce davanti alla chiesa di Desimirovac, scura come il buio tagliente dell’inverno. I denti di Jagoda, ora marci e anneriti, sono stati i primi con i quali si è scontrata la lingua di Jovan Vokanović e, stranamente, ogni volta che lei lo guarda, lui si ricorda di quella sera al bar col biliardo, e un brivido lo attraversa al pensiero che sarebbe potuto finire con lei e baciarla anche ora su quella bocca putrida. Tra sé la definiva proprio quella bocca putrida mentre cercava di estrarre una banconota dal rotolo, guardando quelle uova sporche di merda secca anziché gli occhi insolitamente tristi di Jagoda Velikić. Ma lo sguardo di Jagoda, che ogni giorno scherzava allegramente con i clienti e andava a caccia di battute innocenti e alcune pure sconce, si spegneva e cadeva sul pavimento ogni volta che Jovan metteva piede nel negozio. In realtà, Jagoda ne era sicura, sapeva riconoscere l’odore della benzina della sua automobile, capiva che sarebbe arrivato dal rumore della manovra di parcheggio e, quel che è peggio, nemmeno dopo tutti gli sguardi evitati con sprezzo riusciva ad affogare quella farfalla tra le ovaie che ogni volta iniziava ad agitare le ali pesanti nel suo utero. Perché lei sentiva che in qualsiasi momento Jovan avrebbe potuto alzare lo sguardo, prenderla per mano e dirle Jagoda, voglio sposarti. Ma Jovan non sposerà mai Jagoda. Vivrà grazie ai soldi dei suoi genitori fino a quando avrà quarantotto anni, sulla soglia dei quaranta troverà una ventenne a cui aprirà un salone da parrucchiera, lei gli darà due figli, uno grasso e l’altro bello come la mamma, lui invece la tradirà qualche volta con la sua migliore amica, che è tanto brava a preparare ciambelle. Quello che Jagoda non capisce, mentre passa il dito sullo scotch che proprio non riesce a staccare dal bancone e impila con ordine i panini secchi di domani e mentre sulle guance le scorre una fila di lacrime salate di delusione, è che in tutta la vita di Jovan Vokanović, dal momento in cui le ha buttato quei venti dinari in mano a quello in cui morirà di cirrosi, che in tutta quella vita non ci sarà un solo istante la cui intensità si possa paragonare alla più banale delle battute di Jagoda. Tra le tante, per esempio, quella che fa a una collega quando nel negozio entra un ragazzo carino, per poi strizzare gli occhi, picchiettarsi la fronte con una mano e allargare le due file di denti marci in un sorriso. Jagoda non capisce, ma anche domani, senza alcun dubbio, sorriderà allo stesso modo.
Ciclo Schizzi dal pulmino
Il primo olio su tela del pittore Neša Nedeljković era stato venduto proprio dal pulmino dell’azienda Gea appena fuori Bujanovac. Il tizio aveva offerto cinquanta euro, così diceva l’sms, e Neša era grato a Dio di trovarsi ancora da quella parte del confine per poter ricevere quella notizia fantastica. Per un po’ aveva fissato il cellulare e poi aveva iniziato a pensare al modo più teatrale di annunciarlo a sua moglie Ɖurđa Nedeljković, che in quel momento fondamentale stava puntualmente russando sul cuscino gonfiabile da viaggio, con il mignolo agganciato a una busta della spesa piena di dinari. Dopo qualche minuto, Neša svegliò piano piano sua moglie, le mostrò il dipinto e le chiese se le sarebbe piaciuto tenerlo a casa o regalarlo a degli amici. Da quando Neša era andato in pensione, Ɖurđa aveva sempre rispettato molto il suo ingresso nel mondo dell’arte, in cui finalmente l’aveva raggiunta; con un po’ di indifferenza, però, propose di regalare il dipinto ai loro testimoni di nozze. A quelle parole Neša sobbalzò sul sedile, e, cosa che confuse lui per primo, gridò ridendo: Ma non possiamo darlo via. La professoressa di musica in pensione Ɖurđa Nedeljković si alzò a sedere e guardò i capillari rotti negli occhi del marito, mentre lui, con la lingua screziata, quasi leccava la montatura dei suoi occhiali. Perché quello era l’istante più importante della vita di Neša Nedeljković, che aveva sempre saputo che sarebbe arrivato anche il suo momento di gloria. Ne era convinto anche quando le ragazze lo rifiutavano perché era pieno di acne, o mentre era l’alunno migliore della classe, persino quando i genitori erano morti e lui non era riuscito a finire Giurisprudenza ed era stato costretto a passare tutta la vita a sbirciare dentro le interiora metastatiche delle Zastava Yugo. Neša Nedeljković sapeva che sarebbe arrivato un giorno come quello, in cui all’improvviso i residui decennali di olio motore sarebbero scivolati via per sempre dalle sue dita. Adesso era germogliato, come le piante nei suoi dipinti, il cervello di Neša si estendeva fino al cielo con sfumature porpora. Forse ha avuto un ictus, pensò un po’ ingenuamente Ɖurđa fissando gli occhi pulsanti del marito. Non lo diamo via perché è stato comprato, non lo diamo per questo, pronunciò finalmente Nedeljković con una voce strana, stridula e brusca: l’aveva quasi strillato. La professoressa di musica in pensione saltò sul sedile con incontenibile felicità, abbracciò il marito un po’ di volte, lo baciò sulla bocca con le labbra umide e curate e lanciò qualche pigolio al vento. Poi guardarono a lungo quel quadro che avevano fotografato col cellulare come tutti gli altri, ottanta in tutto, che Neša aveva dipinto nel corso del primo anno di pensione. Quello era il loro preferito. È questo fiume, Ɖurđa indicò un ruscelletto sottile che scendeva da una capanna e arrivava fino alla collinetta che chiudeva il dipinto, vedi come l’hai reso vivo. No, no, è per le nuvole, Neša passò il dito sul piccolo schermo del telefono come se cercasse di toccarle. Al benzinaio albanese scesero tutti dal pulmino per respirare un po’ d’aria e sgranchirsi le gambe, con una sigaretta e un burek troppo caro. Ɖurđa e Neša Nedeljković rimasero seduti ai loro posti osservando un gabbiano e conclusero che era proprio quello, nient’altro, la ragione per cui il dipinto era stato venduto. Neša Nedeljković reclinò la testa sulla spalla di sua moglie e dormì per un’ora con la fronte appoggiata al finestrino freddo, che vibrava violentemente a ogni buca della strada. La professoressa di musica in pensione continuava a tenere in mano il cellulare con la foto aperta e osservava la capanna di paglia e il ruscelletto vivace che fluiva verso una collina totalmente sproporzionata, come pure quel gabbiano, che pareva volare verso di te quando ti incantavi a fissarlo. Guardava Neša dormire, le sue mani percosse da scatti come le zampe di un gatto. Ɖurđa aveva sempre saputo che era un genio, anche quando non lo capiva nessun altro, e ora cosa sarebbe successo se si fosse montato la testa? Se avesse trovato una donna più giovane, se si fosse trasferito a Parigi a fare mostre mangiare caviale scolarsi spumante? La striscia oscura e superba dell’autostrada passò attraverso il ventre di Ɖurđa e si srotolò alle sue spalle. Ehi Neša, lo svegliò, Neša, non lo vendiamo, ci sono tanto affezionata. Neša, frastornato, rifletté in silenzio per un istante, poi le accarezzò la testa, rassicurandola: Ne troveremo un altro, e con estrema velocità e totale innocenza sprofondò nel sonno. Ɖurđa si era salvata per un pelo, e sapeva che era stata questione di un attimo, dalla terribile disgrazia che avrebbe portato suo marito ad Amsterdam, forse a New York, o chissà dove lontano dalla sua volontà. Eppure, non riusciva a smettere di immaginare la grande sala del Pompidou con Tramonto in terra natia di Neša come sovrano incontrastato dello spazio. E proprio tutti lì ad ammirarlo.
*
A 354 km da Belgrado, Marina si ricordò che avrebbe potuto mangiare qualcosa. Tirò fuori quatta quatta il suo salatino ai wurstel, ma non riuscì a passare inosservata, la busta frusciava e ondeggiava come il mare. Ora avrebbe dovuto offrirlo al suo vicino. Tra l’altro proprio il salatino ai wurstel, che non si può smezzare. Eppure, doveva. Ne vuole un po’, no, sono a posto, va bene, e affondò i denti sottili e affilati nella crosta croccante della sfoglia. In quel preciso istante il pulmino si fermò dal benzinaio e ora Marina doveva tentare di terminare il suo pasto al vento. Stava tornando dall’università, viaggiava tre volte a settimana sulla tratta Gračanica-Belgrado. Ogni tanto si fermava a dormire da sua sorella a Borča, ma spesso le sembrava stupido chiedere e la sorella non si offriva più perché le seccava passare il tempo con una che taceva in modo così irritante. Da quando si era iscritta al dottorato, in quanto figlia dei più ricchi della zona, tutti finalmente erano fieri di lei. A causa di quel viso butterato non le avevano mai detto che era bella, solo che era intelligente, ma dopo anni in cui aveva preso sempre il massimo dei voti era scomparso anche quel complimento. Ora, però, Marina aveva acquisito una nuova forza: nel vicinato si parlava di lei come di una scienziata importante e come di una cittadina illustre del paese. Se non fosse stata butterata, tutti avrebbero detto che si era trovata qualcuno e che non studiava affatto ma faceva la puttana e i genitori non volevano che si sapesse in giro. Invece tutti credevano ciecamente che lei fosse una dottoranda e ogni volta che tornava le domandavano di questioni che avevano sentito alla televisione e lei rispondeva in modo timido e conciso, cosa che quasi sempre li faceva impazzire perché si aspettavano un saggio e si ritrovavano quella ragazzina muta. Però non avevano un altro dottorando e dovevano accontentarsi delle risposte brevi di Marina, del suo modo impacciato di tormentarsi le dita sottili. Non sapevano nemmeno che sarebbe stata l’ultima volta che partiva da Belgrado e che non ci sarebbe tornata mai più, che nel mare degli studenti era stata affogata dal pugno di ferro dell’élite intellettuale locale. E lei stessa era scioccata: fino a quel momento studentessa con tutti dieci, da quel momento, d’un tratto, una che non aveva passato l’anno per colpa di elaborati infantili e sentimentali sui Karamazov nei quali aveva scritto che Alëša era un angelo, cosa per cui l’eminente professore le aveva restituito il libretto con profonda indignazione e una compagna di corso aveva sfoggiato un sorriso soddisfatto. Questo succede quando vengono qui solo per dare un senso alla laurea, aveva sentito confusa Marina mentre usciva, per l’ultima volta, dallo studio ocra del suo professore di letteratura. Ed eccola ora, che si copriva le dita gelate con le maniche, e ancora ugualmente confusa cercava di comprendere cosa fosse successo. In quel momento, sull’erba rinsecchita vicino al distributore OMV, sentiva di essere completamente priva del senso che aveva fino a qualche giorno prima. Per lo stress e la polvere della città, il suo viso pallido si era scaldato ancora di più e il sebo era divampato sotto la pelle sottile. L’autista del pulmino ringhiò ai passeggeri di salire sul veicolo perché non aveva intenzione di farsi dieci ore di viaggio. Ma guardate Marina, lei non sale, ha le gambe inchiodate all’erba e le dita completamente rilassate che si muovono come piccole onde ai lati del corpo. Sa che non può tornare a casa, per questo il suo corpo si è cristallizzato e ora la sta trasformando in una quercia. L’autista si arrabbiò, i passeggeri erano in agitazione. Una donna le si avvicinò, ma fu atterrita dai suoi occhi inespressivi e arretrò di quasi un metro. I minuti passavano nell’attesa di qualche cenno di Marina, però lei non si muoveva e solo i suoi capelli vivi ondeggiavano all’aria. Marina è una torcia. Illumina se stessa e sa quanto lontano possa arrivare quella luce. L’autista si stancò e un borsone blu scuro le cadde ai piedi. Allora reagì: si voltò appena appena verso l’autista e i passeggeri, che ancora una volta guardarono nella sua direzione, restituì loro un debole e timido sorriso e alzò la mano destra come per un saluto. Quando le porte del pulmino si chiusero sbattendo, ricordò le parole del suo professore: Lei è un’analfabeta sia dal punto di vista stilistico che da quello scientifico, una vergogna per la comunità accademica. Poi prese la sua borsa e si incamminò verso l’uscita dell’autostrada. Il bivio per Velika Drenova non lo vide neanche. L’aria fredda della notte le aveva intorpidito le guance, spalancò la bocca e quasi per caso iniziò a gridare: ALËŠA ERA UN ANGELO! Poi camminò fino al monastero di Sant’Elia e lì rimase fino alla fine dei suoi giorni.