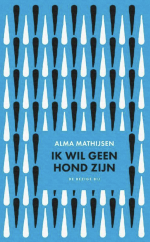Ancora 47 notti
L’igienista mi toglie il raschietto dalla bocca.
«Vedi?» chiede, quasi orgoglioso.
Sul raschietto c’è uno strato di saliva grigiastra.
«Questo viene dalla tasca».
Una strana parola per un buco tra la mia gengiva e l’ultimo molare. Una tasca dà l'idea di qualcosa di grande, qualcosa in cui puoi tenere le chiavi, magari anche del gel disinfettante o un telefono. Nella mia tasca ci sono solo dei resti di cibo triturato, vecchi di qualche mese.
Poco dopo arriva anche il dentista e indica la mia mascella sullo schermo del computer. Il dente del giudizio in basso a destra si è messo in posizione orizzontale, le radici si allungano all’indietro e la parte superiore spinge contro l’ultimo molare.
«Perché fa così?» chiedo io.
«Non lo sappiamo» risponde il dentista «a volte i denti si spostano». Fra tre settimane bisogna toglierlo. Quella sera non riesco ad addormentarmi. Non posso fare a meno di pensare al dente che ha deciso di spostarsi, non più a suo agio nelle mie gengive. Non era mai uscito fuori, era sempre rimasto al buio. Magari è stato quello. Anche un dente vuole vedere qualcosa. Penso al tizio senza un dente della consegna di cibo a domicilio, aveva un gran sorriso, una fila di denti bianchi con in mezzo un buco. Voglio sapere dov’è adesso il suo dente, se ne arriverà un altro al suo posto. Forse devo fare una ricerca su internet, a mezzanotte è sempre una buona idea. Leggo che l’umanità si trova in una fase intermedia. La nostra mandibola diventa sempre più piccola, perché dalla Rivoluzione industriale mangiamo sempre più cibo lavorato, ma i denti del giudizio non sono ancora scomparsi. Sono rimasti grandi come migliaia di anni fa. I denti del giudizio non hanno dato ascolto alla volontà evolutiva. Hanno continuato a crescere nel pezzetto morbido di cartilagine dove in realtà non c’era più posto per loro. Eccoli che si presentano, ogni volta che una persona minaccia di diventare adulta, grandi e poco pratici. Un pezzetto di dente da un’altra epoca.
Ancora 27 notti
Sono seduta in ospedale, di fronte agli armadietti dei medici. Mi passano davanti i dottori nei loro camici bianchi. Mi chiedo se non dovrei essere più nervosa. È la prima volta che mi tolgono qualcosa dalla bocca. Mentre affiorano questi pensieri, batto i talloni l’uno contro l’altro. Si apre una porta, forse è il mio turno, esce un dottore che non si è rasato. Ha in mano un seghetto. Scivolo un po’ più indietro sulla sedia. Alle elementari, quando facevamo i lavoretti manuali usavamo delle seghe identiche, molto insidiose. Con una di quelle, Moos si era mozzato un polpastrello. Per sbaglio. Magari, ogni tanto, questo dottore si diverte a camminare per il corridoio con un affare così per terrorizzare i nuovi pazienti. O forse stanno davvero per operarmi con una sega. Si apre un’altra porta.
«Prego, venga avanti. L’ortodontista arriva subito.»
L’assistente indica con un gesto plateale la poltrona del paziente. Mi stende sulla testa un foglio verdognolo, con al centro un buco per la bocca. La luce della lampada attraversa lo strato di plastica, proprio come l’ombra dell’assistente.
«Posso tenere il dente?»
Non riesco a guardare in faccia l’assistente.
«Sì, come no.»
Immagino già il dente sul mio comodino. Magari ogni tanto, le sere in cui non riuscirò ad addormentarmi, lo prenderò in mano passando le dita sui bordi affilati rimasti nascosti per tanto tempo e che adesso possono finalmente mostrarsi. Vivaci e taglienti, proprio come voglio essere io. Oppure una collana, posso anche farmelo mettere in una collana.
«Facciamo un’altra iniezione» dice l’ortodontista.
I miei piedi scavano ancora più a fondo nella pelle della poltrona. L’ago freddo mi punge di nuovo la gengiva, me lo sento scivolare tra i nervi. Un sapore di ferro misto a cloro. Il dolore avanza impietoso fino al cervello, piccole scosse che si accendono su e giù.
La seconda anestesia funziona più in fretta, non sento più niente, solo un immenso scricchiolio che sembra provenire da tutte le parti. Ci sta mettendo tanto, non ne posso più di vedere le ombre che si muovono sopra di me. Il dente ce l’ha messa tutta per essere qui, con le radici affondate nella mia gengiva. Tutto quel tirare non fa certo bene. Forse avrebbe dovuto morire qualcuno per colpa di un dente del giudizio, penso, per far capire all’evoluzione cosa c’era in ballo. Adesso continuano a tornare, perché ogni volta vengono estratti senza troppi problemi. Meglio scacciare questo pensiero, perché magari sarò proprio io a lasciarci le penne per un dente del giudizio.
All’improvviso l’assistente mi preme un impacco freddo contro la guancia. Quando toglie il pezzo di carta che mi copriva la faccia, il dentista è già scomparso. Nella mia mandibola dovrebbe esserci più spazio, invece ho la sensazione che sia tutto schiacciato.
«Il dente è andato in frantumi» dice l’assistente.
Devo concludere da sola che perciò non mi sarà possibile portarlo a casa. Il dente del giudizio è ridotto in tanti pezzi, su un foglio di carta da ospedale verdognolo e insanguinato.
Quando si accorge che lo sto guardando, l’assistente lo raccoglie alla bell’e meglio.
«Arrivederci» dice senza alzare lo sguardo.
Spero che si sbagli.
Ancora 23 notti
Nei primi cinque giorni il gonfiore può aumentare. Leggo per la centesima volta il foglietto informativo che mi hanno consegnato. Poi lo lascio cadere e mi guardo allo specchio. Sul lato destro c’è un rigonfiamento grande quanto il mio pugno e dei capillari rotti mi percorrono la guancia come saette. Tutta la metà destra della mia faccia è ricoperta da un livido bluastro con i contorni gialli. Sembra che mi abbiano pestata a sangue.
Da quando il dentista mi ha operata non dormo più, perché non riesco a sdraiarmi sul lato destro. Il dolore è troppo intenso, è come se qualcuno tentasse costantemente di strapparmi il dente del giudizio. È passato un po’ di tempo, eppure quell’evento continua a ripetersi. Come una punizione da parte del dente, che vuole ricordarmi in continuazione cosa ho fatto. Ogni tre ore prendo degli antidolorifici, prima due compresse di paracetamolo, poi la pastiglia di ibuprofene più grossa sul mercato, e poi ricomincio daccapo. Di notte non serve che metta la sveglia, tanto non dormo per il dolore.
Ancora 22 notti
Forse devo essere io la prima persona a insegnare all’evoluzione che il dente del giudizio non è più il benvenuto. Devo morire per proteggere il resto dell’umanità da notti insonni e guance blu grandi come le montagnole di terra sollevate dalle talpe. Il dolore è troppo grande, troppo presente, troppo pulsante. Il dente frantumato che adesso si trova da qualche parte tra i rifiuti ospedalieri, magari in una discarica, fra tutti gli altri denti frantumati dei giorni scorsi. Sono le 4:03 e telefono alla guardia medica. Risponde una donna dalla voce roca.
«Martedì scorso mi hanno estratto un dente del giudizio e non mi sento bene» dico
con voce tremante.
La donna resta in silenzio.
«Mi fa malissimo, non riesco più a dormire, da giorni ormai, è gonfissimo, non riesco
più a fare niente.»
Adesso che ho ammesso tutto, arrivano le lacrime. Quasi non ricordo le altre volte in cui ho pianto di dolore. Forse quando mi ha punto una vespa, e il dolore che è scattato un paio di attimi dopo mi ha scioccata.
«Uh, poverina» dice. «In questo momento non c’è neanche un dentista, ma posso darti un anestetico fino a lunedì, e poi lunedì vai subito al reparto. Te lo preparo subito.»
«Sì.»
«Perché non è normale avere così tanto male.»
Annuisco e mi escono ancora più lacrime. E lei sente tutto.
«Ce la fai a venire qui?»
Il vento mi agita i pantaloni della tuta, fa più freddo di quanto pensassi. Tiro su del tutto la zip della giacca. Mi fa bene avere un obiettivo. Ignoro i giramenti di testa, la mia missione è raggiungere l’ospedale. Lì mi aspettano quattro pillole di morfina. Ho addosso una maglia idiota che mi aveva regalato un amico. I can’t fuck, c’è scritto. Odio le maglie con le scritte.
In bicicletta ho sudato e appena entro abbasso la zip, ma la cosa non mi dà sollievo.
«Non ci credo» dice il portiere, e mi fa un sorrisetto. Tiro di nuovo su alla svelta la zip. All’accettazione nella sala d’attesa c’è una donna, mi allunga le pillole senza chiedermi un documento.
«Sogni d’oro» aggiunge.
Aspetto di essere di nuovo a letto e prendo la prima pillola. Guardo Sex and the City per non essere troppo consapevole della transizione, ma me ne accorgo lo stesso. Vengo avvolta da una grande foschia e quasi subito precipito in uno stato confusionale che mi fa addormentare. Nel sogno sono dentro uno scatolone, premo le mani più forte che posso contro il lato di sopra, ma non riesco a far muovere le alette. Dormo in questo stato per otto ore. Alle tre del pomeriggio mi sveglio con un dolore lancinante. La prima cosa che faccio è guardarmi allo specchio: la mia guancia è ancora più grossa, la bocca si apre solo di un paio di millimetri. Non solo il dente del giudizio è un reperto di centinaia di anni fa, tutto il mio corpo sta acquisendo una forma medievale. Mando dei selfie ai miei amici, che ridono e mi chiedono altre foto.
Tutti i denti del giudizio che ho ancora in bocca possono restare, mi dico, forse ancora un po’ fatta per la morfina. Siete degli esseri che non si sono adattati e io voglio farvi spazio. Mi allungherò la mandibola, se necessario. Non so ancora come. Una volta un mio amico ha comprato un piede di porco perché perdeva sempre le chiavi della bici. Forse mi può servire a qualcosa. L’evoluzione impara solo dagli orrori, non da qualche pillola di morfina e da un ortodontista maldestro.
Ancora 21 notti
Alle otto e mezzo di mattina mi ricevono al poliambulatorio. Il mio dottore ha il giorno libero. Un altro uomo mi preme molto forte sulla guancia, ho di nuovo le lacrime agli occhi e questa volta anche un liquido grumoso in bocca. L’assistente mi tiene davanti una vaschetta di cartone, nella quale devo sputare. Il dottore continua a premermi i pollici sulla guancia, delle fitte di dolore mi raggiungono nonostante l’ultima pillola di morfina. Dalla bocca continua a uscirmi una roba marroncina. Non oso più guardare dentro la vaschetta, che adesso sembra più pesante. Esco dalla stanza con una ricetta per l’antibiotico e istruzioni su come rimuovere da sola il pus dalla guancia. Non avevo mai fatto tanta fatica a reggermi in piedi.
Non ero riuscita a buttare giù la colazione, non passava per la fessura che adesso è la mia bocca. In farmacia svengo. Il dente sente la mia mancanza. Non penso a questo mentre sono stesa per terra. Quando svieni non pensi a niente, in quel momento non c’è niente. Quando mi riprendo, non ho idea di quanto tempo sono stata assente. Forse pochi secondi, o delle ore, magari addirittura mesi.
Svenire: è così che mi immagino la morte. Quando mi riprendo, vedo una quindicina di teste che ondeggiano sopra di me. Tutte con lo stesso sguardo preoccupato. Il dente sente la mia mancanza, penso quando sono di nuovo stesa sul mio letto. Ho mandato giù la prima pastiglia di antibiotico. Ogni mezz’ora mi spremo il pus dalla guancia. Il liquido mi entra in bocca passando tra il dente e la gengiva. Lo sputo più in fretta che posso in un bicchiere sul comodino. Le ore scorrono lente. Su Instagram la gente fa un giro della città passando per cinque ristoranti, fotografa il cibo in piattini di carta. Piattini di carta fatti dello stesso materiale della vaschetta per sputare all’ospedale. Altri si scattano selfie con i figli appena nati, in alcuni il bambino tiene in mano una bottiglia di birra. Io voglio vedere tutto.
«Sei sul pezzo» dice Instagram.
Su Twitter sono tutti indignati. Oppure non dicono niente, ma ritwittano qualcosa e ci
piazzano sopra un «Ecco!».
Ancora 7 notti
Chiedo a un amico quando finirà il dolore e lui mi dice che non me ne accorgerò, che uscirò di casa e di colpo mi renderò conto che il dolore se n’è andato, che non lo sento già da un paio d’ore e non ci ho fatto caso. Mi aggrappo a questo pensiero. Ho ricominciato a mangiare patatine, anche se ho ancora paura che qualcosa resti bloccato nel buco che ho in fondo alla bocca. Dopo ogni pasto, spuntini compresi, appoggio una siringa nel punto in cui c’era il mio dente del giudizio. Premo dell’acqua nel buco, per tenerlo pulito. L’assistente mi ha detto di fare così.
Il giorno dopo l’ultima notte
L’amico aveva ragione. Il dolore se n’è andato, di colpo non ne sento più la presenza. Non riesco più a infilare la siringa nel buco, la gengiva si è richiusa. Nello specchio vedo che si è formata una sporgenza rosea dall’aspetto sano. Nel punto dove si trovava il dente del giudizio adesso c’è una lapide, un cimelio da un’età della pietra che avrei preferito continuare a portare con me.