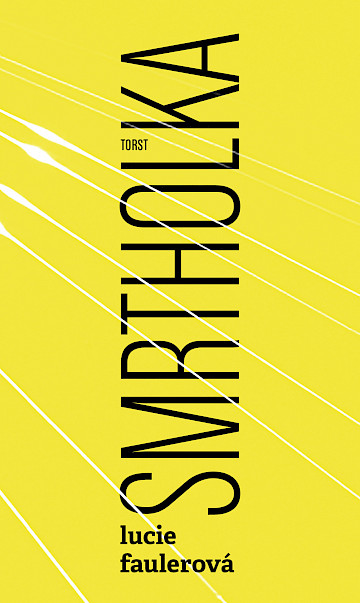Deviazione.
Il suicidio per strangolamento è un evento abbastanza raro. Solitamente il laccio viene avvolto ripetutamente intorno al collo, a volte utilizzando anche un oggetto morbido. Nello strangolamento, a causa della sollecitazione del nervo pneumogastrico e dello schiacciamento della carotide, il flusso di sangue diretto al cervello si arresta e le vie respiratorie si bloccano. Solo la laringe di solito non si chiude del tutto, per questo la morte risulta più lenta che con l'impiccagione (a meno che non si perdano i sensi e che il laccio non si allenti).
L'impiccagione è invece da sempre il metodo preferito dai suicidi nella Repubblica Ceca. Soprattutto tra gli uomini, tra i quali se ne impiccano circa 61 su 100, mentre tra le donne solo 40 su 100.
Se non si ha la fortuna di rompersi l'osso del collo, la morte sopravviene all'incirca in dieci minuti. Questo metodo per suicidarsi ha un'elevata efficacia, ma se si viene salvati, ci sono notevoli probabilità di riportare danni al cervello.
Sono rimasta sorpresa dal fatto che l'impiccagione offra una gamma di realizzazioni pratiche molto più vasta di quanto si possa pensare. Un professore, nel XIX secolo, ha contato 261 posizioni diverse nelle quali i suicidi si impiccano. In 168 casi toccavano con i piedi a terra, in 42 casi erano inginocchiati, in 22 casi erano distesi per terra, 19 erano seduti e gli ultimi 3 accovacciati. Naturalmente l'oggetto più utilizzato è la corda, seguito da cravatta, fazzoletto, biancheria strappata, lacci delle scarpe, giarrettiere, cinture, cavi elettrici oppure cinghie.
Laccio, una parola che non sarò più in grado di pronunciare.
A volte penso alla determinazione, al rifiuto di vivere o meglio alla voglia di non vivere degli impiccati che vengono ritrovati accovacciati.
Zzooomm.
«Sapete perché oggi sono proprio qui?», chiede l'uomo con la camicia bianca, che si trova nella parte anteriore della palestra, ai piedi del podio.
«Perché?», gli chiede la donna col vestito giallo, accanto a lui. È la moglie. La coppia sta infatti mettendo in scena il dialogo tra il mentore (lui) e il pubblico (lei), perché se c'è una cosa di cui non si può mai essere sicuri, è proprio il pubblico (noi).
«Questa seduta ha un unico scopo: infondervi coraggio!»
«Coraggio per fare che cosa?», gli chiede la donna col vestito giallo, alzando la voce. Madla, seduta accanto a me, si infila l'intero pugno in bocca.
«Il coraggio di vivere la vostra vera vita!», annuncia l'uomo con la camicia bianca. Sta iniziando quello che dovrebbe probabilmente essere il momento catartico, nel quale si attende la reazione eccitata del vero pubblico. Mi guardo in giro e osservo le altre persone nel semicerchio di sedie: tanto per cambiare i due terzi sono donne.
Nessuno reagisce, allora la donna col vestito giallo fa di nuovo le veci del pubblico e si mette ad applaudire. A questo punto applaudiamo anche noi.
«Avete mai sentito parlare della tecnica hawaiana dell'Ho' oponopono?», chiede l'uomo con la camicia bianca. Silenzio. «Prima di dirvi qual è l'origine di questa tecnica, vi svelo la cosa principale. La cosa più importante! Siete pronti?»
«Sì», risponde trepidante la donna col vestito giallo.
«Allora ascoltate con attenzione. Ma davvero... con attenzione», scandisce lentamente, «è la cosa più importante che sentirete qui oggi. Quella che potrebbe cambiare la vostra vita.»
Ora siamo tutti in silenzio, aspettiamo ansiosi, vogliamo cambiare la nostra vita.
«Ti amo», dice l'uomo con la camicia bianca, con lo sguardo rivolto verso la signora Starostníková. «Ti chiedo scusa», aggiunge poi, osservando la signora Boháčková. «Ti chiedo perdono», dice facendo un cenno con la testa al signor Boháček. «Ti ringrazio», dice con lo sguardo fisso su Madla, che estrae il pugno dalla cavità orale.
Segue un nuovo, breve momento di silenzio. Qualcuno si schiarisce la gola, qualcuno si dimena, la signora Starostníková si afferra il doppiomento. La donna col vestito giallo ha assunto un'espressione criptica.
«È vero che in queste frasi non c'è niente di strano? Le pronunciate quasi ogni giorno, non è così?», chiede l'uomo con la camicia bianca.
«Certo che sì», risponde la donna col vestito giallo.
«Queste quattro frasi, queste frasi apparentemente così comuni, possono però contribuire alla purificazione del nostro subconscio. Grazie ad esse potete liberarvi dei meccanismi nascosti che ci governano e ci impediscono di portare a termine la nostra missione in questo mondo. E sono sempre questi meccanismi a impedirci di realizzare i nostri desideri. Grazie a queste quattro frasi possiamo raggiungere il così detto stadio zero, ovvero lo stadio in cui non esiste nulla e tutto è possibile. In questo stadio non ci sono pensieri, parole, ricordi, non ci sono convinzioni. Non c'è niente. È lo stadio del vuoto, lo stadio che la gente cerca di raggiungere in diversi modi già da secoli, da millenni.»
L'uomo con la camicia bianca vorrebbe suscitare l'impressione di parlare a braccio, ma si vede che sa perfettamente cosa sta dicendo, probabilmente lo ripete spesso. «Sapete cos'è lo stadio zero? No? È lo stadio dell'amore puro, senza limiti. Tutti noi qui abbiamo una lente attraverso la quale osserviamo il mondo, solo che questa lente è ricoperta di sedimenti. Sapete cosa voglio dire. Pregiudizi, illusioni, ricordi, schemi comportamentali preconfezionati, è necessario liberarsi di tutto questo. Bisogna spazzarli via. E se continueremo a spazzarli via, entreremo in uno spazio che può essere definito un mondo senza frontiere...» Madla inizia a canticchiare sottovoce la sigla di Giochi senza frontiere. «...allora troverete il vostro vero Io, vi libererete dell'energia negativa e attraverso il vostro corpo scorreranno soltanto pensieri e parole puri. Ma perché proprio queste quattro frasi? Ti amo. Ti chiedo scusa. Ti chiedo perdono. Ti ringrazio. Perché siamo intrisi di negatività e di emozioni negative. Che causano la nostra instabilità! Le malattie! Solo attraverso un processo di penitenza e di perdono, e grazie al cambiamento che ne conseguirà, saremo in grado di liberarcene. Questo è l'Ho' oponopono.»
L'uomo con la camicia bianca aggiunge che, grazie all'espressione "Ti amo", ci congiungiamo con il creatore, che l'essenza è amare ogni cosa, anche i propri chili di troppo, anche tutti i pensieri pazzi che ci vengono in mente, dobbiamo essere in grado di dire "vi amo, cari pensieri, vi amo, chili di troppo". L'uomo con la camicia bianca dice che attraverso le parole "Ti chiedo scusa" riconosciamo che un virus è entrato nel nostro sistema e non chiediamo al creatore di perdonarci, ma di aiutarci a perdonare noi stessi. L'uomo con la camicia bianca prosegue dicendo che, se chiediamo perdono, chiediamo al contempo di trasmutare l'energia negativa in luce, chiediamo di trasformare il nostro subconscio in vuoto, per poter scoprire così il nostro vero io, poiché è possibile trovarlo solo nello stadio zero. Quando diciamo “Grazie”, continua l'uomo con la camicia bianca, esprimiamo al creatore la nostra gratitudine e la fiducia nella nostra futura purificazione. L'uomo con la camicia bianca dice che l'Ho' oponopono non è il concetto di vita di McDonald's, dove ritiriamo alla finestrella il cibo pronto, perché il creatore non è un servo, afferma. È necessario pulire, pulire, pulire, cancellare, trovare il proprio Shangri-La, pulire, cancellare, pulire.
«Non si farebbe prima con un lassativo?», mi chiede Madla, chinandosi.
«E che cosa credi che sia questo Shangri-La», le rispondo.
«Ammazzami», sussurra ancora Madla. «E ti ringrazierò, davvero».
L'uomo con la camicia bianca conclude che adesso canteremo, che le persone in tutto il mondo cantano la stessa cosa, che forse cantandolo capiremo il processo di purificazione. La donna col vestito giallo va a prendere la custodia con la chitarra. Madla si rinfila lentamente il pugno in bocca.
L'uomo con la camicia bianca suona la chitarra e, insieme alla donna col vestito giallo, ripete di continuo quelle quattro frasi, fino a che arriva il momento del ritornello (Ho' oponopono, Ho' oponopono ecc.), nel frattempo cercano di stabilire un contatto oculare con il pubblico (noi), per incitarci a unirci al loro canto.
Guardo attentamente gli abitanti di Mršina seduti in semicerchio. Osservo quelli che hanno gli occhi chiusi e sorridono, quelli che hanno le lacrime che scendono lungo il volto, osservo quelli che invece hanno lo sguardo assente fisso nel vuoto, quelli che cantano senza vergognarsi e anche quelli che si uniscono titubanti, osservo la signora Bartáková che si toglie la sporcizia dalle unghie. Solo che in quell'istante, nel ritmo hawaiano della canzone dell'amore, del perdono, delle scuse e dei ringraziamenti, in quel ritmo della canzone sulla ricerca del senso della vita, nella canzone con la quale ci stiamo purificando, un terrorista irrompe nella palestra. Per prima cosa corre dalla signora Bartáková e le taglia la mano con un machete, proprio la mano nella quale si stava spiluccando la sporcizia dalle unghie. Poi corre dalla signora Starostníková e le infilza il doppiomento con un uncino. Il sangue schizza sulla camicia bianca dell'uomo con la camicia bianca, ma lui continua a pizzicare la chitarra, solo il sorriso gli si raggela un poco. Arrivano di corsa altri terroristi, sono come minimo dieci, due di essi hanno addosso una bomba. Per un momento però si fermano, ascoltano, iniziano a dondolare al ritmo della canzone, canticchiano la melodia insieme all'uomo con la camicia bianca e alla donna col vestito giallo. Poi però prendono coscienza del proprio io, del senso della propria vita, ringraziano il loro creatore e ci intimano di sdraiarci a terra. Urlano, sventolano le armi, sparano alcuni colpi, tutti noi piagnucoliamo, ci lanciamo delle occhiate atterrite, abbiamo paura di morire. Qui e ora. Non faremo più ritorno a casa. Moriremo qui. Finirà. Così. E in quel momento stringiamo dentro di noi un compromesso, perché in quell'istante comprendiamo quali sono le cose che contano veramente. La signora Bartaková, per esempio, sa quanto importante sia una mano, prima d'ora non ci aveva mai pensato. Tutti all'improvviso sanno quali sono le cose importanti e quali sono le cose meno importanti, tutti vorrebbero trovarsi in un posto diverso, ognuno ha in testa un posto concreto e ognuno ha in testa persone concrete in quel posto concreto. I terroristi spaccano la chitarra in testa all'uomo con la camicia bianca e vanno via, ci lasciano in vita poiché si sono resi conto che in questo paesino siamo pericolosamente vicini allo stadio zero.
E così siamo tutti vivi, certo soffriamo di shock post-traumatici e a letto ce la facciamo sotto, ma tutti ne abbiamo tratto beneficio, solo dopo quest'esperienza viviamo per davvero. Un anno buono, due. Amiamo, ci scusiamo, chiediamo perdono, ringraziamo.
E poi, dopo due o tre anni... ci metteremo a raccontare che quella volta a Mršina siamo stati assaliti dai terroristi in palestra, durante il corso di Ho' oponopono. Lo racconteremo per tutta la vita, quella che ci resta da vivere, a tante persone. «È stata un'esperienza davvero spaventosa», racconteremo alla festa di Natale, con un bicchiere di spumante in mano. E poi torneremo a casa, ci siederemo al computer, davanti a una lettera motivazionale buttata giù a fatica, cliccando nel frattempo su altri venti annunci di lavoro su jobs.cz, perché il nostro lavoro inizia a essere monotono e non ci sono possibilità di crescita, un'occhiata smarrita nel frigorifero pieno, delle chat iniziate con cinque tipi su Messenger, perché chiunque potrebbe essere la persona giusta, ma chi è veramente? Chi? Un altro cerchio fatto appoggiando la tazza sul tavolo, «ma quante volte te lo devo dire che devi prendere un sottobicchiere?», guardandoci nello specchio del bagno ci afferreremo i rotolini di grasso della pancia, «da domani smetto di mangiare!», prima di coricarci spediremo l'ultimo bacino bacino bacino e mi manchi e una faccina triste e, prima di spegnere la luce, manderemo un bacio anche a quella che dorme accanto a noi, “eh già, immaginati che hanno di nuovo rincarato il prezzo del burro, da non crederci!».
Trantran.
Al posto del finestrino del treno vedo la porta del bagno socchiusa. Papà è in piedi davanti allo specchio, sta sciacquando il rasoio nel lavandino pieno d'acqua e al tempo stesso canticchia Our House di Crosby, Stills and Nash.
Prima pensavo che mio padre fosse una sequoia. La più grande del mondo. Come Hyperion, un albero alto quasi 116 metri. Solo che lui, dopo la morte di Madla, ha iniziato a sprofondare verso la terra. La corteccia si è ingrigita, i rami si sono incurvati e io non ho più trovato in nessun'enciclopedia un albero degno di dare il nome a mio padre.
Scatolina scatolina.
«Scatolina», sussurrano le ruote del treno, sussurrano come dei perfidi folletti, ridacchiano sussurrando mentre io guardo il cimitero dalla collina. Tutt'intorno svolazza la lanugine.
Sembra che stia nevicando dai pioppi, e la bara di Madla è piccola in un modo talmente assurdo che non riesco a distoglierne lo sguardo. Dico sottovoce ad Adam che lei non può esserci entrata, Adam mi copre la bocca con le dita perché la mia voce si sentiva. Ma ho ragione io, là dentro o l'hanno spezzata oppure è in qualche modo rannicchiata. E più il pretino parla, più la cassa di legno si rimpicciolisce, forse alla fine lì dentro Madla davvero non c'è! Il pretino alza un po' la voce, poiché in alto, oltre la chiesa, sta passando il mio treno. Giro la testa verso la collina e immagino di essere seduta in treno e di sfrecciare via, sono in viaggio, non sono qui, sono in viaggio, qual è la meta, la meta potrebbe essere il viaggio, si sa, si sa da molto tempo, lo si canta perfino. E quando calano il corpo di Madla nella buca scavata nella terra, la bara di legno assomiglia più che altro a una di quelle scatoline delle gioiellerie, la scatolina di un anello piuttosto piccolo, una scatolina che potreste tranquillamente rinchiudere nel palmo di una mano e far sparire nella manica. Come una magia. Bibidi bobidi bu.
Scuoto via la lanugine dal vestito.
Scatolina, scatolina, scatolina, sussurrano le ruote. Il treno prende velocità sferragliando. Ci facciamo strada attraverso una coltre bianca.
Trantran.
Penso sempre a Madla. Rotaie senza via d'uscita. Un tunnel senza fine.
Una pagina vuota in un libro.
Uuu-sc-sc-sc.
A volte, quando il signor Rochester porta in negozio un nuovo mobile, che ha appena terminato, resta un momento lì accanto e lo osserva da diverse angolazioni, poi si ferma accanto a uno degli spigoli e mi osserva a lungo, credo che voglia chiedermi che cosa ne penso, e forse me lo vuole chiedere solo per evitare quel silenzio imbarazzante, non perché gli interessi per davvero. Me l'ha chiesto una volta sola: «Che ne dice?», poi, resosi conto che non rispondevo, ha aggiunto «non è male, vero?». E io ho scosso la testa come a voler dire che non era male, e forse mi sono messa un po' a ridere quando ho trovato il coraggio di avvicinarmi a quella cassettiera e di accarezzarne gli spigoli.
«Me ne hai dato di filo da torcere», ha detto accarezzando pure lui la cassettiera. L'ha accarezzata a lungo con la mano e poi le ha dato una pacca.
Sono una cassettiera e il signor Rochester mi accarezza la schiena. Dall'alto verso il basso.
E poi mi dà una pacca.
Mi guarda sorpreso mentre ridacchio come una stupida adolescente e arrossisco come una stupida adolescente. Scuoto la testa come se volessi scacciare quel momento imbarazzante.
Sorride.
Vorrei abbracciarlo.