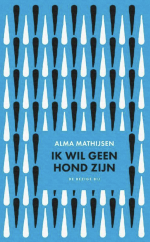Il mulino, il sentiero che porta al fiume, il pozzo, i cavalli, le mucche e il grano. I secchi crepati colmi di pomodori rosso sangue, i barattoli da conserva ben chiusi con le verdure messe sottaceto per l’inverno. Lo stretto corso d’acqua del Severski Don, che cuce i campi uno all’altro, stringe la Russia all’Ucraina, tiene insieme la cartina come fa il mio bisnonno Nikolaj con le giacche che impuntisce con ago e filo. Il vento nelle vele del mulino, le ragazze del komsomol sulla piazza centrale del paese.
Ballano. Si prendono a braccetto, si tengono in equilibrio l’una con l’altra inclinando i corpi di lato e slanciandosi da terra giusto con la forza necessaria. Il mulino quasi non emette suoni, il meccanismo di legno cigola una volta sola. Poco più in là, il mio bisnonno Nikolaj cammina per il campo di grano. Tiene le spighe tra le mani, strappa un pezzo dello stelo, ne stacca qualche chicco che poi si mette in bocca. Fa scrocchiare il grano secco e sente il sapore della terra in cui cresce mia nonna: dolce e amaro. Mastica, ascolta gli animali, il grano nel vento. Guarda il suolo nero sotto i suoi piedi – questo lembo di terra così fertile da sfamare l’intera Unione Sovietica e per il quale si combatterà sempre. Eccolo lì, il mio bisnonno nel campo dorato, sotto il cielo limpido.
Più mi avvicino al luogo in cui è nata mia nonna, più il cielo della sua gioventù si fa di un azzurro intenso. A ogni chilometro che mi allontana dalla mia terra natia, le buche nell’asfalto diventano più grandi. La gente ci infila dei lunghi rami, per impedire incidenti mortali con la macchina, e ogni tanto spunta un girasole che si allunga solitario. Conto sempre più case diroccate, finché non sfioro con le punte delle dita i fori di proiettile nella staccionata della mia prozia Nina. Imparo che l’azzurro può essere tutto: che gli occhi azzurri delle mie prozie si trasformano in graffianti e impenetrabili lastre di ghiaccio quando si parla di politica, sono cime di montagne che diventano ghiacciai scivolosi quando loro piangono e imprecano.
Mentre mangiamo, nei loro occhi tutto si calma come i laghi del Caucaso: un panorama sereno e piacevole, dove ci si sente al sicuro. Una volta, la mia bisnonna Anna affermò che gli occhi di tutte le sue figlie e di tutti i suoi figli sarebbero stati azzurri come il cielo sopra la campagna ucraina. Ogni figlio che nacque le diede ragione. La sua prima figlia, Anastasiia, venne al mondo con gli occhi più azzurri di tutti. Il suo sguardo spiccava intenso in ogni ambiente in cui veniva portata.
Anastasiia emanava luce, persino durante i suoi ultimi giorni sul letto di morte, quando un ragazzo di Lugansk andò a chiedere la sua mano e fu impossibile staccarlo da lei. Quando la mia giovane nonna venne spedita fuori, perché non fa bene vedere un morto se si è così piccoli.
A 2.722 chilometri dai campi dove Nikolaj tiene tra le braccia per la prima volta la figlia Anastasiia, appena nata, Folkert Jan mi fa salire a bordo della sua nave. Tra la banchina e il ponte scorre la Beneden-Merwede, sopra di noi sono sospese le nubi olandesi con il cielo sbiadito sullo sfondo, un cielo che non contrasta mai davvero con il paesaggio, che non diventa mai di un azzurro pieno e acceso, ma cerca sempre di amalgamarsi educatamente con tutto. Sento la pelle pulsare per l’umido caldo olandese, che mi avvolge come un panno appiccicoso già da alcuni giorni. Sulla coperta di ferro della Semplonius I , dipinta di bianco e nero, il caldo non fa che aumentare. Folkert Jan osserva a braccia incrociate la sua nave portacontainer lunga 192 metri e dice: «E insomma eccoti qua. Be’, benvenuta». Ha la faccia ricoperta di lentiggini, i capelli rossicci brillano al sole.
«Sai che per quattro giorni non puoi scendere, eh?» scherza.
Sposto lo sguardo verso il ragazzo mingherlino con una tuta da lavoro arancione, che sta lavando il ponte con un getto d’acqua, e verso il filippino minuto, che è appena saltato giù dalla nave e beve un caffè da un bicchiere di carta, sul molo della stazione di rifornimento. Ci scambiamo un cenno di saluto.
«Questa è una nave tranquilla» dice Folkert Jan, «con persone cortesi. Su certe navi non si va per il sottile, gli uomini sono un po’ spacconi. Lì, di solito, nessuno si ferma a dormire.»
Mia madre, con le mani sui fianchi, se ne sta sulla banchina a guardare i container, infilati a quattro piani di profondità nel ventre della nave. Il suo sguardo li passa in rassegna, la vedo contare annuendo: quattro in altezza, quattro in ampiezza, undici in lunghezza. Avanzo lentamente dietro Folkert Jan, verso l’altro lato della nave.
La prima volta che tornano insieme nella Madrepatria, mia madre e mia nonna nuotano nel Severski Don.
«Non è lo stesso fiume» dice mia nonna dopo che sono state sballottate dalle onde per un po’, «sembra anche che ci siano meno colline, che sia stato spianato tutto».
È l’estate del 1973, Stanitsya Lugansk è calda e polverosa, la zia Nina ha teso un telo tra la casa e il capanno per fare ombra. Mia madre parla russo a stento, ma dalla bocca di mia nonna rotolano fuori all’improvviso dei suoni pieni e altisonanti.
Un russo fluido e impeccabile che mia madre, a casa in Olanda, non aveva mai sentito parlare con tanta generosità. Adesso sente solo russo, tutto il giorno. Per mia madre significa un infinito lavoro di mani e piedi, che a ogni sorso di vodka le riesce meglio. Una sera dopo l’altra, lei e mia nonna devono andare in visita da qualche parte, per sedersi anche loro sotto un telo teso in un grande giardino, a una lunga tavolata piena di cibo, succo fresco e vodka. Si siede tra cugini di cugini, accanto a ragazzi e ragazze che si definiscono suoi fratelli e sorelle – come mio cugino Maksim non è mio cugino, ma mio fratello, una parola che mi dà subito una sensazione di vicinanza. Mia madre si ritrova sul piatto delle fette di cocomero giganti, talmente grandi che ci può infilare tutta la faccia. Il succo rosso del cocomero è più dolce che a casa, rinfresca il suo corpo surriscaldato. Il cibo in tavola è più grasso, più pieno, i pomodori non hanno un sapore acquoso, ma sanno di caldo e di estate, la vodka è pungente e fredda. Mia madre stona nei suoi jeans, e con il passare delle settimane indosserà sempre più spesso abiti a fiori, diventando a poco a poco un tutt’uno con le sue sistri e zie, con la nonna Anna, che pela patate sulla sua sedia in giardino, sotto il melo. La nonna getta le patate nella pentola e posa le bucce nel grembiule che tiene sulle ginocchia. Mia madre si domanda se si farà mai mettere un dente d’oro, come le sue zie, le cui bocche risplendono all’ultima luce della sera quando ridono.
La Semplonius I parte. Mia madre è tutta sola sul molo della stazione di rifornimento e mi saluta con la mano finché non sparisco dalla vista, come fa mia nonna quando lascio il suo appartamento nella casa di riposo. Nella nostra famiglia si saluta fino a che non si è girato l’angolo, fino a quando non ci si vede proprio più. Da noi si suona il campanello due volte per far sapere che si è “di casa”. Appoggio la borsa nella mia cabina e apro la finestra sopra il letto. L’acqua scivola via in silenzio. I ciclisti corrono sulle dighe, i mulini raccolgono vento e le pale girano in cerchio.
«Ancora circa 500 chilometri fino a Mannheim» dice Edwin dalla cabina di comando, «e navighiamo grossomodo a 10 chilometri all’ora, quindi calcola un po’ tu».
Sul braccio ha un tatuaggio che si legge sia come EDWIN che come EDMIN, la M e la W sono tatuate una sopra l’altra. Tra due giorni mi racconterà che è stato solo un errore, quella M, che per un periodo, tra i suoi amici, è andato di moda farsi tatuare il proprio nome sul corpo a caratteri gotici. Io gli porgerò l’avambraccio per mostrargli il nome di mia nonna, Александра: Aleksandra. È scritto con la sua grafia.
Edwin preme un pulsante. Lentamente ci alziamo in aria con cabina di comando e tutto, fino a che non siamo più alti dei container. Vediamo la punta della nave, io riesco a vedere il fiume. Passiamo sotto ponti che da bambina attraversavo in macchina, seduta dietro, lungo argini su cui d’estate andavo in bicicletta con i miei genitori.
Dal ponte di poppa guardo il sole che sprofonda poco a poco nel paesaggio lasciando strisce rosse nel cielo, appoggia sull’acqua lunghi fasci di luce, come macchie di acquerello sulla carta. La bandiera olandese si agita al vento, a volte si ripiega su se stessa, altre si distende. Uomini su sedie da pescatore fanno cenni di saluto, coppie di una certa età fermano le biciclette per guardare la nave. Dal fiume tutto sembra rallentato, il tempo è diverso, la vita prende un altro ritmo. Quando naviga qui negli ultimi giorni dell’occupazione dell’Olanda, mia nonna vede accadere lo stesso: anche se sulla riva è stato fatto saltare in aria tutto, in acqua sembra che non sia successo nulla, è silenzioso e sicuro. La vedo passare, ci incrociamo, l’acqua del fiume tra la Semplonius I e la sua nave si increspa, spumeggiante. Lei è diventata magra, ossuta. Indossa una camicia bianca e una gonna a tubo. Ha le braccia e le gambe scure, le guance rosse. Dà i pannolini di tela di Peter a suo marito Kees, che sporge con la pancia dal parapetto della nave. Kees lava i pannolini in acqua sfregandoli con un pezzo di sapone, li strizza alla bell’e meglio contro il fianco della nave. Io non dico niente, non invoco il nome di mia nonna (Sasja, per gli intimi) sull’acqua che si frange, guardo soltanto. Le sue mani sottili che passano tra i capelli del piccolo Peter, tra i suoi riccioli pettinati di lato con la cera, che lui da ragazzo cospargerà con ancora più cera, e drammatizzerà quell’aspetto andando in moto a tutto gas lungo il fiume Merwede. Mia nonna guarda il fiume alle sue spalle con soddisfazione e sollievo, e rivolge davanti a sé gli occhi di un azzurro limpido e brillante, con un sorriso accennato sul viso. Andiamo a casa, diciamo io e lei all’acqua. Lascio il ponte di poppa solo quando scompare dalla vista, quando il fiume descrive un’ansa e il cielo della sera si fa blu.