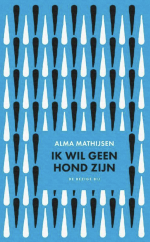Quella sera mi chiamava, e non sembrava avere alcuna intenzione di smet tere.
‒ Mamma. Mamma!
Lo diceva così, offrendolo a me e alla stanza mentre questa si ritirava in un’oscurità di cera, piena di giocattoli (la sua unica proprietà). Strillò ancora, molto più forte, e allora distolsi lo sguardo e accarezzai il bicchiere di whisky, proprio sul fondo, finché l’umidità non passò sulla punta del mio dito.
La parola era ben cucita al suo cervello fin da quando era piccolo. Rimasi immobile a guardare la forma iridata e caparbia della goccia. Non era certo un crimine lasciare che imparasse a sentire il freddo, a man darlo giù. Immaginavo la sua lingua che si tendeva, l’eccesso di saliva mentre diceva con chiarezza chi ero in questa casa, mamma, mamma, mamma; quella preghiera soffocata, quella supplica all’unico Dio che co nosceva veramente. A volte, da quando era nato e l’avevo tenuto in braccio, avevo desiderato che mi guardassero occhi diversi. Essere semplicemente una sconosciuta che si allontana da tutto, ma che allo stesso tempo si ri flette, per un istante, nelle pupille di chi la guarda. Non mi chiamava mai con il mio vero nome. Di nuovo un’altra supplica, mamma, vieni, la goccia tesa e affilata sulla punta del mio dito, mamma, mami, che si allontanava. Ora, quella parola correva da me con un suono umido; quante volte era di ventata quasi un gemito per colpa della febbre o per un piede rimasto inca strato uscendo dalla macchina.
‒ Vieni, – ripeté. – Sta parlando con me.
Mi tappai le orecchie. Riconoscevo il dolore. Poi fissai lo sguardo sul tavolo di legno dove mangiavamo (a volte con le mani, come nei film che piacciono a lui; dove gli scoiattoli parlano con eloquenza greca tra i rami di una grande quercia e spaccano le noci con la mandibola, hanno i denti piatti, enormi; poi sconfiggono un cattivo). C’erano tre sedie distanti. Avevano un design industriale, di colore nero, e brillavano parecchio alla luce della lampada. La mia sedia, quella di mio figlio e la sedia di fronte. Soltanto Adrián giocava nel salone. La terza doveva averla allontanata lui. Mi avventai di nuovo contro il bicchiere, sempre più freddo. Forse leccai il fondo mentre cercavo di capire. Un’intuizione vibrava dietro quell’imma gine; il fatto che la terza sedia, allontanata dal tavolo della sala da pranzo, fosse un dettaglio reale. C’era qualcosa di strano nel modo in cui era dispo sta, come se qualcuno si fosse appena seduto lì a parlare con me; a dirmi… non riuscii a completare il pensiero.
‒ Mamma, vieni, - ripeté.
‒ Dormi, Adrián. Voglio stare sola. Passo già tanto tempo con te. ‒ Ma…
‒ Ti ho detto di dormire.
Sentendomi, doveva essersi coperto la faccia con il piumone, quello con gli aeroplani, fino a non lasciar passare l’aria. Non si zittì questa volta. Era strano. Era sempre stato un bambino obbediente, con i denti separati e bianchi. Gli si vedevano al buio. Non vomitava nemmeno quando aveva la febbre.
‒ Mi sta parlando.
Mentre bevevo tremavo ancora, e premevo il bicchiere contro il petto. La pelle dei polpastrelli stava diventando bianca, esangue. ‒ Chiudi la bocca, su. Stringi bene i denti.
Inchiodai la voce nel corridoio, nella palla sgonfia, in tutti i suoi pu pazzi di guerrieri mutanti ammassati in una specie di fossa (una volta avevo bevuto e, prima di chiudere la porta della sua camera, gli dissi di staccare la testa a tutti i pupazzi e di farmeli vedere). Chi mai gli avrebbe parlato? Il sapore acido e intenso del whisky faceva sì che la mia testa girasse attorno al cuore di quella frase. Si ramificava e si apriva sempre di più. All’improvviso era come se mio figlio mi potesse contagiare fino a provocarmi dei lividi, e poi, come se vedessi accanto a me uno dei suoi amici invisibili. Seduto, senza muoversi.
‒ Chiudi quella boc...
Inchiodai la voce alla porta della sua camera e la ritorsi in modo da non farmi chiamare più. Mi rimaneva quasi mezza bottiglia. Ma lui conti nuava a pregarmi di andare lì. Non avrebbe smesso. Forse non poteva, e ora il suo corpo era malato di quel verbo. Vieni nei muscoli, dietro gli occhi. Vieni, mi sta parlando, riempiendosi di sangue. Avevo troppa nausea, così mi alzai, feci un respiro profondo e mi rivestii di nuovo con la parola. Bevvi ancora per spegnere la luce.
‒ Mamma.
Dicendola ad alta voce, con la nausea, mi sembrò fin troppo flebile. Si era deformata. Per strada non passava nemmeno una macchina. Mi sembrò di distinguere degli uccelli immobili, inchiodati ai rami dell’acacia di fronte. La nebbia si attaccava alla finestra come una lingua. Era solo una via vuota in cui piombava giù la parola mamma, e io non potevo andarle dietro, per poco non potevo seguirla o correrle dietro. Dovevo rimanere rinchiusa lì con lui. Passai accanto alla terza sedia e accarezzai lo schienale. Espressi un desiderio. Una crepa in mezzo alla casa.
Continuai a camminare, addentrandomi nel corridoio con mag giore difficoltà. All’improvviso, pestai qualcosa di duro e inciampai. Colpii l’angolo della parete. Riuscii a non cadere. Di sicuro era un pupazzo. Quando si ruppe, lo scricchiolio bianco della plastica mi si arrampicò lungo la gamba.
– Mamma sta arrivando, – dissi ad alta voce, e mi misi a ridere da sola. – È molto vicina.
Mi fermai di nuovo e guardai le nostre foto appese alla parete. In alcune passavo il braccio sulle spalle di Adrián, dolcemente, e non sem bravo mamma, mamma, mamma. La sensazione di prima mi spuntò più forte in gola. Si insinuava. Vieni. Ma non riuscivo a smettere di guardare le foto. Sembrava come se, in quei luoghi dove avevamo chiesto a qualche persona del posto di fotografarci – il paese dove trascorrevamo le vacanze, la sua foschia, gli occhi dietro le tendine – avessimo lasciato anche uno spazio, sempre a sinistra, per qualcun altro. Accanto alle cornici, trovai dei segni di matita rossa e gialla. La punta aveva lasciato delle incisioni sulla parete. Erano disegni di Adrián. Le teste dentate di un gruppo di bambini, probabilmente. E io ero tra loro? Non possono vederti, Clara. Le nostre immagini si confondevano con i disegni distorti dei bambini, a matita. Aveva disegnato ognuno con un colore, senza volto, con le braccia a forma di palo e le gambe come spirali, uncini, punte. Voleva che entrassero nelle nostre foto? Erano molto vicini. Arrivai fino alla cucina e aprii la finestra per guardare la nebbia e lasciare che si posasse sul bordo.
Quando entrai nella sua camera, il suo modo di strillare era cam biato. Non appena mi vide, sulla soglia della porta, si tolse il piumone dalla faccia. Si scoprì solo gli occhi e il naso. Mi sussurrava qualcosa con un filo di voce, ma non capivo cosa volesse dirmi.
‒ Che hai fatto alla parete? ‒ dissi.
Strinsi il pugno. Tremavo, e non mi importava che mi vedesse così. ‒ Sono miei amici.
‒ Quelli non sono tuoi amici. Devi fare meglio le linee della faccia. Forse era il momento di approfittarne e di iniziare a trattarlo da adulto. So che una madre non deve mai brindare davanti a suo figlio. Io l’ho fatto.
L’asciugamano copriva la staffa sul muro, di fronte al letto. Avevo si stemato la sua camera in modo che non mi infastidissero i suoi giocattoli e, soprattutto, la faccia dell’orso che avevo appeso lì quando aveva quattro anni. Tempo fa gli avevo insegnato a coprirla non appena finiva di giocarci. Di solito mi chiedeva di toglierla da lì, quando faceva gli incubi. In uno, mi raccontò, il dentista gli strappava i denti, uno ad uno, e nei buchi metteva i colori a cera. Dopo mi supplicava di rimettergliela, e quindi era l’orso il vero monarca della camera. Era come se coprendolo con il telo, gli strap passi l’unico frammento di bellezza.
Questa volta tolsi l’asciugamano dai ganci e mi misi a ridere strin gendo forte il bicchiere. Bevvi. Gli accarezzai il muso. Aveva una di quelle facce da animale ridicole, in cui il naso e la bocca erano di dimensioni esa gerate. Il fabbricante gli aveva tolto tutti i denti, credo per una preoccupa zione totalmente assurda: che avrebbero spaventato il bambino. L’interno della bocca era una pura massa di plastica rigida, simile a stucco insangui nato. L’orso rideva. Entrambi ridevamo. Non lo ricoprii.
‒ Perché non dormi?
‒ È che non smette di parlarmi.
‒ Gli orsi non parlano, Adrián. Non hanno la lingua.
Ma non guardavo l’animale mentre lo dicevo. La nebbia copriva quasi tutta la strada, un intestino che usciva dall’altro lato della finestra e si metteva sotto le macchine. I rami avevano foglie ricurve, si torcevano per il vento e cadevano senza rumore. Adrián tremava; e io avevo bisogno di bere, di tornare a sdraiarmi sul divano o di cercare un altro posto. Fuori.
‒ È meglio che dormi, ‒ dissi, e sentii riesumare le parole dal pro fondo. ‒ Dammi retta.
Quando mi avvicinai, notai che era pallido e che gli brillavano gli occhi, come se fossero stati accesi dall’interno. Gli toccai la fronte e lo presi. Era caldo, anche se non aveva ancora la febbre. Mi sembrò che muovesse le labbra e che dicesse vieni. Gemette ancora una volta.
‒ Mamma, tu hai freddo, come lui.
‒ Sì, hai ragione. Ho molto freddo.
Quando mi feci spazio accanto a lui, sentii che il letto era più inca vato e pensai, per un istante, alla terza sedia lontana dal tavolo. Lasciai il bicchiere sul pavimento. Credo che riuscii a sentire come si svuotava. Poi presi la sua testa e la strinsi al petto. Ora, vedevo i miei piedi nudi. La bocca dell’orso si era un po’ sfumata ai miei occhi; ed era nera, le gengive, tutto aperto.
Feci scivolare la mano giù dal letto, provai a toccare il bicchiere, ma le dita mi pesavano e non riuscii a trovarlo. Le inzuppai nel whisky. Sentivo che stavo nuotando in un delirio, in un cerchio, come se potessi vedere con più chiarezza, immergergli la testa lì, nel colore rosso e nel colore giallo – volevo bere, e lui faceva resistenza tra le mie braccia; immergerlo in mamma, e in fondo, un lago pieno di bambini che galleggiano silenziosi in superficie. Da sola, prendevo lentamente il posto di uno di quei bambini disegnati sulla parete ed entravo in una fotografia in cui appariva solo la mia immagine. Volevo rimanere lì. Girarmi e andarmene, tornare a siste mare la sedia.
‒ Vieni ‒, dissi.
Continuavo ancora a stringergli la testa.