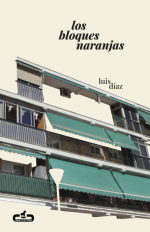Il giorno in cui mio padre credette di aver visto il diavolo io non ero a casa. Di fatto, era un’eternità che non avevo notizie della mia famiglia.
Quindici anni senza varcare la soglia di azulejos rotti di Villa Milagro. L’ho fatto di proposito. L’aria si trasformava in fango al solo pensiero di ritornare. Scrivergli una lettera o una cartolina sarebbe stato come strapparmi un occhio. Per quale motivo girarci tanto intorno? Non ho mai sentito casa mia come casa. Casa mia era un manicomio. Pazzi lucidi. Pazzi che ragionano, che dialogano, che controbattono, che convincono. Non esistono pazzi peggiori dei pazzi lucidi. Ma c’è di peggio: la follia della mia famiglia risaliva a diverse generazioni passate. I miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni, i miei trisnonni, tutti avevano decisi di restare ancorati a quel terreno di fronte al mare, determinati a non muoversi mai, a diventare statue di sale, fedeli al proposito idiota di custodire un melo avvizzito. Il destino della famiglia Miralles è ed è sempre stato, figlio mio, fai attenzione, prendi nota, che cos’è quella ruga sulla fronte?, petto in fuori, sentiti orgoglioso, il destino della famiglia Miralles è ed è sempre stato fare i cani da guardia.
Io me ne sono andato. Sono stato a Barcellona, a Copenaghen, ad Addis Abeba, a Manaus, a Johannesburg, a Luang Prabang, a Bucarest, a Zacatecas, a Shanghai, in tanti posti, mai in abbastanza posti. Pompe di benzina nel bel mezzo del nulla costruite appositamente come rifugio dove comprarsi una birra. Lavarsi le ascelle e farsi la barba di nascosto in un bagno pubblico. Passeggiare per una città straniera, circondato da estranei – estraneo il colore della pelle, estranei gli abiti, estranee le abitudini – ed essere cosciente del fatto che, in realtà, quello estraneo sei tu. Ho fatto il contrario di ciò che la mia famiglia si aspettava da me: non ho mai smesso di muovermi. Sono saltato da un paese all’altro come se in questo consistesse la mia vita. Se per caso mi fermavo più di un paio di mesi nella stessa città, nello stesso villaggio di casette di fango e paglia, nella stessa capanna persa in culo al mondo, cominciavo a sentirmi male. Le gambe mi tremavano e dopo ogni pasto vomitavo una bile bianca e spessa come latte quasi rappreso. Gli attacchi di nausea non cessavano finché, ancora una volta, non prendevo lo zaino e mi rimettevo per strada. Senza destinazione, senza casa, senza amici, senza un euro-dollaro-peso-dirham-rupia-yuan in tasca. Me la sono vista brutta. Questa è la verità. In questi anni mi sono visto obbligato a fare cose di cui non sono orgoglioso. Ma e allora. Sì. È così. È il prezzo della libertà. Io ora so delle cose. So, per esempio, che a Khartum i bambini di strada parlano una lingua segreta chiamata rendók. So che a Zanzibar la notte il plancton brilla in mare come se fosse porporina. So che a Potosí le sigarette ti durano di più perché la città si trova a quattromila metri di altitudine e la scarsezza di ossigeno fa sì che il tabacco bruci più lentamente. So che in India i travestiti sono al contempo santi e mendicanti. So anche, per non farla lunga, che in California si può tirar su una buona paga raccogliendo marijuana.
Il giorno in cui mio padre credette di aver visto il diavolo io mi trovavo a diecimila chilometri di distanza. Precisamente a Bangkok, precisamente nel quartiere Sukhumvit, precisamente in un sudicio appartamento affittato a uno speculatore cantonese. Il mio cellulare squillò alle due di notte. Risposi mezzo addormentato. Fu allora che una donna sconosciuta mi informò del fatto che mio padre credeva di aver visto il diavolo. Quella era la prima volta in quindici anni che qualcuno menzionava il nome di mio padre.
La donna si presentò come signora Nissenbaum. Affermò di essere l’intermediaria amministrativa di Antich & Asociados, un’azienda che si occupava di sviluppo urbanistico. Quella era una questione di massima importanza. Così disse la signora Nissenbaum attraverso il vivavoce del mio cellulare. Di massima importanza.
«Parlo con il signor Moisés Miralles? Suo padre è Noé Miralles? Non riagganci. Devo comunicarle una questione di massima importanza».
Io la ascoltai parlare con una sensazione di irrealtà sfregandomi la punta delle dita. Mio padre. Il melo. La sacra missione dei Miralles. La mattina in cui me n’ero andato. Tutto mi ritornò di colpo, come una bastonata in mezzo agli occhi.
Sono passati due giorni. Da allora non ho smesso di pensare a mio padre. Mi sono accorto che non riesco a ricordare la sua faccia: è come se cercassi di afferrare un buco. Quello che invece ricordo con sorprendente nitidezza sono ognuna delle sue numerose manie, i suoi immutabili automatismi di uomo irremovibile. Com’è che dicono i bravi figli ai funerali? Ah, sì: mio padre è sempre stato un uomo abitudinario. Quando la signora Nissenbaum, intermediaria amministrativa di Antich & Asociados, mi telefonò, andò dritta al punto. Non seppe o non volle darmi troppi dettagli su come mio padre aveva creduto di vedere il diavolo. Ma io, che conosco ancora a memoria le consuetudini di quella che era stata casa mia, non ho nessun dubbio su come sono andate le cose quella mattina di ottobre.
Alle sei e venti del mattino mio padre aveva aperto gli occhi. Mancavano esattamente dieci minuti al suono della sveglia. Mio padre ha sempre avuto un risveglio da automa. Un istante sta dormendo e quello dopo il russare gli si spezza in due con un colpo d’ascia, il cervello si elettrifica, pronto per entrare in azione. Troppi turni notturni di guardia durante l’infanzia e la giovinezza e la vecchiaia. Io mi sveglio allo stesso modo. Mio fratello Zaccaria si sveglia allo stesso modo. Mio fratello Gabriel si sveglia allo stesso modo. Mio padre ha insegnato a tutti noi a passare dal sonno alla veglia con la professionalità di un gatto. A mia sorella Ruth no: lei è donna. Dio non l’ha creata con l’anima da sentinella, a lei ha riservato altre attività, principalmente quella di partorire altri Miralles. Non l’ho detto? Oltre che fuori di testa, nella mia famiglia sono anche dei primitivi maschilisti. Perciò alle sei e venti, dieci minuti prima del suono della sveglia – sono convinto che sia andata proprio così –, mio padre si svegliò quasi mozzando il sonno e restò con gli occhi aperti, immobile sotto le lenzuola, ad aspettare che le lancette dell’orologio segnassero le cinque e mezza. Mia madre dormiva all’estremo opposto dell’antico letto matrimoniale. Russava piano.
Dalla finestra la luce entrava di lato come se scorresse lungo uno scivolo.
Luce masticabile del Mediterraneo che nasce densa e placida, del colore del mandarino.
Ho fatto il giro del mondo e non ho mai visto una luce come quella.
Un secondo prima che la sveglia cominciasse a suonare mio padre allungò la mano e la spense. Poi si alzò con la cautela appresa dopo anni passati a condividere il letto. Si tolse i pantaloni del pigiama e la maglietta, li piegò e li dispose sul cuscino. Nudo, si diresse verso l’armadio in cerca di un cambio nuovo. Mio padre è sempre stato un uomo alto e magro. Molto alto e molto magro, intendo. Da nudo deve essere uguale a un albero secco. Di colpo mi accorgo che sono passati quindici anni. In tutto questo tempo, per forza, la carne di mio padre si sarà liquefatta, le vertebre gli si saranno incassate una sull’altra, avrà perso, come minimo, sette o otto centimetri di statura. Ma sarà ancora un uomo alto, su questo non ho dubbi, e magro in modo esagerato. Ciò che più attirava l’attenzione in mio padre erano le sue mani enormi. Dita così lunghe che sembravano avere venticinque falangi. Dita come rami dell’albero secco che mio padre era, e di certo è ancora. Le poche volte che, nel corso degli anni, l’ho sognato, non sono mai riuscito a distinguere il suo volto – quel buco –, ma le sue mani sì. Mi apparivano a riposo sul tavolo, preistoriche e lunghe, abbandonate accanto al bicchiere di vino o alla tazza che puzzava di caffè corretto. Nei miei sogni non succedeva nient’altro. Le mani se ne stavano semplicemente lì. Rinsecchite. In attesa.
Le persone normali si siedono sul bordo del letto per infilarsi i pantaloni e le scarpe, ma mio padre no, mio padre si siede solo quando è il suo turno di fare la guardia. Per quello so che il giorno in cui credette di aver visto il diavolo si vestì in piedi, forse appoggiandosi alla cassettiera della bisnonna, forse allo stipite della porta. Pantaloni di velluto a coste e una canottiera di cotone bianca. Anche un maglioncino, se l’alba fosse stata fresca. Ai piedi, espadrillas. Mio padre uscì dalla stanza e scese le scale. Nel letto, mia madre aprì gli occhi, constatò che suo marito se ne era andato a compiere il suo dovere e si riaddormentò.
Invece di andare in bagno mio padre si diresse verso la cucina. Aprì il rubinetto dell’acquaio e si rinfrescò la faccia proprio lì. È come se lo vedessi. Tutti i cazzo di giorni allo stesso modo. Per asciugarsi mio padre usò il dorso della mano, niente asciugamani o strofinacci. La cucina è grande e antica, sommariamente ristrutturata. Gli scaffali di pino si incurvano sotto il peso dei piatti di ceramica e delle brocche di peltro, il corredo di generazioni che si accumula senza ordine né misura; in questa casa non si butta nulla: Non una acetiera bucata, non un piatto pacchiano, non un mestolo piegato. Grandi quantità di casseruole, mulinelli da pesca, damigiane di vetro verdi, ceste di vimini, non c’è spazio per tante cianfrusaglie. La dispensa è in fondo, dietro una tenda di stoffa. Il forno, incassato nella parete, degli inizi del XIX secolo, un’epoca in cui la maggior parte delle persone non potevano permettersi un forno. Quel forno con rivetti di bronzo è un simbolo. Un ricordo del fatto che, molto tempo fa, la residenza dei Miralles era stata una signorile alquería.
Alquería: è così che si chiamano a Valencia quelle case di campagna con un’aria da castello che ai tempi i contadini benestanti avevano tirato su con l’intenzione di rendere chiaro ai vicini che loro no, nella maniera più assoluta, loro non erano in nessun modo come i morti di fame che li circondavano. A quell’epoca Villa Milagro doveva essere una bellissima proprietà. Oggi è una reliquia. Ragnatele e crepe.
Mio padre fece colazione in piedi – ho già detto che mio padre si siede solo quando è di guardia –, la pancia appoggiata al ripiano, ben attento a che le briciole cadessero nell’acquaio. Una fetta di pane e qualche pezzo di formaggio di pecora. Caffè freddo della sera prima. Lo stesso benedetto menù di ogni benedetta mattina.
Dopo aver mangiato, mio padre uscì in cortile. Lì lo ricevettero i cani più mattinieri. Forse qualche salto, anche un muoversi frenetico di code, ma mai, di questo sono sicuro, un latrato. I cani di Villa Milagro sono stati educati con scrupolo e abbaiano solo se c’è un motivo. Quando me n’ero andato, in casa avevamo nove cani. Sono ancora in grado di recitare i loro nomi tutti di seguito: Expósito, Pentecostés, Corintio, Inmolado, Cabal, Fariseo, Jericó, Oveja e Munífico. Mi chiedo quanti cani ci saranno ora. Di più? Di meno? Sicuramente di più. Sì, sicuramente molti di più.
Comunque: il cortile. Finalmente mio padre uscì in cortile.
Il centro della casa. Il centro dell’universo. Letteralmente: il centro dell’universo.
Il cortile interno di Villa Milagro è rettangolare. Le mura che lo circondano – le mura che circondano il centro dell’universo – sono robuste. Non proprie di una villa, più adeguate a una prigione. Sulla sommità si distingue il profilo dentato del fil di ferro, oltre a cocci di bottiglia mescolati alla calcina e disposti qua e là con tutta la cattiveria del mondo. Ogni tanto un gabbiano si lacera un’ala con la concertina o si ferisce una zampa con i cocci, e allora a Villa Milagro si rallegrano perché almeno ci sarà qualcosa da commentare a tavola. Il muro orientale di quel cortile dà direttamente sul mare, uno strapiombo che discende sette metri in picchiata fino al Mediterraneo. Nonostante quella posizione inespugnabile, la sua sommità è tanto spinata quanto le altre, la stessa ferocia contro lo stesso ipotetico e invisibile nemico.
Al centro del cortile – al centro del centro dell’universo – ci sono un ombrellone, un tavolino di plastica e una sedia a dondolo.
Quella è la sedia a dondolo del Guardiano.
Di fronte si staglia il maledetto melo traboccante di sole.
Portagli rispetto. Salutalo. Fatti il segno della croce. Ascolta, figlio mio, fa’ attenzione: quel melo è nostra responsabilità, dei Miralles, nostra e di nessun altro; a chiunque si avvicini a quel melo gli spariamo dritto in fronte, gli tiriamo coltellate nelle reni, gli apriamo lo stomaco con un colpo solo, lo gettiamo in mare e amen.
(…)
View Colofon
Original text
"Los Miralles" written in Spanish by
Kike Cherta,
Other translations
- "Семейство Миралес" translated to Bulgarian by Ivana Peneva,
- "Міральєси" translated to Ukranian by Oleksandra Laktionova,
- "Mirallesovi" translated to Slovenian by Mojca Petaros,
- "Rodzina Miralles" translated to Polish by Justyna Sterna,
- "Familia Miralles" translated to Romanian by Ilinca Gângă,
- "Strážných" translated to Czech by Markéta Cubrová,
- "De familie Miralles" translated to Dutch by Lies Doms,
- "Miraljesovi" translated to Serbian by Irena Selaković,
This text has been made possible thanks to the collaborative efforts of the CELA network. Are you interested in reading more translated chapters of this writer? Please reach out to us!
More by
Martino Gandi
You might also like
'Come si può misurare il tempo?'
Written in Italian by Fabio Guidetti
8 minutes read
Lieto fine
Translated from
Serbian
to
Italian
by Sara Latorre
Written in Serbian by Jasna Dimitrijević
9 minutes read
Il tempo è un cerchio
Translated from
Romanian
to
Italian
by Maria Alampi
Written in Romanian by Andrei Crăciun
10 minutes read