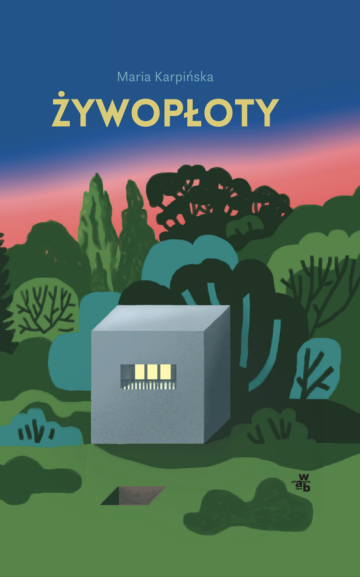Prologo.
Posso scrivere qualsiasi cosa. Tutto ciò che volete. Un annuncio, un pamphlet, un contratto societario. Tutto. Ditemi cosa, e io lo scriverò. A volte potrò rifletterci per un po’, ma non a lungo. Pochi, una manciata di secondi, e poi tutto scorrerà come una valanga di parole da un vulcano letterario. Sarete sorpresi della velocità con cui il tutto fuoriuscirà da me. Mi siederò, nonostante alcuni, a quanto pare, scrivano in piedi, ma io comunque mi siederò, prenderò una matita, una penna, una biro o qualsiasi cosa abbiate, e scriverò. E sarete soddisfatti. Ve lo prometto.
Ammetto sinceramente che ho sempre desiderato fare proprio questo nella mia vita. Scrivere su commissione. Qualcuno mi suggerisce una parola di partenza, e io in quattr’e quattr’otto mi siedo (a quanto pare alcuni stanno in piedi, ma io mi siedo sempre!) e scrivo. Ma non esiste nessuna professione così, nessuno vuole pagare per questo. Giornalista? Eh no, fare il giornalista non è la stessa cosa. Un giornalista non riceve una parola di partenza, un giornalista riceve un intero universo di tematiche e le discute, le approfondisce, si informa gentilmente in merito, le critica, le espone. E non scrive di tutto. Degli abusi di potere, della corruzione, della buca in strada, del nepotismo, dello scandalo dei rifiuti, della disoccupazione nelle piccole città. E io? Be’, per citare un classico, posso solo dire con imbarazzo (e non lo ripeterò tre volte), non me ne frega un cazzo delle piccole città.
Basta, un professione così non esiste. Si può guadagnare di più stando immobili sul mercato che muovendo la mano su un pezzo di carta da una parte all’altra su commissione. Bisogna rassegnarsi: così almeno i miei genitori mi hanno sempre detto, perché dovete sapere che fin da piccolo ho cercato di fare fortuna proprio in questo mestiere particolare. Agli onomastici delle nonne, degli zii o dei cugini mi aggiravo tra gonne voluminose e tintinnii di tazze, aspettando che una delle zie mi scorgesse e mi pizzicasse la guancia. Può sembrare strano, ma prima o poi, una delle donne mi dava sempre un pizzicotto sulla guancia, perché il destino mi aveva dotato di un viso tondo che invogliava a essere pizzicato. Ancora oggi, a volte ho l’impressione che le donne mi guardino sul tram o in posta lottando con se stesse per non darmi un pizzicotto. A quanto pare, nonostante la barba irta, le mie guance hanno ancora un aspetto attraente. Ma torniamo al punto: dopo il pizzicotto, procedevo chiedendo se la zietta fosse interessata alla letteratura in prosa in forma breve su commissione. Ero efficiente al 100%. Del resto, chi non avrebbe voluto ricevere un testo artistico da un bimbo di cinque anni con le guanciotte? Così scrivevo e mi facevo pagare, a volte anche con una mancia, anche se oggi so che mi facevo pagare troppo poco: solo uno złoty a testo.
A quell’epoca era sufficiente, dal momento che i miei costi di mantenimento erano molto bassi. Col tempo, tuttavia, la mia attività ha iniziato a subire un declino, attiravo sempre meno l’attenzione delle zie, che mi davano pizzicotti sulle guance solo di rado e le mie entrate diminuivano sempre più. Avrei dovuto pensare a un nuovo mercato, ma invece di pensarci, pensavo ad altre cose, quelle a cui devono pensare le persone in età adolescenziale.
Aveva iniziato ad andare meglio dopo il diploma. Studiavo ingegneria sanitaria ambientale. Erano tempi bellissimi perché avevo scoperto che nel mio settore vi era una grande richiesta di parole. Le persone che lavorano a diretto contatto con i tubi hanno un grande rispetto per la letteratura. C'è in loro una fame d'arte, una fame che era diventata il motore della mia attività nel suo breve periodo di relativa prosperità. I clienti e dipendenti dello stabilimento idraulico in cui lavoravo, sbalorditi dalle mie capacità, mi commissionavano testi, fornendomi spesso le parole di partenza più strane. L'ode al gasdotto mi ha messo particolarmente in difficoltà. Anche le parole "epatica" ed "epicureismo" sono state una bella sfida, ho dovuto cercarle entrambe nel dizionario. Posso dire con orgoglio che sono riuscito a far tutto. Avevo poche commissioni, ma ero convinto che l’attività sarebbe decollata. Le annotavo scrupolosamente in un taccuino rosso con la scritta “commissioni”, uguale a quello che aveva il responsabile del nostro stabilimento. I tempi di realizzazione erano di un giorno. Mi facevo pagare in anticipo. Lavoro affidabile, prezzi accessibili, nessuno sconto: così era solito dire il nostro direttore e ho seguito anche io questa regola.
Solo una volta non l’ho osservata e ancora oggi ne pago le conseguenze. Mi trovavo alla fermata del tram. Ricordo che quel giorno faceva molto caldo, anche se giugno era appena iniziato. Il calore si sprigionava dall’asfalto morbido, l’aria surriscaldata era umida e pesante. Un tizio stava all’angolo e urlava: “Occasione! Calzini a prezzi bassi, ve li raccomando!”. Non mi capacitavo, chi mai potrebbe pensare ai calzini con queste temperature, e in quel momento la vidi. Aveva un abito bianco stretto in vita da una cintura azzurra. Una spessa treccia chiara le arrivava fino alle scapole. Sembrava una pastorella che aveva appena lasciato il pascolo con il suo gregge di pecore. Non riuscivo a vederle tutto il viso, ma solo gli occhi, grigio-azzurri. Il naso e le labbra erano coperti da un ventaglio colorato con motivi orientali. Invece di sventolarsi, scrutava da dietro il ventaglio, come fanno le matrone illustri durante un ballo nei film in costume. L’ho guardata e ho immaginato che dall’altra parte del ventaglio nascondesse un gran sorriso di fanciulla.
Invece mi ero terribilmente sbagliato. Il viso dietro al ventaglio era molto serioso e molto più anziano di quanto avessi valutato all’inizio. Quando l’ho invitata a commissionare qualcosa alla mia ditta personale, la donna mi ha squadrato con uno sguardo freddo, quasi piacevole in un giorno così caldo. Mi ha ascoltato e poi ha risposto:
– È impossibile, caro signore. Io non leggo.
– Signora, nessuno legge, l’importante è scrivere – le ho detto, ma né questo né il generoso sconto che le ho offerto hanno avuto effetto. Era inflessibile, il calore bruciava e avevo già perso due tram. Stavo per battere in ritirata quando le è balenato qualcosa di birichino negli occhi e con un sorriso scaltro, da dietro il ventaglio orientale, mi ha detto:
– E va bene. Le commissionerò un testo, e al posto di una parola di partenza, le darò un’ispirazione. Domani la porterò nel luogo che mi indicherà lei.
Le ho dettato il mio indirizzo e sono andato a sistemare l’appartamento. Immaginavo che tutto questo fosse un inizio, l’inizio di qualcosa di buono, e siccome mi piacciono molto gli inizi, ero di ottimo umore.
È arrivata a mezzogiorno in punto. Non aveva più il ventaglio, ma un ombrello. Un ombrello, a detta sua, originale giapponese. Dietro di lei trotterellava un cagnolino.
– Cos’è? – le ho chiesto osservando l’animale.
– L’ispirazione – mi ha detto, ed è uscita. Il cagnolino si è rivelato essere una femmina, estremamente brutta e fastidiosa. È entrata nel mio appartamento come se fosse a casa sua e ha iniziato a rotolarsi sul tappeto, era tutta sporca ed in più perdeva pelo. In genere amo molto gli animali, ma la creatura su cui dovevo scrivere un breve testo in prosa non mi ispirava simpatia. Aveva una malocclusione; l’arcata dentale inferiore era sempre fuori in un immobile sorriso psichedelico, o piuttosto in un’espressione aggressiva. La cagnetta stava diventando spelacchiata, il suo lungo pelo grigio era rado su tutta la superficie del corpo. Aveva le zampe corte, una forma allungata e grassa. Gli occhi non si vedevano affatto, tanto l’animale era peloso (anche se spelacchiato). Abbaiava di continuo e si grattava senza sosta, sollevando nell’aria un mucchio di peli.
Sono stato seduto a lungo a osservare il cane, ma non mi sono venute in mente parole adatte. Ho lottato con lei tutto il pomeriggio, perché cercava continuamente di infilarsi nel mio letto insieme alla sua truppa di pulci. Mi sono arreso verso sera, quando ho capito che la sconosciuta con l’ombrello giapponese non sarebbe tornata e che l’ispirazione avrebbe dormito quella notte e tutte le altre a seguire nel mio letto.
Il cane più brutto che avevo mai visto in vita mia ha trascorso con me dodici anni. Ho speso una fortuna per lei, dato che Ispirazione soffriva costantemente di spiacevoli malattie della pelle. Ho lavorato per tutta la vita nel settore idraulico e questo lavoro mi piace, non posso lamentarmi. Ma ancora oggi sogno di scrivere su commissione e di tanto in tanto metto un annuncio sul giornale locale. Il telefono, tuttavia, tace. Da quel fatidico giorno in cui ho incontrato la donna con gli accessori giapponesi, non ho ricevuto neanche una commissione. I tempi sono cambiati, la parola scritta non è quotata e so che mi devo rassegnare. Ho provato a scrivere per me stesso, ma mi venivano fuori cose strane. Troppo lunghe e piuttosto sentimentali. Non si prestavano a niente.
Ieri Ispirazione è spirata. È stata malata per tutta la nostra vita insieme, e nell’ultimo periodo era in preda a una tosse sfiancante. Il veterinario ha diagnosticato la pertosse, ma non ha potuto fare altro. Tossiva, espettorava, vomitava, povera cagnetta, e aveva trasformato il mio appartamento in un ospedale per cani, nel quale mi aggiravo nervosamente, dandole sempre più medicinali. Da quando è morta, non mangio, non dormo e bevo decisamente troppo. Non me lo so spiegare, ma mi sento come se stessi scivolando giù da un tetto spiovente e solo le parole possono far sì che la grondaia, all’ultimo, mi salvi. Non so se capite cosa intendo dire.
Intendo dire che se mi lanciate una parola di partenza, scriverò qualsiasi cosa voi vogliate. Un annuncio, un pamphlet, un contratto societario. Tutto. Mi siederò, ci rifletterò un po’ e scriverò. E sarete soddisfatti.
Anni dell’adolescenza
Da bambino mi piaceva il ritmo costante del treno. Aveva un effetto soporifero su di me, riuscivo ad addormentarmi dopo soli quindici minuti da quando io e tutta la famiglia eravamo saliti sul vagone, portando con noi una quantità eccessiva di bagagli e cibo. Mi sdraiavo sulle pile di valigie o sulla coscia paffuta di mia madre e mi addormentavo cullato dallo sferragliare delle ruote.
Eravamo in piena estate. Gli alberi fuori dal finestrino erano di un verde così succoso che se ci avessi affondato i denti avrebbe cominciato a colare sul mento. Il caldo afoso non era ancora riuscito a inaridire il panorama estivo. Qua e là, qualche casupola, un’impressione idilliaca, di pace. E tutto questo sfocato, indistinto, sporco come un vetro ricoperto dal grasso di centinaia di mani umane e non pulito bene dal personale ferroviario.
Su questo sfondo non c’era nessun altro, se non una bimbetta. Tutti la chiamavano così, sento ancora mia madre che dice questa frase: – ci sarà una bimbetta, vi piacerete –. Anche quella volta eravamo in treno, andavamo dalla famiglia di uno zio o di un cognato, non ricordo. Non ho più visto nessuna delle persone che allora mi avevano ospitato, né prima, né dopo. Quale fosse l’idea di queste vacanze, non lo so, del resto l’infanzia è piena di eventi che non hanno bisogno di essere spiegati a un bambino, non hanno nessuna ragione o scopo, non li precede nessuna introduzione. Un beato mondo di ignoranza, privo di decisioni.
Mi piaceva la parola “bimbetta”, aveva in sé sonorità e l’allegria di una “canzonetta”, la spensieratezza, la leggerezza di un trampolino o di un’altalena. Non mi piaceva invece l’idea di passare le vacanze con una ragazza. Avevo quell’età in cui si può fingere per ore che un bastone sia un fucile o una spada, ma non si può fingere che una ragazza sia un essere umano come tutti gli altri.
Si dice che le persone vengano giudicate dall’impressione che fanno nei primi quindici secondi. Se questo è vero, quella vacanza sarebbe dovuta essere un incubo, perché Anielka, questo era il suo nome, mi aveva fatto un’impressione terribile. Aveva due trecce color topo, un vestitino legato con fiocchetti sulle spalle e arti lunghi e sottili. Il corpo era così magro che le ginocchia e i gomiti sembravano tuberi innaturali sulle sue membra. Tuttavia non si trattava di una condizione patologica ma temporanea, dopo la quale la figura di Anielka avrebbe preso forma e, come effetto collaterale, anche massa. Occhi grandi, il naso un po’ all’insù e tutto il viso esageratamente adulto e serio, anche se in fondo aveva appena compiuto otto anni.
– Giochiamo con la pallina – aveva detto. Questo diminutivo mi infastidiva, al tempo non sapevo ancora che Anielka mette al diminutivo ogni sostantivo, e anche gli adulti, parlando con lei, cominciavano a usare lo stesso strano linguaggio, come se Anielka appartenesse a un’altra specie, una specie di teneri orsacchiotti e palloncini rosa, dove si può solo usare questa amabile neolingua.
Ben presto ho visto che, nonostante le frasi rotonde ed educate usate da Anielka nei suoi dialoghi con gli adulti, era una persona crudele, e che addirittura si crogiolava in questa sua crudeltà. Il gioco con la pallina si trasformava in nient’altro che un semplice fare a botte, nel quale ero io, un ragazzo di tre anni più grande di lei, a essere pestato, come si suol dire, a sangue. Ricordo che quando mi aveva colpito in faccia per la sesta volta con la palla con una forza che non mi sarei mai aspettato da una bimba esile come Anielka, avevo smesso di guardarla con quel misto di disprezzo e indulgenza con cui l’avevo accolta, e avevo iniziato a considerarla con un’ammirazione che, durante quei due strani mesi afosi, aveva raggiunto il suo apogeo al momento della partenza.
Ogni giorno Anielka inventava per noi sempre più giochi, ognuno dei quali prevedeva la tortura di creature innocenti che incontravamo sul nostro percorso, o in mancanza di questi, di me. Ingenua e pura nella sua ingenuità, questa l’impressione che dava la mia nuova amica, la bambina osservava con gioia e soddisfazione la sofferenza dei piccoli gattini terrorizzati che mi faceva mettere sul nido di cicogna più alto della zona. Guardando gli occhi che uscivano dalle orbite delle rane appese per le zampe posteriori a un ramo, emetteva rantoli di soddisfazione che mi facevano rabbrividire. – Fai una giostra di rane – mi aveva detto, e io, inghiottendo le lacrime, avevo obbedito docilmente e in silenzio avevo legato con lo spago le sottili zampe delle rane, che assomigliavano ingannevolmente a quelle di un angelo. Eseguivo tutti i suoi ordini, contribuendo all’incredibile sofferenza di molte creature innocenti e rischiando io stesso al contempo la salute, se non la vita. A mia discolpa posso dire soltanto che a volte, quando Anielka andava a fare merenda o stava aiutando i suoi genitori, andavo di nascosto sul luogo del delitto e liberavo gli animali, di solito già moribondi. Mi dicevo che era tutto ciò che potevo fare per loro.
Avevo quell’età in cui la visione del castigo per i peccati evoca una reale e lacerante paura interiore. Nella mia città natale facevo il chierichetto in una parrocchia vicina e prendevo molto sul serio la questione dell’ira divina. Ogni sera, invece di dire la preghierina, scoppiavo a piangere, a pancia in giù, con la faccia nel cuscino. Mi tormentavo al pensiero dell’inevitabile confessione alla fine dell’estate. Continuavo ad aggiungere nuovi elementi al mio conto di coscienza. Tenevo la lista nello spazio tra il materasso e la struttura in legno del letto. Non c’era giorno in cui non la prendessi in mano due o tre volte per aggiungere una nuova voce con una matita mordicchiata. Annotare i miei peccati mi dava un sollievo di breve durata, come se l’esistenza stessa della lista mi offrisse la speranza del perdono. Dopo un po’, però, la lunghezza dell’elenco aveva cominciato a spaventarmi. Ogni volta che dovevo aggiungervi qualcosa, davanti ai miei occhi appariva il confessionale, e di fronte ad esso io, che borbottavo sottovoce una litania infinita dei miei peccati. Finché, durante una delle mie notti insonni, in preda all’impotenza, avevo mangiato la lista, dopo aver prima tagliato il foglio in piccoli pezzi. Forse speravo che l’indigestione causata dalla presenza di carta nel mio stomaco potesse essere considerata una forma di penitenza e quindi contribuire al perdono di almeno una parte dei miei peccati. In fondo, però, sapevo, e ne sono ancora certo, che non c’è nessun Dio che perdonerebbe quello che ho fatto quell’estate.