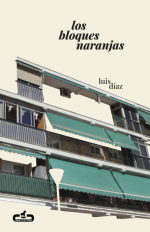I
Il mattino dell’11 luglio 1978 un camion parte con un carico di propene li quido in direzione di Barcellona. Il camion proviene da una piccola città della Catalogna ed è guidato da un autista con due grossi baffi nel mezzo della sua faccia lucida. Sono vent’anni che guida lo stesso mezzo per conto
della stessa società, e conosce a memoria la rete stradale spagnola. Per evi tare le autostrade a pedaggio sceglie sempre le strade nell’entroterra.
Le bombole del gas non dovrebbero stare a lungo sotto il sole, meno che mai una bombola enorme che contiene venticinque tonnellate di propene quando dovrebbe portarne non più di diciannove. Forse si buca una gomma e il camion va a sbattere contro il muro di recinzione del camping, si ribalta, slitta e va a fermarsi contro un pozzo di cemento con un colpo abbastanza forte da forare il serbatoio. Forse il serbatoio si fora già da prima e l’autista ferma il suo mezzo vicino al campeggio per ispezionare la perdita. Quel che in ogni caso è certo è che dal serbatoio si solleva una nuvola di propene e inizia a fluttuare sul camping Los Alfaques in cerca di fiamme libere.
La grande nuvola bianca di propene che galleggia sopra il camping attira subito l’attenzione dei molti villeggianti presenti che si accalcano intorno all’autocisterna squarciata per osservare il fenomeno. Il gas trova il suo in nesco nei pressi di una discoteca situata a nord-est del camping, dove un ra gazzo sulla ventina sta fumando una sigaretta. Non appena la nube prende fuoco, in una frazione di secondo il gas incendiato sfreccia in direzione del camion. La fiammata raggiunge il serbatoio e il propene residuo esplode
con uno scoppio assordante. Una palla di fuoco alta sei piani avvolge metà del campeggio. Chi non è colpito direttamente dai pezzi fiammeggianti di camion che volano in aria, brucia nell’onda d’urto incandescente che di strugge tutto ciò che incontra. Scoppiano le bombole blu per i fornelletti da campeggio, le auto volano nell’incendio, alcuni rimangono bloccati nelle tende e nei camper in fiamme. Per proteggerlo, un padre getta il figlio letto nel congelatore. La temperatura dell’onda è così alta che il ragazzo rimane ucciso dal caldo all’interno del suo forno personale. La maggior parte delle vittime indossa solo il costume da bagno.
Quel che rimane dell’autista è un polso bruciato che indossa, fermo ma ancora intatto, l’orologio. L’orologio segna le 14.36, l’orario in cui è avve nuto lo scoppio.
II
Io sono un polso. Un pezzo di osso fatto col calcio più duro avvolto in un fascio di carne secca e pelle ormai fragile. Mi trovo nella stanza di una ra gazza al sud della Spagna. Mi ha messo in cima al comò, in mezzo a una sve glia da viaggio con lancette luminose e la statuina di plastica di un puffo. Quando è notte, la luce fioca, verdognola delle lancette si posa sulla mia pelle. Il puffo ha un regalo fra le mani e io non so cosa contenga.
Tempo addietro non ero un polso che non sta attaccato a niente, ma il pezzo di un baffuto autista di camion. Nella parte anteriore dell’abitacolo aveva costruito un altarino. Contro il parabrezza aveva messo una targa sulla quale era punzonato il nome di sua figlia. Contro la targa c’era un vec chio temperino di marca Opinel. Da bambino ci si era tagliato un dito mentre affilava un bastone, la cicatrice sarebbe lì sul dito, se lo avessi ancora. Il coltellino pieghevole era diventato tutto attaccaticcio per via del sangue coagulato, lo si apriva solo con una certa fatica. Non lo usava più da tempo. Eppure, se quel coltello fosse andato perduto si sarebbe tastato feb brilmente tutti i vestiti. Avrebbe liberato l’abitacolo da cuscini e giornali, dai coprisedili di perline e da tutte le altre cose che non erano fissate al camion, e se a quel punto non avesse ancora trovato il coltello avrebbe per corso a ritroso centinaia di chilometri, fermandosi in tutti i parcheggi in cui aveva sostato, dove avrebbe strisciato sull’asfalto alla ricerca del suo vec chio coltello che non usava ormai più.
C’erano ancora altre cose sul retro di quella targa. Un cucchiaino d’argento, trovato una volta sul bordo del lavandino in una pompa di benzina. Un portachiavi di plastica dura a forma di arachide. Una banconota da cinque dollari e una chiave inglese spezzata a metà dell’impugnatura. Tutte quelle cose l’autista le raccoglieva ai bordi dell’asfalto su cui guidava giorno dopo giorno. Così come per il coltello, avrebbe fatto chilometri e chilometri a ri troso per ciascuna di queste reliquie, se le avesse perdute. Non perché gli sarebbero mai tornate utili, soltanto perché facevano parte del suo altare.
E ora mi trovo io stesso in mezzo a un altare del genere. Con accanto a me la sveglia da viaggio con le sue lancette luminose, e dall’altra parte il puffo con il regalo. E in tutto il mondo ci sono miliardi di altari simili a questo, disposti in vecchie lingottiere, su davanzali, mensole o poggiati sopra la tv.
E tutti quei barattoli pieni di denti da latte, sassolini levigati, uova soffiate, carillon, piume portafortuna, cartoline, conchiglie, bracciali, scarpe per bambini, pupazzetti Playmobil e frutta finta formano insieme una gigante sca rete a cui milioni di persone in tutto il mondo attribuiscono un valore enorme. La religione più grande del mondo trae la sua origine da miliardi di cianfrusaglie. E io e te insieme, caro il mio occhio, siamo di tutto questo il re e la regina.
III
È tardo pomeriggio quando il ragazzo si dirige in paese. Suo padre lo ha mandato qui perché girano voci riguardo certe capre inselvatichite che i terroristi si sono lasciati indietro. Dalla fattoria, le fumate sul paese in fiamme le hanno viste tutti.
Le strade del paese sono annerite di muffa. Animali morti con addosso ancora qualche brandello di carne giacciono maleodoranti fra le capanne. Le capre, certamente quelle affamate, hanno la tendenza a infilarsi ovun que. Il ragazzo deve entrare perciò in ogni casa, aprire ogni armadio. Non si azzarda però a guardare nelle capanne poiché ha paura di trovarci un morto. Cammina su e giù per le strade sabbiose, va ad appoggiarsi sul pozzo, fuma una sigaretta ai margini del paese. In mezz’ora di ricerche il ra gazzo non vede neanche una capra.
Il ragazzo è quasi pronto a tornare a casa quando, al lato di una delle ca panne distrutte, nota una grossa credenza di legno. È un modello europeo, in legno nero di quercia, e sebbene sia carbonizzato da cima a fondo, l’ar madio è ancora in piedi. Il ragazzo si avvicina guardingo. Il mobile in legno sporge di mezzo metro oltre la sua testa. Il ragazzo apre l’armadio. I cardini sono secchi e scricchiolano per la sabbia.
Sul fondo della grande credenza di legno c’è un giovane capro che prova con molta fatica a tenere gli occhi aperti. Il capretto è smunto, e dal suo pelo opaco il ragazzo deduce che non beve da giorni. La sabbia e le zanzare gli ricoprono gran parte del corpo. Ciò che è più strano si trova però sulla testa della bestiola, poiché incastrato fra le due corna c’è un occhio di vetro. Il ragazzo la accarezza una volta dal collo alla coda, così da tranquillizzarla, poi con la mano destra le serra la testa e con l’altra inizia a tirare l’occhio. L’occhio cede bruscamente e rotola nell’angolo dell’armadio. Il ragazzo tasta con la mano nell’angolo, trova il bulbo di vetro e se lo infila in tasca. Poi si carica lo stanco capretto intorno al collo e in tutta fretta si incam mina verso casa.
A casa il ragazzo mette il capretto nel campo recintato accanto alla fattoria. Le altre capre lo prendono con loro nel gregge, lui dopo un pe riodo di convalescenza comincia a produrre la sua discendenza.
Il ragazzo va nella sua stanza, scruta l’occhio, il nord, l’occhio.
IV
L’acqua è importante per un occhio di vetro. Se non lo conservi nel liquido la polvere si accumula, e poi quella polvere ti si infila nella cavità oculare, quando ci inserisci l’occhio. Infatti, il mio vecchio proprietario mi teneva in un bicchiere da cocktail pieno d’acqua, quando non mi indossava. A quel punto io stavo con la pupilla rivolta sul fondo e per tutta la notte guardavo il sotto del bicchiere.
Il mio nuovo proprietario è un ragazzo con due occhi sani, per cui non mi indossa. Io sto sul davanzale della sua camera, senz’acqua. La polvere mi si appiccica addosso.
Stanotte guardavo fuori, verso la duna di sabbia di fronte alla fattoria. La duna di sabbia veniva illuminata di arancio sodico dalle lampade lì appese per scacciare gli animali selvatici dal pascolo delle capre. Un’oasi di luce nel deserto buio come la pece tutt’intorno. Mentre guardavo, una vipera si spostò sotto la luce. Con la coda disegnò nella sabbia una traccia ondulata. Era una lineetta stretta e sottile, eppure riuscivo a vederla chiaramente at traverso le fitte ombre create dalla luce arancione.
Più tardi quella stessa notte altre vipere scivolarono sulla duna sabbiosa. Disegnarono nuovi solchi, paralleli al primo, ma anche in diagonale sopra di esso. Cominciò a sembrare un disegno di onde. Fatto con mano incerta, maldestra, forse un po’ infantile. Ma nella sabbia, all’improvviso vidi il mare.
Un occhio di vetro non può piangere e perciò non si bagna da sé. Un occhio di vetro ha bisogno di acqua. È per questo che il mare è speciale per un occhio di vetro. Per molti il mare è un ostacolo, un’ultima barriera da superare sul cammino per la terra promessa. Per me, invece, il mare non è nulla di tutto questo. Io ci voglio andare.
A un certo punto quella notte il ragazzo stava dietro di me. Anche lui guar dava la duna. Non so se anche lui vedeva le stesse cose nei solchi delle vipere. Non so se sogna il mare anche lui. Ma il ragazzo aveva già posato la sua mano su di me, come se in qualsiasi momento potesse afferrarmi per andare via.
V
Una ragazza è una ragazza è una ragazza è una ragazza. E malgrado sia dell’opinione che proprio qui in Spagna me ne dovrei andare per boule vard, con gli stivali da cowboy di cuoio bianco stinto e una camicia rubata, offrendo ai ragazzi torta di carote e salsiccia calda, da qualche settimana sento invece di dover salire in cima a un’alta torre e sventolare i capelli dalla finestra, di modo che un principe arabo, in sella a un cavallo nerissimo, tutti e due con gli stessi occhi bui come l’inchiostro, possa venire e por tarmi via da questo mortorio di paese e, con selvaggio basso ventre, sbat termi sulla spiaggia fino a farmi sua sposa.
E quasi ogni notte mi addormento con l’immagine di un grosso occhio verde che brilla su questo paese come una luna in cielo, guizzando ritroso di qua e di là come se stesse cercando qualcosa. L’occhio cade all’improv viso di sotto, e rotola per le colline in direzione della mia camera. Io resto incollata all’occhio rotolante, lui mi porta via dal paese che rimane indietro, come rovine sgretolate e in fiamme.
Io non ho un uomo che mi porti con sé, personalmente sono una ragazza pericolosa con un polso sull’armadio che non le fa né paura né schifo. Il formicolio che ho nelle arterie è il sangue sporco che si sveglia quanto metto il mio polso contro quello ritrovato. E comunque non mi sento per duta o depravata.
Una ragazza è una ragazza è una ragazza è una ragazza. Il vento su queste labbra ruvide mi urla di andare. Il vento nelle vene urla invece di attendere.