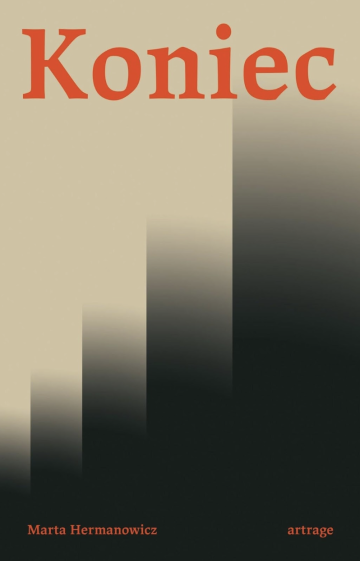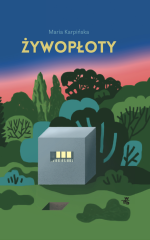Il mio corpo è otto ettari di terra nera di Chrobrowicze, terra di Volinia concimata con sangue e merda, fertilizzata dagli sputi di un bracciante, ma solo se il padrone non guarda, e poi a mento alto supplicando un coltello, finché il padrone deportato al gulag era visibile.
Sono cresciuti fianchi larghi, un seno prorompente, il rimpianto di non poter praticare la rotazione, ma da me non nascerà nulla, perché l’uomo, così come per dare la vita, è fatto per morire. Porto in me un compito. Ecco cosa ho in dote: un coltello e uno spray al peperoncino. Mi agito. Sono un lanciafiamme, terra bruciata, sterile, una minaccia di vendetta giurata controvento, un burattino che non riesce ad annegare.
Cammino per strada e vedo voi più di quanto voi vediate me. Ognuno di voi è un carnefice. So di cosa siete capaci. Vi identifico, uno per uno. Saccheggiatore, piromane, informatore, stupratore, ladro. Tra le nazioni del mondo. Nel silenzio della notte. Alzatevi, impostori, Dio non è nato. Ditelo a coloro a cui è stata fecondata la terra, che il bene vince sempre. Pare che ci sia una scintilla che arde in ognuno di voi, pare che siate stati creati tanto per l’omicidio quanto per la bontà e la verità. Nei libri di testo troverete sculture di prodi, eroi dopo la decapitazione. Date di battaglie, di stermini, notti di lunghi coltelli, notti senza stelle, quando il sangue non veniva affatto assorbito di nascosto dal terreno. Quello che avete fatto ai più piccoli, lo avete fatto a milioni, miliardi. Lo avete fatto ad alta voce. Con la luce accesa. E i numeri si sciolgono, vagano sempre più in profondità, si spengono e si calmano; romani, arabi, vanno bene sia per contare il pane che i corpi dei nemici. Anche io ho le mie cifre. Sono divisa. Sono composta da cinquantadue parti, una più scuroa dell’altra. Non so se sono viva, o morta, copritemi di terra. Mi agito tra l’allora e l’oggi, vecchia anima, un proiettile inesploso dai tempi della guerra, una reliquia bambina del passato.
Cerco di ricompormi. Dio mi ha lanciato, ha mancato il bersaglio. Ora devo raccogliermi da terra, alzarmi, scuotermi, arrivare da qualche parte, fare qualcosa, che march, march, Dąbrowski. (1) Scendo nella mezza età con la scala mobile fino al binario tre dell’inferno, primo girone. Guardo la gente che vaga alle quattro e quaranta di sabato mattina, alle quattro e quaranta di notte del diciotto luglio del duemiladiciotto di un anno randagio. Smarriti alla stazione centrale, cercano di salire sulla carrozza giusta. La folla s’accalca sul Konopicka da Wrocław a Lublin, sullo Słowacki, sul Mickiewicz, sull’Orzeszkowa. Come si chiamava il treno di carri bestiame Volinia-Siberia, forse Dostoevskij o Tolstoj? Le persone con i loro bagagli, preparati a luglio per il pieno inverno, tornano in periferia dalle madri; le madri hanno fatto i pierogi, cucinato il brodo. Saluteranno i figli, diranno, ti ha stancato questa capitale, non partire domenica. Ma poi i figli scapperanno comunque, tra la casa e la stazione fumeranno qualche sigaretta, con un profondo respiro in treno prenderanno posto vicino al finestrino, nascondendo sotto le gambe le provviste imballate nel vetro e nei giornali, torneranno a Varsavia di nuovo a perdersi, disperdersi, cadere a pezzi.
Tutti i treni oggi vanno in direzione opposta. Nowa Sól, il capotreno allarga le braccia, è cambiato l’orario, dove si trova, non lo so, telefonata muta, non c’è, numero inesistente. Forse non c’è questa città, forse tra martedì e mercoledì hanno spostato i confini e dovrei tornare in Volinia, all’insediamento di Chrobrowicze. Forse Lotka è lì, e non in un ospedale di Nowa Sól nei territori recuperati, ma non per lei, lei non aveva recuperato nulla. Dovunque lei sia, Dio non la vede. Ovunque lei sia, non la ricomporranno comunque. Esco. Salgo, cambio treno. Alla stazione Warszawa Zachodnia c’è coda. Mi metto al fondo. Respiro i gas di scarico dei pullman, invecchiati malamente a forza di girare in tondo. Qualcuno urla, birra fredda, tè caldo. Qualcuno si versa l’acqua bollente addosso, è venuta voglia di una bevanda calda, avrà una cicatrice grande quanto l’Unione Sovietica ai tempi di Gorbaciov. Chiudi il becco, grida qualcuno. Što gavariš, što. V pizdiet. (2) Tutto si confonde. È andata bene. Sull’autobus c’erano gli ultimi posti, ancora un paio di ore e sarò da qualche parte nel voivodato di Lubusz, nei dintorni di Nowa Sól.
Lotka, sto venendo da te in mezzo alla folla e in preda alla fame. Lotka, arrivo, per chiudere il cerchio. Eri una dei miei defunti, allora non lo sapevo, ti ho tagliato pezzo per pezzo dalla fotografia di famiglia, tu ti sei tagliata fuori meglio, eri morta da tempo.
Il pullman si è fermato in un tunnel sotto la Vistola, proprio adesso potrebbe scoppiare un incendio, sottoterra e sott’acqua allo stesso tempo, nessuno si salverebbe. A due giorni di distanza la Siberia è in fiamme. L’incendio si vede dallo spazio. Dio ci vede bene, si diverte, quattro milioni e mezzo di ettari. Forse è stato lui ad appiccarlo, il roveto ardente, che bruci, che arda all’inferno. Per i tuoi otto ettari di terra nera non si è nemmeno chinato, ha mandato un garzone come sostituto. Dio non ha promesso nulla a suo figlio, che è stato appeso per i peccati di tutti, uno per tutti, tutti per nessuno, perché dovrebbe promettere qualcosa a te. Chi crede in me, vivrà per sempre, e quindi potrebbe essere peggio. La gente si è aggrappata alla vita eterna come un moscerino alla fogna, due settimane di quarantena in purgatorio, poi riposo, Dio, è questo il mio inferno. Dio Padre tratterà tutti in maniera brutale: colonna di sale, omicidio, sette anni di carestia, morte del bestiame. Dio! La Polonia, pia illusione, l’undicesima piaga.
Il pullman è uscito dal tunnel, siamo tutti vivi, che disgrazia. Mia madre ha chiamato, non ho risposto, quanti buoni consigli si possono ricevere sul pulire con il metodo Macondo o Komari, tutto arrotolato, maglioni piegati come origami, l’appartamento è un piatto di sushi, il bagno è una ciotola per sciacquare le dita, sto per vomitarci dentro, ho sniffato una riga prima di uscire dall’appartamento, e nel pullman si soffoca per le sigarette fumate fino al filtro, comprate a poco prezzo dai cognati. L’autista gracchia attraverso il microfono, tra poco ci sarà la fermata, e io torno in deposito. La mia cinquantaduesima parte già mi rode. Accanto a me è seduto un ragazzetto, sbava mentre prova a mettere in rima come pulisce lo sterco dei cavalli aristocratici nei dintorni di Varsavia. Mi offre dei biscotti, io rifiuto, non mangio dolci da quando ero bambina, sì, è per questo che sono così magra, rispondo, i sonniferi sono finiti nelle tette. Non voglio ascoltarlo, ripeto chiaramente, e lui tace solo alla terza volta. Ieri ha chiamato mia madre, la nonna è caduta, è stesa in ospedale. Anche io allora ero stesa, Er mi aveva mollata e c’era merda bianca sul tavolo. Avevo arrotolato la banconota da cento in maniera perfetta, non era rimasto attaccato niente, la mamma sarebbe stata fiera. Mi sono sotterrata, succede sempre così quando si aspira la polvere in solitudine e tristezza. Ho dormito tutta la giornata, mi ha svegliato la notifica del messaggio di mamma. Alzarsi di botto, scappare, anche solo nel luogo dal quale si era fuggiti prima.
Tra quattro giorni compirò trentasei anni, è una coincidenza che sia ancora viva, una coincidenza. Ancora un attimo e mi verrà la gobba. Non voglio, ma mi trascino come Lotka, prima la testa, un esploratore goffo, seguita poi dal resto che segue strusciante al guinzaglio. Forse un chiropratico aiuterà, metterà a posto, sistemerà dall’inizio, perfino queste parole nervose, la voce che varca il confine orientale durante i primi incontri. Non è la mia voce, non ho una mia voce. È tutto ingarbugliato, anche la lingua. Sono un fascio di nervi con un accento primitivo.
Mi sono levata dai piedi non alle mie condizioni, sono scappata. Non sono l’unica. I pullman e i treni sono sovraccarichi come carri bestiame negli anni quaranta. La terza generazione fugge verso Varsavia con zaini pesanti, porta con sé barattoli pieni di cuore materno. E poi si lamenta delle code alla cassa: quando tornerò a casa, mangerò finalmente del pane vero. Il migliore dalla mamma.
Il sole inizia a bruciare i finestrini, mi si secca la gola, non ho preso nulla da mangiare, nello zaino trovo i resti di un panino attaccati a un berretto di pelo. Signor autista, gridano, l’autista finalmente si ferma. L’autista gira verso la stazione. Ne addento un pezzo e mi preparo a uscire. Fanno il pieno, il pullman e i passeggeri. Io me ne sto in disparte, conficcata a terra, fumo una sigaretta e bevo una Red Bull, due al prezzo di una, la mia colazione preferita. Ho freddo, anche se siamo in piena estate, e torno a prendere il maglione. Forse dovrei mettermi anche il berretto di pelo. Gente ammassata in mucchi, si scambiano pensieri logori, chi vive dove, che lavoro fa, quanto guadagna, quando torna, no, non tornerà definitivamente ai confini della Polonia.
Preferirei addormentarmi, ma lo stalliere non me lo permette. Grugnisce, si agita sul sedile. Prenderei un sonnifero, ma non voglio svegliarmi nell’appartamento dell’autista. Guida indossando una camicia bianca a righe rosse stropicciata, fa da bandiera, soffia il contenuto della testa in un fazzoletto, lo butta a terra. Tutto intorno campi, piccole case, piccoli demoni, sfrecciamo, un cavallo di Troia di latta con un losco tachimetro. Il telefono emette dei suoni, un messaggio di mia madre che chiede se ci sarò. Non ci sono mai stata.
I libri dicevano più degli adulti, a voce più alta. Cadevano dalle mani e sbattevano sul pavimento, si aprivano sulle foto dei morti. La mia stanza funzionava bene come ripostiglio, una bambina piccola non ha bisogno di molto spazio, è già lei un mobile, può essere spostata dal pavimento alla sedia, dalla sedia al letto; gli armadi erano stracolmi di cose: da porcellane tedesche, ai vestiti del nonno, qualche abito della bisnonna, un manuale di medicina legale con foto di persone annegate, vittime di incidenti, strangolate, impiccate, assassinate, fatte a pezzi. Un album di famiglia, è così che lo consideravo. Disegnavo cornici e soli intorno alle foto, aggiungevo acconciature e baffi, vestiti simili a quelli dell’armadio, e quando iniziava a far freddo, cappotti di pelliccia. Inventavo storie per i parenti, professioni, colori e piatti preferiti, e anche spiegazioni sul perché non erano venuti a trovarci. Zio, nonno, bisnonno, cugine, zia. Erano partiti per un viaggio in capo al mondo, ma sarebbero tornati, nel giro di poco, con il pullman, una semplice auto non avrebbe sufficiente spazio. Ci siederemo a tavola, bisognerà chiedere in prestito delle sedie dai vicini, le nostre tre non basteranno. Forse sono loro. Forse tutto questo è dovuto ai morti, non alla nonna. Forse mi hanno contagiato con qualcosa che aspettava tra le pagine del manuale, un’allergia alla vita, un’infiammazione acuta. Volevo essere come loro, morta.
Ero un corpo temporaneamente vivo, vivo per tutti, poi mi ha preso qualcosa, si è allentato qualche ingranaggio, il meccanismo si è reimpostato, sono finiti i “grazie”, “prego” imparati, sono finiti i “che bella”, “bella bambina”, nessuno sa chiedere scusa come lei, mi giravo dalla parte sbagliata, mi sedevo sul pavimento freddo della cucina, metti i calzini, Malwinka, cucciola, amore, tesoruccio, per l’amor del cielo, mani della stessa temperatura del pavimento mi spostavano sul tappeto di fronte al televisore, guarda i cartoni animati, non urlare, una gazza preparava la pappa, dava da mangiare ai propri cuccioli, batti batti le manine. E poi le mani fredde portavano il mio corpo sul divano, mi coprivano con una pesante coperta piegata a metà, troppo rigida per calmarmi e farmi dormire a lungo. Sognavo appena sotto la superficie, venivo scaraventata al di sopra di essa, mi svegliavo e coglievo l’aria lasciata dai tedeschi, con l’umidità tirata verso terra. Forse tutto ciò per colpa della mancanza di ossigeno, non di nonna.
Tutto per colpa di nonna, ripetevo la mia prima frase. Non si dice, spiegava mamma, ma non lo smentiva. Perché era tutta colpa di nonna Lotka, il letto bagnato, il brutto tempo, le cadute durante il gioco, il cane che abbaiava. E lei mi chiamava bambina rotta, scaduta, di fattura sovietica. Bambina, per l’amor del cielo, hai appena iniziato a parlare e già tendi all’est, nessuno in famiglia parlava così, la bisnonna veniva da Zamość, il bisnonno da Puławy, e la lingua si è appiattita dopo la guerra, è stata investita da un carro armato, il canto è stato fucilato, e ora non c’è niente da cantare, a meno che qualcuno non voglia farlo sui surrogati del cioccolato.
Strattonavo peggio dei cani al guinzaglio, come i suoi predecessori non ha ricevuto un nome, era solo bestiame vivo e domestico. E io ero mezza viva. Potevo essere spostata, il pianto non funzionava, non erano queste le cose che sentiva nonna. Le dava più fastidio il silenzio. Una volta mi sono nascosta nell’armadio, soffocante per l'odore dei vestiti colorati non indossati. Tornata dal negozio, non riusciva ad arrivare a fine giornata senza il dolce al formaggio. Non mi ha fatto divertire come mi aspettavo, non ha esclamato: “tana per Malwinka!”, l’ho scambiata per la nonna del manuale dei morti. Attraverso le ante dell’armadio ho sentito un respiro pesante, sempre più veloce, sempre più forte. Si trascinava da una stanza all’altra. Sono saltata fuori dall’armadio, urlando: sorpresa! E lei, in risposta, niente. È andata in cucina, non ha parlato per il resto della giornata, ha mangiato il dolce solo quando ormai era raffermo.
Stava calando la sera, quando mamma tornava dalla biblioteca. Riposo, diceva, come se avesse finito di lavorare. Io, bestiame, potevo essere messo via, tranne che nell’armadio, lì muoio, salto fuori al momento sbagliato. Sulla soglia della porta si sono scambiate delle parole, piove di nuovo, fa di nuovo freddo, il vento taglia, Polonia del cazzo. Andava all’autobus mezz’ora prima della sua partenza, aveva paura di non arrivare in tempo. Il berretto e i guanti lasciati in corridoio non erano in grado di farla tornare indietro. I vicini dicevano: abbiamo visto Lotka, era seduta alla fermata, tremava dal freddo; la mamma ha risposto: la nonna ha sempre freddo, anche nel giorno più caldo dell’estate. Congela con il berretto, e senza berretto, non c’è differenza.
Quando Lotka ha trovato il mio manuale dei morti, ha minacciato mio padre e io ho fatto la pipì sotto al tavolo della cucina. In quel momento è rimasta immobile a fissare la pozzanghera sul pavimento sconnesso e lavato. Mi ha ordinato di andare in camera. Sono rimasta con i vestiti bagnati addosso fino a sera. Non l’ha detto a mio padre. Prima del suo arrivo l’aveva già dimenticato. Tornava tardi o non tornava affatto, il cane senza nome gli abbaiava contro, nonostante si differenziassero solo per il fatto che uno dei due aveva il guinzaglio e la museruola. Mi svegliavo quando compariva in casa, mi trattenevo dal chiamare mamma, preferivo rimanere invisibile. Usciva all’alba. Si lasciava dietro busti di persone morte, quadri di grassi signori in pizzo, che chiamava ritratti di antenati. Mamma ammassava le anticaglie di mio padre nella mia stanza. Io non le coloravo, mi tenevo alla larga dai suoi morti.
Dopo la partenza di mio padre, mamma risistemava casa, spostava gli armadi pesanti nelle stanza, non tirava fuori nulla, era una perdita di tempo, preferiva sprecarlo massaggiandosi la schiena bloccata, forse stavolta si era rotto qualcosa, sarebbe andata dal medico, ma l’unico di cui si fidava era morto da tempo. Entravo nella stanza e non sapevo dove sarebbe stato il mio letto. Il futuro era incerto, temevo che dopo l’ennesimao cambio di posizione dei mobili la mia stanza sarebbe stata assegnata a qualcun altro. Forse volevo scomparire per colpa di mamma, e non di nonna. Per dopo. Non si sa mai.
Ogni tanto qualcuno bussava al portone, il campanello non funzionava, non c’era niente e nessuno per cui ripararlo. I figli dei vicini dell’Estremità tre chiamavano: Malwina, Malwa. La nonna si avvicinava senza fretta, e ogni volta io speravo che avrebbe fatto entrare gli ospiti. No, rispondeva, guardando le faccine sporche. Non voleva disordine convinta che fossi più felice bagnata di pipì sotto al tavolo. Nonna schifosa, dicevo, tutta colpa della nonna. Avvertiva subito la presenza del postino, con la coda dell’occhio miope riusciva a scorgere un pezzo di berretto blu con l’aquila rovinata che spuntava per un attimo da dietro il cancello verde scrostato. Lo riconosceva dall’abbaiare del cane, più feroce del solito. Veniva ogni due mesi con la bolletta dell’acqua, e due volte l’anno, subito dopo le feste, con una cartolina con un Gesù neonato o morto accompagnato dalla regina britannica su un francobollo, sempre di colore diverso, e sempre gli stessi auguri, nemmeno la virgola cambiava posto. Buone feste da Tadek e famiglia. È così che i miei morti mi contattavano. Ma una volta il signore delle poste è arrivato due settimane dopo aver consegnato la bolletta dell’acqua, a giugno, e nemmeno Gesù può ritardare così tanto la sua venuta nella gloria. Quel giorno il dolce al formaggio non andò sprecato: la nonna ricevette una scossa, le calorie venivano bruciate così come anche il fienile, mentre lei sfrecciava attraverso il giardino come Olga Bondarenko (3) nei tremila metri. Il postino, non meno incuriosito, le aveva consegnato un pacco avvolto in carta grigia, stracciata dall’incuria o dall’impazienza, timbrata in inglese, con il cognome della nonna e Estremità dieci scritti a mano. Il postino saltellava attorno alla nonna come un gatto in calore, e lei si spostava, restia a un contatto ravvicinato. Aveva preso il pacco sottobraccio e sbattuto il cancello. Il postino deve essere rimasto fermo dietro la recinzione a lungo, perché il cane a furia di abbaiare ha iniziato a schiumare. Tornata a casa, ha posato il pacco sul tavolo. Ci camminava intorno, cambiando i percorsi tracciati. Chiedevo cosa fosse il pacco, ma sembrava che non mi sentisse; il suo udito era buono solo quando ne aveva bisogno. Si è decisa ad aprire il pacco soltanto quando è tornata la mamma. Ha preso un coltello da un cassetto e ha praticato un parto cesareo, un’ostetrica diplomata in dolori. Ha gettato la carta nella stufetta e il fuoco l’ha bruciata. La mamma ha aperto la scatola. Ne è uscito un pezzo di pelliccia. La nonna ha sibilato qualcosa, l’animale morto taceva, peli e polvere si sono sparsi per la cucina, aleggiando nell’aria. Subito dopo dalla scatola è uscito fuori il fratello gemello. A ogni berretto con uno spillo dalla capocchia blu era attaccato un bigliettino. Piccolo e storto. Su uno c’era scritto: Lotka, sull’altro: Ula. Mia nonna e mia madre. Entrambi erano scarabocchiati con mano tremante, simile alla calligrafia di un bambino. Non frignare, ha detto la nonna. Rigirava il berretto di pelo fra le mani spostandolo da un posto all’altro come una pentola piena di zuppa rancida. Lo chiudeva nel comò, lo portava fuori, lo infilava in un cassetto. Non si sa dove metterlo, borbottava.
1.
Marsz, marsz, Dąbrowski: riferimento al ritornello dell’inno nazionale polacco.
2.
dal russo: “Cosa dici, cosa. Cazzo”.
3.
ex mezzofondista sovietica.