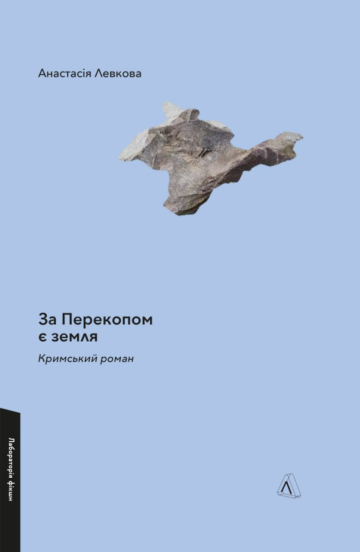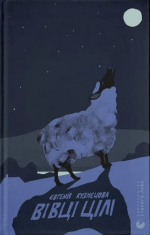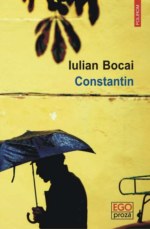Più o meno in quello stesso periodo, la città mi aveva travolta.
Cos’era accaduto fino ad allora? La strada per tornare a casa da scuola, lungo la quale serpeggia il fiume Čuruk-Su, le case e gli orti sulla nostra via, il distretto n°6 sulla collina in lontananza, i chioschi e i ristorantini su entrambi i lati del Khansaraj (1); e, naturalmente, il Khansaraj stesso, con quel cortile in cui potevo non sbirciare per anni, ma che rimaneva impresso nella mia mente con il suo tetto di tegole, gli scuri intagliati, i dipinti e i minareti. Ogni venerdì sentivo l’adhān dalla moschea del Khan nella mia stanza; c’erano altre moschee in cui l’adhān veniva recitato ogni giorno, in casa nostra non lo sentivamo ma si leggeva chiaramente sul volto della città. La presenza di un minareto cambia subito tutto.
Ad avermi insegnato ad amare la città in modo consapevole era stato Borja. Era maggio ed eravamo un gruppetto bello variegato.
Borja si era trasferito da Alupka, dove era cresciuto con le nonne, a Bachčysaraj, dove abitava la madre, che lavorava in un ospedale del posto già da cinque anni. Borja sapeva di v e d e r e la città perché era un visitatore. Lui v e d e v a il Khansaraj, noi invece no. Per noi era un elemento familiare del paesaggio fin da quando eravamo bambini, ci andavamo ogni tanto in gita scolastica e per la “catena umana” con i veterani tra i meleti, accanto al monumento al Milite Ignoto. Capivo che per Achtem, Alije e Chalila tutto quel cortile – con la moschea, le terrazze, il cimitero del khan, il palazzo dell’harem, i bagni – doveva essere qualcosa di diverso da quello che era per noi; ora diremmo che era il loro luogo di forza ma, per quanto fosse strano, Borja conosceva il palazzo del Khan e l’intero Bachčysaraj ancora meglio di Achtem. Era stato lui a dire che il cortile del palazzo, proprio accanto alla moschea, in origine non era recintato, che le mura erano apparse nel XVII secolo per proteggerlo dall’arrivo di Potëmkin e del suo esercito.
Borja diceva che Čufut Kale, dove ero stata solo per dei picnic scolastici, era un prodigio: di grotte, mausolei e kenasa (2) del genere non ce n’erano da nessun’altra parte. Aveva anche detto che, quando si segue la corrente del fiume Čuruk-Su, è come viaggiare nel tempo, dato che gli edifici intorno sono allineati da quelli più antichi ai più recenti. Era da Borja che avevo scoperto che l’ospedale psichiatrico della nostra città non era sempre stato tale, ma che all’inizio fungeva da madrasa di Zincirli (3). Lui e Achtem-oca (4) sapevano – mentre gli altri no – che sulle nostre rocce, a volte di colore grigio, rosa, beige o bianco a seconda del momento e del luogo da cui si guardano, erano stati piantati di proposito dei pini per evitare che franassero. “Non vedete che crescono a macchiette?”, aveva detto Borja così mascolino, e il diminutivo macchiette uscito dalla sua bocca faceva tenerezza.
Fu allora che sentii la parola tatara di Crimea sandyk, scrigno. Mi sembrava che la Crimea fosse un sandyk di favole, un sandyk di pietre preziose, mentre Bachčysaraj un sandyk nel sandyk, uno scrigno nello scrigno.
Le foglie arricciate alla sorgente da cui sgorga il Čuruk-Su. Le strade acciottolate con curve spigolose che conducono bruscamente verso il basso. Le tegole rosse. Le finestre a bulbo. Le scritte in diverse lingue sugli edifici. Probabilmente tutto questo lo si può vedere anche altrove, ma a completare il quadro si aggiungono i minareti slanciati, i mausolei-türbe (5) e l’onnipresente profumo di timo e lavanda: da bambina non avrei mai pensato che avrei dovuto imprimermelo nella mente, così da poterlo sempre rievocare ogni volta che ne avessi avuto bisogno, perché non sarei mai più stata in grado di vederlo e sentirlo dal vivo.
(Anni dopo avrei avuto paura di dimenticare le strade della città. Mi sarei iscritta al gruppo di Bachčysaraj sui social media per amore delle foto. Le avrei guardate per non dimenticare. Mi sarei ricordata della collezione di foto stampate che Chalil aveva scattato su pellicola quando eravamo adolescenti, una raccolta che era rimasta a casa dei miei genitori, a cui avrei chiesto di scannerizzare le immagini e inviarmele per e-mail. Avrei aperto Google Maps per “percorrere” le strade, per ricordarmi la posizione degli edifici, le anse del Čuruk-Su, l’aspetto del terreno grigio chiaro della steppa e le rocce che facevano da muri, i pini piantati “a macchiette”. Avrei letto Şamil Alâdin (6) per ricordare la città che non avevo potuto conoscere e che non esiste più, ma che vive nei suoi mattoni, si libra nell’aria, ribolle nel terreno.)
Diversi antenati di Borja avevano vissuto in Crimea sin dall’antichità: alcuni, forse, sin dall’inizio dei tempi, altri dal XIX secolo. Il trisnonno era giunto qui dal governatorato di Orël, quando era stata abolita la servitù della gleba nell’Impero russo; era arrivato per costruire palazzi perché sapeva come farlo e la Crimea si stava sviluppando intensamente. Suo figlio, il bisnonno di Borja, aveva studiato architettura e aveva sposato una donna del posto, una caraita. Nel 1935 era stato inviato a Nikolaevsk-na-Amure, nell’Estremo Oriente russo, a costruire la città. La nonna di Borja era nata lì insieme alla sorella gemella. Nel 1937, il bisnonno era stato imprigionato e, sei mesi dopo, fucilato. “Avrebbero potuto non fucilarlo”, aveva raccontato Borja. “Il campo di concentramento non era così lontano: ce n’erano parecchi nella regione dell’Amur”.
In quanto membri di una famiglia di un “traditore della patria”, la bisnonna e i figli erano rimasti nel territorio di Chabarovsk sino alla fine della guerra, poi avevano cercato di trasferirsi. Era impossibile tornare in Crimea nell’immediato: nel migliore dei casi sarebbero stati rispediti indietro, così ogni sette anni si spostavano sempre più a ovest, stabilendosi ogni volta in prossimità di quelle zone e lavorando lì come liberi professionisti: da Blagoveščensk (7) al Kazakhstan.
Nessuna delle figlie si sposò e le due sorelle gemelle vissero insieme per tutta la vita. Una delle due diede alla luce una bambina, la mamma di Borja. Entrambe le nonne erano infermiere, entrambe mamme della mamma di Borja e nonne per Borja. Nessuno in famiglia si era mai iscritto al partito, “non riuscivano a vincere la nausea”. Nemmeno la mamma di Borja si sposò mai. All’inizio lavorava come ostetrica a Jalta ma, dopo l’ennesima storia d’amore non andata a buon fine, l’ultima con il primario del reparto maternità, volle trasferirsi in un’altra città e aspettò un posto vacante a Bachčysaraj.
Eravamo rimasti a Borja e al suo bisnonno-architetto. Mah, forse erano alla pari con Alije: il trisnonno era un artista, la bisnonna in esilio comunicava con Sabrije Eredžepova (8) e il nonno conosceva Rollan Kadijev (9).
Chi ero io accanto a Borja, ad Alije e Chalil, ad Achtem? Gli amici dei miei genitori erano perlopiù ingegneri, commercialisti e funzionari locali, mio papà lavorava in un cementificio, mia mamma alle finanze, e io non avevo nulla di cui vantarmi in quel gruppo. Inoltre, avevo poco da raccontare sui miei nonni: nulla sui nonni di Perm’, poco su quelli crimeani. Non potevo e non volevo. Mi vergognavo di parlare di queste cose davanti a loro.
***
Inna Ivanivna, la nostra esaltata Inna Ivanivna, quando leggeva Puškin a lezione si asciugava le lacrime e beveva valeriana, mentre quando parlava dei personaggi di Dostoevskij diceva (e ciò doveva essere annotato nel quaderno, che avrebbe controllato in seguito, correggendo la difficile punteggiatura): “La grandezza della letteratura russa sta nel fatto che, nei confronti del protagonista, persona che porta distruzione, il lettore non prova odio ma compassione e, grazie alla penna degli illustri, comprende ogni movimento dell’anima di tale persona, piccola (10) e afflitta dal dolore”.
In quel periodo Inna Ivanivna parlava con entusiasmo della serie L’impero russo, che veniva trasmessa di tanto in tanto su NTV e di cui pareva stesse per andare in onda le stagioni successive.
«Possiamo ritenerci fortunati a vivere in un’epoca in cui vengono proiettati film di questo genere. Dovremmo essere orgogliosi di vivere in Crimea, perché è una terra che è stata formata da illustri scrittori russi, rispettati in tutto il mondo: Sanja (11) Seergevič Puškin, Lev Nikolaevič Tolstoj, Anton Pavlovič Čechov… Questi scrittori sono benedetti, e anche noi, crimeani, lo siamo perché a un passo dai palazzi reali benedetti di Livadija, di Voroncov... Possiamo sfiorare tutta questa grandezza. Ma lo sentite che è davvero nostra?», chiedeva in estasi Inna Ivanivna.
Avevo visto anche io quella serie. Non mi era piaciuta Caterina II, ma mi dispiaceva per l’assassinio di Nicola II e, soprattutto, per le figlie e il figlio affetto da emofilia. Non erano ancora usciti degli episodi su di loro, ma avevo letto qualcosa in proposito.
Non mi piaceva l’entusiasmo di Inna Ivanivna, con le sue lacrime e la sua valeriana. Il suo pathos mi infastidiva. Anche i miei compagni di classe ridevano del suo stile altezzoso, ma quello che non potevo perdonarle era un’altra cosa: le discussioni con El’zara sulla sua lingua madre.
Durante la lezione in cui si discuteva di questo, El’zara aveva detto che la sua lingua madre era il tataro di Crimea. Inna Ivanivna le aveva chiesto: «Parli davvero così bene il tataro di Crimea? Meglio del russo?»
El’zara non era riuscita a rispondere di sì.
«El’zara, in tal caso, come puoi considerare il tataro di Crimea la tua lingua madre, se quasi tutta la letteratura che leggi sin da quando eri bambina è in russo, se parli e scrivi perlopiù in russo? E, in fin dei conti, era possibile farlo anche in esilio. Ma tu addirittura pensi in russo!»
«Non sono diversa dagli altri tatari di Crimea della mia età da questo punto di vista», aveva risposto El’zara. «Per qualche ragione, però, il 92% della mia gente ritiene che il tataro di Crimea sia la sua lingua madre».
«Se così fosse, dovrebbe parlarla, ci dovrebbero essere dizionari, libri, trasmissioni in tataro di Crimea… Dove sono?»
«Scusi, ma ci sono delle ragioni se mancano tutte queste cose… Per mezzo secolo i tatari di Crimea hanno avuto la possibilità di usare la propria lingua solo nella vita quotidiana perché vivevano in terra straniera; e anche ora che sono tornati in patria non possono usare pienamente il tataro di Crimea perché intorno a loro parlano tutti russo».
«El’zara», sospira Inna Ivanivna. «Se una lingua non si sviluppa non è perché tutti gli altri ne parlano un’altra. È perché alla base di quella lingua non c’è una predisposizione allo sviluppo. Se una lingua è completa alla base, può funzionare in qualsiasi condizione. Hai mai sentito parlare di un quartiere di New York che si chiama Brighton Beach? Prova a immaginare: l’America, la lingua inglese e un quartiere a sé stante dove quasi tutti parlano russo, dove ci sono stazioni radiofoniche, studi televisivi e redazioni di giornali in lingua russa. Com’è possibile? Ma aspetta, non ho finito. Per una persona la lingua madre è quella in cui si pensa; quindi non ci sono i prerequisiti per parlare del tataro di Crimea come di una lingua madre».
El’zara lì per lì non sapeva cosa rispondere, così su due piedi, ma di certo non era d’accordo, quindi scuoteva la testa titubante. Mi sono poi ricordata di una lezione di un anno prima, all’inizio delle superiori, una lezione sulla produzione letteraria della mia
terra. Una delle opere era di Seitümer Emin (12). A quel tempo Lenur non studiava più con noi, mentre El’zara – guarda un po’! – era assente. Zojka Vaščučka, dopo aver visto il cognome sotto l’opera, aveva esclamato: “Questo non è uno scrittore russo! È un tataro di Crimea, senza dubbio. Perché studiamo questa poesia durante un corso di letteratura russa?”. Inna Ivanivna aveva risposto: “Ragazzi, non entriamo nel merito di queste questioni. Tutti quelli che studiamo sono scrittori russi”.
Dopo il dialogo con El’zara sulla lingua madre avevo capito che non avrei mai e poi mai potuto trattare Inna Ivanivna come l’anno prima, quando avevo appena iniziato a frequentare le olimpiadi scolastiche e andavamo insieme al Centro culturale russo, quando passavamo davanti al Kujbyšatnyk (13) con tutte le voci dei bambini che risuonavano. Inna Ivanivna percepiva quel cambiamento, a volte lo diceva davanti a tutti o in privato:
«Eh, Utajeva…»
Io la guardavo con aria interrogativa. Lei una volta provò a dirmi:
«Ascolti storielle incredibili invece di sviluppare il tuo talento letterario. O forse vuoi diventare una scrittrice ucraina o tatara di Crimea?»
Non sapevo cosa rispondere, perciò avevo solo alzato le spalle dicendole: «Non capisco di cosa stia parlando»
«Ti ricordi Puškin?», aveva ribadito l’insegnante, che in ogni situazione riusciva a tirare fuori una citazione del re-sole della poesia russa. «I torrenti della Slavia confluiranno nel mar russo…(14)»
Era la prima volta che sentivo quei versi. Non conoscevo affatto la produzione letteraria di Puškin.
1.
Han Saray in lingua tatara, è l’ex residenza dei Khan di Crimea situata nella città di Bachčysaraj, ora Museo di storia e cultura dei tatari di Crimea. [N.d.T.]
2.
Kenasa o kenesa indica il luogo di preghiera degli ebrei caraiti dell’Europa orientale. [N.d.T.]
3.
Madrasa (scuola secondaria e superiore musulmana) fondata nel 1500 dal khan di Crimea Meñli I Giray a Salačyk, la prima capitale del khanato di Crimea (oggi Salačyk è un quartiere di Bachčysaraj). [N.d.A.]
4.
Letteralmente: “insegnante”. Il termine “oca” [odʒa] per i tatari di Crimea non indica solo il nome della professione, ma è un titolo di particolare rispetto per una persona impegnata in diversi ambiti. [N.d.T.]
5.
In lingua turca il termine di origine araba türbe ha il significato di tomba. Indica, nello specifico, i piccoli mausolei costruiti per nobili e reali dell’Impero ottomano. [N.d.T.]
6.
Şamil Alâdin (1912-1996) è stato uno scrittore, traduttore e attivista tataro nato nella penisola che lottò tutta la vita per i diritti del popolo di Crimea anche dall’esilio, che ebbe fine nel 1994. [N.d.T.]
7.
Città dell’Estremo Oriente russo e capoluogo dell’oblast’ dell’Amur. [N.d.T.]
8.
Sabrije Eredžepova (1912-1977) è stata una cantante tatara di Crimea che ha interpretato anche le canzoni nel film “Il cosacco oltre il Danubio” (1937). [N.d.A.]
9.
Rollan Kemal oğlu Qadıyev (1937-1990) è stato un fisico sovietico, dissidente e attivista per i diritti umani, tra i leader del movimento nazionale tataro di Crimea negli anni Sessanta e Ottanta. [N.d.T.]
10.
Riferimento al “piccolo uomo” (malen’kij čelovek), tipo di eroe letterario russo dell’inizio del XIX secolo che indica una persona di bassa estrazione sociale e priva di carattere o talento. [N.d.T.]
11.
Sanja è il diminutivo affettuoso del nome Aleksandr. [N.d.T.]
12.
Seitümer Emin (1921-2004) è stato un poeta, scrittore e attivista per i diritti civili dei tatari di Crimea in esilio, nonché partigiano durante la Seconda guerra mondiale. [N.d.T.]
13.
Si tratta di Piazza Kujbyšev, situata in un quartiere di Sinferopoli che ospita numerosi edifici pubblici, tra cui il palazzo dei pionieri. In gergo viene talvolta chiamata dagli abitanti kubyk o, appunto, Kujbyšatnyk. [N.d.T.]
14.
Verso tratto dalla poesia “Ai calunniatori della Russia” di Aleksandr Sergeevič Puškin del 1831; traduzione italiana a cura di Paolo Statuti. [N.d.T.]