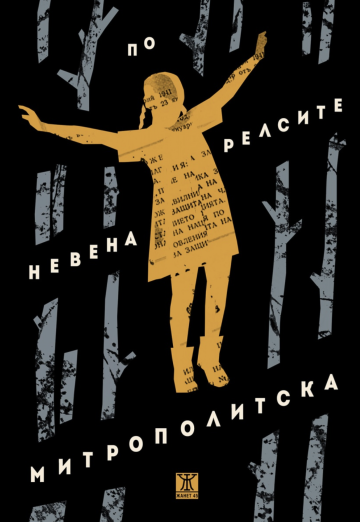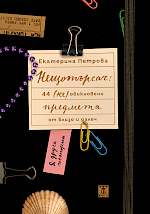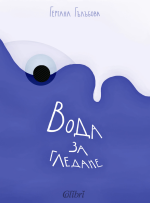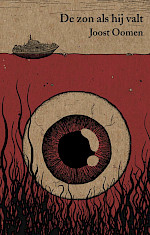Rebeka, marzo 1943
Era il sei marzo mattina, due giorni dopo la notizia che ci avrebbero deportati in un posto a nord, quando papà mi disse che ci sono momenti in cui niente dipende da noi e dobbiamo sottometterci al destino. Gli chiesi se anche quello era uno di quei momenti.
«Non lo so, Beka» mi rispose e mi accarezzò la testa. «Vorrei poterti dire che anche adesso abbiamo scelta. Vorrei poterti dire che abbiamo sempre scelta. Solo che non posso dirti niente».
«Mi hai insegnato che non bisogna mai disperarsi, vero?».
«Sì».
«E che vale sempre la pena fare un altro tentativo».
Lui annuì.
«E adesso? Perché adesso non ne vale la pena, papa? Proprio adesso!». «Non vedo cosa si possa fare».
«Fuggire».
«E dove? Ci nascondiamo in montagna? L’inverno non è ancora finito». «Chiederemo a qualcuno di nasconderci a casa sua. Zio Mitko e zia…». «Non possiamo metterli in pericolo. E poi sicuramente ci scoprirebbero».
«E allora pensa a qualcos’altro, sei adulto, no? Se un decimo di quello che ha letto Aron è vero…».
«Lo so, Beka».
«No, papa, non lo sai!». Battei il piede sulla pozzanghera congelata davanti a me e quella si sbriciolò. «Non sai un bel niente!».
E ci credevo davvero.
Sei giorni prima era trascorso un mese da quando León aveva suonato davanti a me la Serenata di Schubert. Non ci eravamo messi a pensare cosa segnasse la data, ma non avevamo dubbi che fosse importante. Istintivamente proteggevamo tutto ciò dalle parole, come se l’avrebbero reso meno etereo. Andavamo a piedi insieme alle nostre rispettive scuole e ogni volta che era possibile facevamo la strada in due anche al ritorno. Alle volte, quando non vedevamo gente attorno, ci tenevamo per mano. Perfino quello non lo facevamo sempre, ci sfioravamo le dita mentre camminavamo, le intrecciavamo per un attimo, come per caso, ci scambiavamo sguardi. Dopodiché facevamo avanti e indietro accanto ai negozietti chiusi all’imbrunire tra i quartieri Kapijata e Adžundar e tacevamo. Tanto era forte il sentimento che ci aveva inondato con quella musica da avere bisogno di fare due passi per calmarci. In altri casi parlavamo: delle nostre famiglie, di musica lui, di letteratura io. Allora scrissi la mia prima poesia e la lessi unicamente a lui. Avevo iniziato a pensare in versi, e anche le mie più banali osservazioni mi accorrevano in testa rimate. Sapevamo che sparlavano di noi, che pestavamo fango, che si propagava la guerra, che eravamo circondati da ingiustizie, sofferenze. Lo sapevamo, ma non permettevamo che niente si avvicinasse a noi, lasciavamo che scorresse nei fossati. Ci eravamo costruiti il nostro mondo, colorato e bellissimo.
E papà ne rimaneva fuori. Era così immerso nei suoi pensieri da adulto, nelle notizie sulla guerra, nel ruolo affidatogli dagli altri, che mi sembrava insensato mettermi a dargli spiegazioni. “Non vedo cosa si possa fare”, me l’aveva detto così, senza rendersi conto di quanto suonasse crudele. Lo odiavo in quel momento, volevo che provasse dolore affinché mi capisse, pestavo impotente il ghiaccio sotto i miei piedi. Mio padre non aveva quindici anni. Lui e mamma avevano vissuto il loro amore, avevano condiviso i loro momenti importanti, messo da parte i loro luminosi ricordi. Nessuno poteva portargli via tutto ciò.
«Quando andremo in Polonia, anche se non abiteremo vicini, risparmierò i soldi per una bicicletta e ogni giorno dopo il lavoro verrò a trovarti», mi aveva detto León quella stessa mattina.
Non gli dissi che non ci credevo – mio padre insisteva perché tacessi. Girai soltanto la testa.
Le voci sulla deportazione si erano già sparse. Già la sera del quattro un avvocato, compagno di scuola di mio padre, improvvisamente passò da casa. “Che ne dici di fumarci una sigaretta in cortile?”, propose a papà. “Con questo freddo?”, fu la basita risposta. Ma l’espressione dell’ospite era eloquente. Li osservavo dalla finestra: si erano messi dietro il susino, quell’uomo gli parlava con fare serio, gli appoggiò una mano sulla spalla, mentre lui con acredine spense il mozzicone col piede. Rientrò impallidito.
«Ci deporteranno. In questi giorni», disse dalla porta.
Si sentì un tintinnio metallico. La pentola che mia madre stava avvicinando al fornello rovinò sul pavimento, pezzetti di rapa si sparsero ai suoi piedi.
«Dove?»
«Lontano, cari miei». Il viso di papà era senza vita, soltanto le labbra si muovevano, come staccate da esso. «Lì da dove non c’è ritorno».
Da quel momento in poi venimmo sommersi da storie confuse e spaventose. Il compagno di scuola di papà rispondeva degli immobili di Kjustendil requisiti dallo stato. Qualche giorno prima gli aveva fatto visita un funzionario del Commissariato per le questioni ebraiche (1), chiedendo di mettergli a disposizione il deposito di tabacco Fernandes, accanto alla stazione. L’avvocato si era rifiutato di farlo senza che gli dicessero il motivo. Il funzionario aveva convenuto controvoglia, a condizione che l’avvocato avesse giurato di mantenerlo segreto: era questione di eccezionale importanza nazionale. C’era un accordo firmato con la Germania per l’immediato trasferimento degli ebrei in quella che una volta era la Polonia e il deposito serviva loro per radunarci prima di farci salire sui treni. Data dell’estradizione: dieci marzo, poco dopo mezzanotte.
La sera seguente, cinque marzo, papà rientrò con altre due brutte notizie: il sindaco aveva richiesto alla comunità ebrea di garantire tempestivamente trecento secchi, trecento mestoli, pentoloni e altri oggetti casalinghi, senza precisarne lo scopo. Mamma iniziò a fare i bagagli. Guardò le valigie, ma disse che non erano comode, e decise di cucire degli zaini. Cercava un modello adatto – chiedeva a vicine di casa e amiche; le serviva stoffa – ritagliò i copriletto, la macchina da cucire riprese a sferragliare. Mentre cuciva le veniva in mente qualcosa, si lanciava in una direzione e poco dopo tornava con lo sguardo confuso, incontrava altre donne in preda al panico. Rammendava calzini, faceva guanti a maglia, cercava borracce, sfornava fette biscottate. Una volta apparve con le forbici, per tagliarmi le trecce. Dicevano che avrebbero diviso i figli dalle madri e sarebbe stato difficile per me con i capelli lunghi. Mi rifiutai e lei non insistette. Si rimise a far sferragliare senza pietà la macchina da cucire.
Mentre i bambini erano felici. I piccoli ebrei erano felici. “Saliremo sul treno e andremo nei paesi stranieri!”, con questo grido mi venne incontro Haim, sei anni, del nostro quartiere. Anche gli altri bambini se ne vantavano. Volevano salire sul treno più grande e andare lontano lontano, fino al mare. Più giù lungo la nostra strada vidi un treno disegnato con un bastoncino nel fango. Stavo per rimproverare i piccoli artisti, per spiegargli che non c’era di che gioire, ma fissai i loro occhietti luminosi e rimasi zitta. Quando lo stesso venerdì andai a casa di León lui non c’era, ma mi accolse Blanca. “Ho ordinato a papà una pomata e lui me l’ha fatta”, si vantò, la prese e me la sventolò in faccia. “In Polonia ci faranno lavorare nei campi e dobbiamo proteggerci la faccia dalle scottature. La ordino anche per te?”. La guardai: così fragile, i suoi occhi brillavano, le braccia si agitavano emozionate. La abbracciai e uscii.
Avanzavo lungo la strada, incrociavo persone crucciate che andavano di fretta e non capivo: la maggior parte degli adulti credeva che ci avrebbero portato in Polonia a lavorare. Non che si aspettassero belle cose, prevedevano povertà, fame, malattie e duri inverni in terra straniera. Ma diversamente da me, si immaginavano vivi.
«Papa, perché non dici loro cosa c’è scritto in quel giornale?» chiesi a mio padre mentre andavamo dai vicini.
«Non è certo che sia vero».
«E se lo fosse? Non è meglio saperlo?».
«E a saperlo che cambia?».
«Decideranno cosa fare».
«Non possono fare niente, ragazza mia. Se avesse senso glielo direi. A me dispiace averlo sentito. Non si va avanti senza speranza».
Lanciai uno sguardo alla sua esile figura nel cappotto grigio. Mi affrettai in avanti e i suoi passi si affievolirono dietro di me. Mi dispiaceva essere cresciuta. Mi dispiaceva che mio padre si fosse rimpicciolito.
“Ho paura di sparire. E che nessuno se ne accorga. E che non mancherò a nessuno”.
Questo avevo detto a mio padre qualche anno prima, per il Capodanno degli alberi, quando i bambini erano usciti senza di me. All’epoca lui mi aveva tranquillizzata, ma ecco che la mia paura era tornata ancora più forte. Guardavo la nostra modesta camera con i due letti per me e Aron, la piccola scrivania, il calamaio con il portapenna rotto, guardavo le mensole con i miei amati libri e l’armadio a muro con la piccola anta rotta. In quella camera avevo giocato, avevo pianto, avevo riso, mi ero nascosta, addormentata, persa in sogni, avevamo chiacchierato fino a tardi con mio fratello. Guardai fuori dalla finestra e vidi la collina Hisarlăka: ancora mesta, spoglia, ma consistente e salda al proprio posto. Potevo osservarla per ore e ogni volta scoprivo qualcosa di nuovo. Amavo quella casa. Amavo quella città – gli amici, la montagna, i frutteti zuppi di colore, il variopinto mercato, le bottegucce polverose, gli edifici impettiti. Amavo quella terra – lì dove erano nata, dove erano nati i miei genitori e i loro genitori, e i loro genitori. La sola che conoscevo.
E vedevo che il nostro amore non era reciproco. Lei era parte di me, ma io non ero parte di lei. Per lei io ero superflua, persino dannosa. Mi avrebbero grattata via come una macchia sporca dal selciato per caricarmi su un treno e buttarmi nella discarica. E poco dopo in quella stanza avrebbero messo piede altre persone, sul letto avrebbe sognato un’altra ragazza – una col sangue più ariano, sulle mensole ci sarebbero stati altri libri, il portapenna con la punta rotta sarebbe stato sostituito, un altro avrebbe fissato Hisarlăka oppure non ci avrebbe fatto caso, un altro al posto mio sarebbe andato a scuola. Le persone sono facilmente sostituibili. Oppure forse non le persone, bensì gli ebrei. Li carichi su un treno, quelli spariscono, fine, già vengono dimenticati. E la vita continua. Continua senza di me.
«Quanto sei bella, Beka!». Mamma aveva alzato la testa dalla macchina da cucire, cuciva il terzo zaino e il suo piede era immobilizzato al pedale. Il silenzio che seguì le sue parole si fece pesante. Stava fissando la mia faccia, come se mi vedesse per la prima volta. Dopodiché il suo sguardo mi attraversò e si offuscò. Brividi mi trafissero.
In mezzo ai preparativi per la partenza, in mezzo a tutto il panico, mamma aveva scoperto che ero bella. Prima di allora non me l’aveva mai detto. Non che non avessi percepito di piacerle: annuiva soddisfatta mentre mi osservava, mi faceva le trecce, e mi presentava con un’espressione entusiasta alle amiche.
«È tutto a posto, mamma?».
Lei concentrò lo sguardo su di me, si alzò e mi si avvicinò.
«Sei così bella!», passò le dita sulla mia fronte, guancia, mento. Nei suoi occhi – orgoglio e paura. «Assomigli a mia madre da giovane, e lei era bellissima. Sei anche più bella di lei, Beka».
La mia preoccupazione cresceva, volevo nascondermi da quello sguardo che mi squadrava. Mi tirai indietro e la sua mano rimase a mezz’aria. Lei quasi non ci fece caso e continuò a fissarmi.
«E sei così giovane».
«Come te ne sei accorta proprio ora?».
«Lo sai che dovrai stare attenta a te stessa, vero? A malapena mi lasceranno essere sempre accanto a te».
«Tutti dobbiamo stare attenti. A che serve però se comunque moriremo?». «La morte non è la cosa più spaventosa, tesoro».
Mi accarezzò con le dita tremanti.
«Esco», si staccò da me. «Vado da Rivka. Torno presto».
A mezzogiorno il tempo si addolcì, il fango si sciolse, si attaccava alle suole e i miei passi si appesantivano. Camminavo lungo la nostra strada, oltrepassai la casa di León, mi trattenni dall’impulso di sbirciare dalla finestra. Lì c’era il ragazzo a cui collegavo tutta la luce del mio futuro. Poco prima da lì era uscita mia madre con un pacchettino di polvere bianca in mano. Era per me, conteneva cianuro e mamma aveva intenzione di cucirlo nell’orlo del mio cappotto. Così, perché non si sa mai. Me lo disse come se mi stesse porgendo un fazzoletto da naso.
«Dammelo» le dissi.
Lei non si mosse. Il suo volto era rigido e pallido. Mio padre si avvicinò a noi, guardandola sconvolto.
«Dammelo» ripetei.
Invece di aprire il suo palmo lo strinse in un pugno. Mi ricordo quel pugno, come l’avessi adesso davanti agli occhi – la pelle secca, le vene in rilievo, le nocche bianche – tremava come attraversato da una scossa. Mi chiedevo se avrebbe trovato le forze di andare fino in fondo. Speravo non le trovasse. Il pugno si schiuse e il pacchettino passò nella mia mano.
«L’hai preparato per tutti?».
«Non posso chiederne ancora a Bohor. Tu ne hai più bisogno».
«Perché?».
«Solo se ti mettono le mani addosso».
«A tutti ci possono mettere le mani addosso».
Il viso di mamma si contrasse; provò ad accarezzarmi, ma mi scostai. Staccai gli occhi da lei, non riuscivo a guardare il suo dolore.
«A te possono farlo anche in quanto donna. Sei così bella, tesoro mio».
Papà con una mano di strinse gli occhi, mentre con l’altra abbracciò mamma. E io, stretto il pacchettino in mano, scappai fuori.
Camminavo lungo la nostra strada, il fango si era ancorato alle mie suole e la mia andatura si faceva sempre più pesante. Avevo oltrepassato la casa di León, probabilmente anche il mio amore, i miei sogni, e la vita. Tutta la mia vita era dietro di me, tutti i miei quindici anni. Mi ero immaginata che fossero solo l’inizio. Davanti a me si stendeva soltanto fango, appiccicoso e rivoltante, e vorace, e era scritto che dovevo affondarci dentro – più o meno dolorosamente. Più o meno dolorosamente, quella era la mia unica scelta.
Pestavo il fango della mia strada in quel giorno di marzo, il sole aveva trapassato le nuvole, accarezzato la terra, sciolto il ghiaccio. Lo pestavo e mi chiedevo se valeva la pena continuare. Valeva la pena battermi? Contro cosa? Contro chi? Contro quelle genti sconosciute che volevano deportarci? Contro Hitler in Germania? Dov’erano? Oppure contro la mia amorevole madre, che mi aveva dato il veleno per regalarmi una morte dignitosa? Non lo sapevo. Ma non volevo fermarmi. Preferivo avanzare finché il fango non mi avesse divorato. E affondando avrei sentito la gioia del movimento, della speranza. Che forse proprio quella volta sarebbe accaduto un miracolo. Che proprio io me la sarei cavata. O che nell’attimo prima di affondare avrei scorto il riverbero del sole o il riflesso di un albero. Un ultimo attimo di bellezza. Non vale forse la pena battersi per questo?
Estrassi il pacchetto, lo ruppi e lo rovesciai nel fango. Poi mi voltai e ripresi la strada di casa.
1.
Istituzione statale esistita tra il 1942 e il 1944 allo scopo di condurre la politica di rimozione degli ebrei dalla società bulgara e di estradizione dalla Bulgaria (NdT).