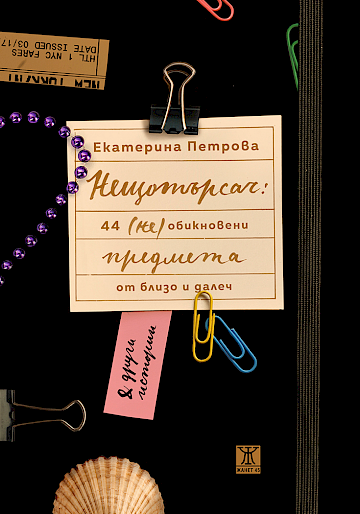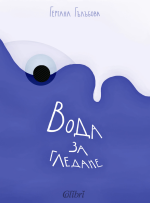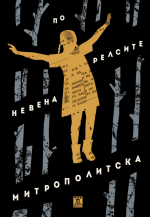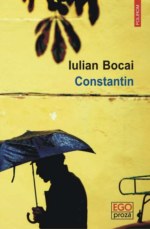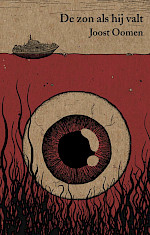Il mondo è pieno zeppo di cose, e ci vuole proprio qualcuno che si occupi di trovarle. Questo è appunto il compito dei cercacose.
Pippi Calzelunghe, Astrid Lindgren
traduzione di Donatella Ziliotto, Annuska Palme Sanavio e Samanta K. Milton Knowles
E così Dorothy si mise in cammino [...]. C’erano molte strade lì intorno ma non fu dif icile trovare quella lastricata di pietre gialle e Dorothy vi si inoltrò camminando di buona lena. Le scarpette d'argento risuonavano allegramente a ogni passo e lei non si sentiva né sola né triste come sarebbe stato logico in una bambina risucchiata con la sua casa e lontana dal suo paese per colpa di un ciclone, piombata in luoghi sconosciuti.
Il mago di Oz, L. Frank Baum
traduzione di Rossana Guarnieri
I mattoncini gialli
Sul nebuloso passato e l’incerto futuro di uno dei simboli architettonici di Sofia
Anni fa una mia amica ungherese venne a trovarmi a Sofia. Durante la doverosa passeggiata tra le attrazioni cittadine ci ritrovammo nella piazza di fronte all’Assemblea Nazionale, quando Agnes, invece di osservare la moltitudine di importanti edifici nei dintorni, si mise a fissare il selciato. Con le scarpe rosse che casualmente aveva indosso mi sembrò Dorothy di Oz in carne e ossa, con la differenza di essere atterrata sulla strada lastricata di mattoncini gialli non dal Kansas, ma da Budapest. Le spiegai che pur essendo uno dei simboli più riconoscibili di Sofia i mattoncini in realtà condividevano il suo luogo di nascita, e Agnes scherzò dicendo che sicuramente per quello lì si sentiva come a casa propria. Quando mi domandò come i mattoncini fossero arrivati in città le raccontai la celebre versione sulla loro comparsa nella giovane capitale bulgara nei primi anni del XX secolo in quanto regalo dell’impero Austro-ungarico per le nozze dello zar Ferdinando.
Oltre alle vie centrali di Sofia, oggigiorno i mattoncini gialli paiono ricoprire anche un’invisibile barriera a livello più astratto: da una parte c’è la puramente utilitaria funzione di rivestimento stradale, dall’altra il loro valore sentimentale in quanto attrazione turistica e simbolo storico di Sofia.
Il periodo in cui le vie centrali della capitale vennero ricoperte di mattoncini gialli (1907-1908) coincide con l’apparizione di tutta una serie di edifici emblematici per Sofia: il Teatro nazionale (1906), il Club militare (1907), il Mercato coperto (1911), il Bagno termale centrale (1913), il tempio di Aleksandăr Nevski (1904-1912) (1). Ma a differenza della storia degli edifici, che è ben nota e documentata, quella dei mattoncini è alquanto nebulosa. La loro origine estera viene pubblicamente svelata soltanto nel 1960. Secondo gli archivi citati nel sito della Municipalità della capitale, “i mattoncini di ceramica si ottengono dalla marna calcarea, conosciuta in Ungheria col nome “márga”, che si trova in una cava vicino Buda Pest. La marna estratta viene ridotta in polvere fine, modellata e cotta in speciali forni alla temperatura di 1300 gradi. Sono stati fatti tentativi in Ungheria di utilizzare materie prime provenienti da altre località, ma invano”.
La versione ancora oggi in voga del regalo di nozze però si rivela inattendibile, affermatasi più a causa della sua attrattiva romantica e grazie alle infinite ripetizioni che sulla base di fatti. Di nuovo secondo il sito della Municipalità della capitale “la messa in posa dei mattoncini di ceramica non è un commovente regalo in occasione delle nozze del principe Ferdinando con Maria Luisa, che a quel tempo (1907) già non era più tra i vivi, non è una trovata, bensì l’espressione di una politica comunale sostenuta dallo stato nel periodo della costruzione di una nuova Bulgaria”. In altre parole, i costosi mattoncini gialli furono ordinati, trasportati, importati, collocati – e pagati (con l’aiuto di un ingente prestito!) – dal Comune di Sofia.
Altra differenza sostanziale tra la pavimentazione gialla e le restanti opere architettoniche dell’epoca è la quasi totale assenza dei mattoncini dal mercato dei souvenir. Mentre magliette, cartoline, calendari e modellini con l’ onnipresente immagine della cattedrale di Aleksandăr Nevski sommergono i turisti a Sofia (e non solo 2)), i mattoncini gialli esistono solo in via incidentale, come un dettaglio che non può essere evitato. Questo ovviamente è dovuto in parte alla loro funzione utilitaria: con le sue cupole dorate il tempio si presta molto di più a interpretazioni da souvenir rispetto a una pavimentazione stradale, per quanto possa essere impressionante. E comunque il potenziale per interpretazioni del genere c’è, come testimoniano le repliche barcellonesi delle piastrelle disegnate da Gaudì oppure i souvenir di ogni sorta marchiati con il caratteristico motivo floreale dei marciapiedi di Bilbao.
I mattoncini gialli si differenziano dai loro contemporanei – gli edifici simbolo di Sofia – anche per il loro futuro incerto. Il tempio-monumento di Aleksandăr Nevski, il Teatro nazionale, il Club militare e il Bagno termale centrale subiscono lavori e ristrutturazioni (quanto siano ben riusciti è una questione a parte). D’altro canto, i mattoncini gialli, nonostante il loro valore estetico e l’importante simbolismo storico, pare vengano trattati come una pavimentazione qualunque e – lentamente, irreversibilmente e quasi di soppiatto (o soprattutto con la scusa che sono poco pratici oppure cari da mantenere) – scompaiono dal paesaggio sofiota, molto spesso sostituiti da noioso asfalto. Oltre che tristi, queste sostituzioni fanno anche infuriare, poiché avvengono senza discussioni pubbliche né una chiaramente annunciata strategia per la conservazione del lastricato giallo.
Seppur non mi consideri una grande patriota, i mattoncini gialli per me sono diventati simbolo del forte legame che ho con la mia città natale. Ogni volta che ci passo sopra, specie se sono mancata da molto tempo, nella mia testa appare spontaneamente la frase che Dorothy de Il mago di Oz si ripete come formula magica che la fa tornare da dove è venuta: “Nessun posto è come casa propria”. Per questo anche il sempre più risicato segmento ricoperto di mattoncini gialli in centro città, insieme alla prospettiva che possano scomparire da Sofia del tutto, mi deprimono abbastanza. Però trovo comunque una qualche consolazione al pensiero che probabilmente ancora a lungo ne rimarranno almeno in alcuni posti nel mondo.
Il primo posto del genere lo scoprii quando a mia volta feci visita ad Agnes a Budapest. Mentre passeggiavamo senza meta per la città ci ritrovammo in una viuzza laterale senza uscita a Buda. Di primo acchito mi sentii stranamente a mio agio e pensai di star vivendo un qualche inspiegabile déjà-vu, ma un attimo dopo notai che la strada era ricoperta da mattoncini leggermente trascurati e usurati, che a parte ciò erano del tutto identici a quelli gialli di Sofia. Anni più tardi capitai sui mattoncini gialli di una piccola piazzetta a Belgrado. A differenza di Sofia però, dove i mattoncini sono disposti in un’unica direzione, quelli erano ordinati secondo un più complesso motivo “a scacchiera”. In un modo o nell’altro il loro aspetto era sufficiente per scacciare il lieve attacco di nostalgia che sentivo per Sofia proprio quel giorno, e far sì che il cupo cielo sopra Belgrado sembrasse un po’ più accogliente.
Ecco come dimostrare che comunque ci sono anche altri posti (quasi) come casa propria.
Tshoglham
Sugli stivali per andare piano e l’indice di felicità in Bhutan
Cercando immagini con le parole chiave “Bhutan” e “scarpe” su internet, si ottengono due tipi di risultati. Il primo sono le scarpe sportive turistiche, solide, grezze, con la suola spessa, di colore scuro, bruttine ma superpratiche. Di quelle consigliate agli entusiasti che hanno intenzione di arrampicarsi sui pendii himalayani senza il rischio di distorsioni della caviglia.
Il secondo tipo di risultato è l’esatto contrario: incredibilmente colorati e variopinti stivali fino al ginocchio, il cui genere è totalmente decorativo e quasi tanto distante dalle pratiche scarpe turistiche quanto l’himalayano Regno del Bhutan dalla balcanica Repubblica di Bulgaria.
Gli stivali, noti come tshoglham, sono forse la parte più attraente del vestiario tradizionale maschile bhutanese, che comprende inoltre anche una tunica fino al ginocchio a maniche lunghe, e i cittadini bhutanesi sono tenuti a indossarla sempre quando sono in luoghi pubblici. A differenza del vestito però, gli stivali si mettono soltanto per cerimonie speciali; nella quotidianità il loro posto è occupato da deludenti calzature nere maschili qualunque o scarpe da tennis bianche. Quelle pare siano escluse dal campo di applicazione dell’ordinanza governativa che mira a conservare l’identità nazionale bhutanese sia dalla pressione per la modernizzazione da parte dell’Occidente che dall’influenza di India e Cina, i giganti vicini del piccolo regno himalayano.
Gli stivali si producono tuttora interamente a mano e solo su ordinazione. Il calzolaio a Thimphu, la capitale del Bhutan, che fabbricò i miei, non riuscì a nascondere la propria perplessità per il fatto che una donna volesse ordinare per sé degli stivali da uomo, ma ciononostante si comportò in modo del tutto professionale: delineò il mio piede su un pezzo di cartone e misurò la lunghezza tra la mia caviglia e il mio ginocchio. Dopodiché tirò fuori dei campioni di variopinte stoffe satinate e ricami tra i quali io scelsi mentre i clienti locali annuivano con approvazione.
Il risultato finale è letteralmente da capogiro e include dragoni colorati ricamati su seta broccata arancio acceso, circondati da variopinti ornamenti floreali. Tra le diverse stoffe ci sono passamanerie verde prato e arancioni, mentre le estremità sono bordate di rosa ciclamino e blu turchese. Nelle sezioni monocromo e a prima vista sobrie osservando con maggiore attenzione si svelano anche dettagli aggiuntivi: la parte monocromo superiore è blu satinato con dragoni ricamati, mentre la parte inferiore ha motivi floreali in rilievo. Perfino gli ornamenti marroni sulle punte e i talloni sono cuciti con filo nero.
Ogni dettaglio di per sé va oltre le tradizionali concezioni sulle combinazioni di colori, ma presi nell’insieme in qualche modo riescono a creare qualcosa di assolutamente fantastico, quasi psichedelico. “Gli stivali sono assolutamente importabili, a parte questo vanno bene con tutto”, constatò giustamente una mia amica quando li vide a Sofia. E ad oggi io non li ho mai messi, non solo per la mancanza di un’occasione adeguata in cui indossarli, ma anche perché mi stanno grandi. Una nota alquanto deludente, tenendo conto che quelle sono le uniche scarpe che possiedo fatte su ordinazione appositamente per il mio piede.
Quello che non sapevo quando scelsi come dovevano apparire era che il colore e i motivi degli stivali dipendono dalla professione e dalla condizione sociale del rispettivo proprietario. Mentre la parte superiore di solito è di seta nera o blu, la parte inferiore ne svela il rango nella gerarchia: il colore giallo è riservato a Sua Altezza il re del Bhutan e alla più alta carica religiosa, l’arancione per i ministri, il rosso per gli ufficiali con il titolo di cavaliere e i giudici, mentre il verde è per i cittadini comuni.
Oltre che per la sua complicata e anacronistica struttura politica, nel mondo il Bhutan è celebre anche per l’impegno che lo stato mette nella crescita non soltanto del prodotto interno lordo (PIL), ma anche della felicità interna lorda (FIL). La seconda non è una sorta di astratta idea buddista, bensì un principio guida che determina una serie di concrete misure governative le quali lavorano per il benessere del popolo bhutanese oltre gli indicatori
strettamente economici. Iniziata dal monarca precedente, questa politica continua a essere applicata anche oggi da suo figlio nonché erede al trono, l’attuale re del Bhutan. Dopo la sua incoronazione nel 2008 il ventottenne sovrano bhutanese Jigme Khesar Namgyel Wangchuck diventò il più giovane capo di stato al mondo (e lo rimase fino al 2011 quando Kim Jong-un salì a capo della Corea del Nord). Alla cerimonia di incoronazione l’erede al trono, ovviamente, indossava i tradizionali stivali bhutanesi. Quella volta però non erano stati realizzati da un calzolaio locale, bensì dalla lussuosa firma italiana Salvatore Ferragamo, la cui nascita risale agli anni Venti del secolo scorso, quando lo stesso Salvatore Ferragamo era un amato stilista di calzature delle stelle di Hollywood. In quanto tale nel 1938 Ferragamo produsse quello che forse è il suo più famoso modello di scarpe, chiamate Rainbow – sandali dorati con un’alta zeppa dai colori dell’arcobaleno non meno psichedelici degli stivali – proprio per Judy Garland, che in quel periodo stava girando Il mago di Oz. (E il collegamento con la canzone Over the Rainbow, scritta appositamente per il film, non è affatto casuale.) Nel film però l’eroina interpretata dalla Garland, Dorothy, non indossa i sandali in questione, ma un paio di scarpette rosso rubino con le paillettes (3). Alla fine batte i tacchi uno contro l’altro e ripete la formula magica “Nessun posto è come casa propria” tre volte, per lasciare il Paese di Oz e tornare a casa. Anche se io tornai a Sofia in modo alquanto più prosaico – con una serie di voli aerei – dopo il mio rientro dal Bhutan ebbi a lungo la sensazione di essere stata in un luogo tanto magico quanto lo stesso Paese di Oz. Ma nella mia valigia, invece delle scarpette rosse della Malvagia strega dell’Est, portavo i variopinti stivali bhutanesi – con la stessa provenienza.
1.
Secondo la cosmopolita Sultana Račo Petrova, che giunse a Sofia da Tulcea nel 1885, “non c’erano strade, solo enormi buche e molta polvere che si trasformava in fango quando pioveva e rendeva qualsiasi movimento impossibile”. Nel giro di alcuni decenni però, grazie ad architetti austroungarici, francesi e bulgari formatisi in Europa occidentale, Sofia passò “dal tipico paesino orientale a una città con l’ambizione di avere un aspetto di dimensioni europee”. (NdA)
2.
Anni fa, frugando in un negozio di antiquariato del leggermente sperduto stato americano dell’Iowa, con mia enorme sorpresa mi imbattei in una grafica incorniciata con l’immagine di Aleksandăr Nevski. A Sofia sarei passata oltre la grafica in quanto kitsch turistico del tutto privo di interesse, ma a una distanza di 9000 km, in modo completamente inaspettato, mi colpì a tal punto da trattenermi a fatica dal comprarmela. Il mondo è davvero grande, ma per fortuna casa nostra è in agguato dappertutto. (NdA)
3.
È curioso che nel libro Il mago di Oz le scarpe ereditate da Dorothy dalla Strega dell’Est in realtà siano argentate, e non nere. Nel film Il mago di Oz invece il loro colore venne cambiato in rosso rubino allo scopo di sfruttare in modo efficace l’allora nuova tecnologia di colorazione Technicolor. Le svariate paia di scarpe rosse prodotte appositamente per il film acquisirono un’iconicità tale da diventare uno degli oggetti da collezione di maggior valore. (NdA)