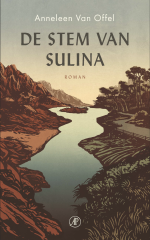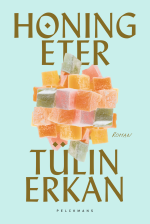Tornato, fu un’immersione totale fin dal primo giorno. Senza preavviso l’acqua mi tirò verso il basso a tutta velocità. La paura percorse il mio corpo, mentre sprofondavo il freddo era straziante. Pochi secondi dopo toccai il fondo dello stagno. Lentamente sentii il mio corpo placarsi e osai aprire gli occhi. Intorno a me solo acqua torbida, foschia verde-marrone. Rigirandomi su me stesso, in lontananza vidi comparire una luce fioca. Sguazzai nella sua direzione fino a raggiungere un passaggio seminascosto. Senza riflettere spinsi il mio corpo nella cavità. Al di là del tunnel mi aspettava un posto nuovo, migliore, o almeno così speravo. Tutto ciò che avevo per la traversata era un’ultima e disperata boccata di ossigeno prima di fiondarmi nell’acqua.
L’anno scolastico iniziò qualche giorno dopo il trasloco. Di colpo venni travolto da un’ondata di nuove usanze. Classi di soli maschi. Alzarsi all’inizio di ogni lezione quando entrava l’insegnante, insieme fare il segno della croce, accompagnato a volte anche da tre padre nostro al giorno. Parole serissime e minacciose come interrogazione e verifica. Per pranzo bere latte e cacao tiepido in un refettorio scuro con le altissime vetrate a piombo che incombevano su di me. Se lo immagino ora, il tunnel è un corridoio poco illuminato. Dalle nicchie nei muri statue di santi mi scrutano con sguardo offuscato mentre preti mi fissano contrariati da fotografie ingiallite e incorniciate. Su piastrelle grigio chiaro e rosso vinaccia risuonano freddi i miei passi mentre una nube di vapore e fecola esce dalla cucina della mensa scolastica. In alto, vicino al soffitto, le piccole finestre sono ricoperte di condensa, fuori nient’altro che un cielo grigio opprimente. In classe alzai cauto la mano per rispondere a una domanda, per la prima volta sicuro di me. Purtroppo, tradussi in neerlandese e il professore mi prese in giro per la mia risposta involontariamente ambigua. A lezione di inglese non mi era concesso utilizzare parole che gli altri non avevano ancora imparato. Parole care, come soft-spoken, to throb, to stifle o a burst, che tacevo e bandivo. Quando discutevamo in cortile, percepivo un tranello pronto a scattare ogni volta che qualcuno raccontava qualche aneddoto di una serie TV. Guardavo le facce degli altri e ridevo quando lo facevano loro, annuendo ogni tanto mentre mi sentivo girare la testa. Una volta tornati, la leggerezza greca era evaporata dai miei genitori. Come se fossero rientrati nel raggio di chissà quale fonte di influenza oscura e si trovassero a subire impotenti il suo effetto. Le sere calde e spensierate sulla terrazza, in cui chiacchieravamo tranquilli o leggevamo un libro, erano acqua passata. Mio padre era praticamente sempre in viaggio e quando tornava a casa si concentrava su mia madre, i cui sbalzi d’umore erano ancora più forti.
A casa stavo tranquillo, guardavo la tv e facevo di tutto per non causare problemi: tenevo la camera il più in ordine possibile, cercavo di stare al passo a scuola, mi muovevo da una stanza all’altra senza fare rumore. Non opponevo resistenza a quella nuova situazione, non ne avevo il coraggio né l’immaginazione. Avrei superato anche quel periodo, senza speranze né indizi su cosa sarebbe venuto dopo. Incerto su quali organi, nel frattempo, avrebbero risentito della mancanza di ossigeno, quali strati della mia anima avrebbero potuto atrofizzarsi.
Cercavo di manovrare il mio corpo in modi che fossero accettabili per i miei genitori e compagni di classe. Non dire né fare niente di controverso, non mostrare nulla del tumulto che imperversava dentro di me. Intanto la mia testa vaneggiava con una precisione sempre maggiore. Per giorni mi cimentavo con furia maniacale a calcolare quadrati sempre più grandi e ad assorbire e poi snocciolare tutte le capitali del mondo.
Ci furono amicizie fugaci con ragazzi con cui avevo poco da spartire e legami sbilanciati con altri in cui riconoscevo qualcosa di vago, appena tangibile. A volte mi si avvicinava un insegnante entusiasta o un allenatore di calcio di buon cuore. Mi prendevano da parte e mi bisbigliavano qualche incoraggiamento, parole come preziose bolle di ossigeno.
Per un istante percepivo colui che forse si nascondeva dentro di me: qualcuno che udiva il cuore pulsante di un testo latino vecchio di duemila anni e lo sapeva declamare, prima con voce sommessa, poi piano piano con convinzione. Un difensore tagliente nonostante il mio corpo fragile e mingherlino. Di tanto in tanto vi gorgogliavano residui di greco che tornavano a galla come sbuffi di vapore di un antico geyser quiescente. Stralci di discorsi, cori da stadio per insultare l’acerrimo rivale della vicina città portuale, jingle pubblicitari insignificanti per croissant ripieni al cioccolato. Sgorgavano e risprofondavano all’improvviso. Per un attimo mi sembrava di riconoscere l’odore dell’asfalto indolente, semisciolto o di sentire in bocca il sapore della pita dorata, ripiena di souvlaki speziato e tzatziki.
A volte immaginavo di essere di nuovo accanto a un maestoso pino marittimo sul cui tronco scendeva strisciando una schiera di bruchi. Cercavo un bastone e mi inginocchiavo vicino all’albero. Aspettavo che il corteo mi raggiungesse e osservavo affascinato i prodi passanti, le loro setole vibranti e l’andatura solidale. Quando la parata giungeva circa a metà, piazzavo con cautela la punta del bastone vicino alla fila e davo, con tutta la delicatezza di cui ero capace, un colpetto di lato a uno dei bruchi. Per un istante quello pareva disorientato, schiacciato tra il vuoto davanti a lui e la pressione dei bruchi che venivano dopo. Ma gli bastava un secondo per riprendersi. Prendeva coraggio, sceglieva senza esitare una nuova direzione e proseguiva indisturbato. In un baleno era diventato un leader. Gli altri lo seguivano ciecamente, come avevo fatto io con i miei genitori. A casa c’erano distanza e disagio. Le domande riguardavano solo i miei voti e l’ordine nella mia stanza. Ogni tanto veniva proposta una nuova attività, oppure oggetti che avrei potuto collezionare per superare le prossime vacanze estive. Monete, sottobicchieri, cartoline, ci sono sempre nuove cose da racimolare, più che sufficienti per colmare un vuoto.
Quando ero nei pressi di mia madre venivo travolto dalla tristezza e dal senso di colpa. Inconsapevolmente ma con maestria lei li risvegliava con la sua fame, il suo silenzio e la sua trasparenza. Antiche maree in grado di trascinarmi via tutt’oggi. Di giorno la ritrovavo immobile e pensosa. Taceva, ma la sentivo covare. Minacciosamente ferma come un sottomarino, spiava sotto la superficie di acque nemiche. Di sera il salotto rimbombava di recriminazioni con la lingua impastata. Fuggivo di sopra, mi cambiavo alla svelta e mi mettevo a letto.
Se giacevo immobile nel mio letto a pancia in su e aspettavo abbastanza a lungo, ecco che succedeva: una lacrima spuntava circospetta all’angolo dell’occhio. Si ingrossava silenziosa, usciva dall’argine e scorreva lungo lo zigomo e la guancia fino al collo. Sentivo la sua scia fredda e sottile, mentre la lacrima si asciugava lasciando dietro di sé solo tracce di sale. Sottili linee di cristalli mi rimanevano attaccate al viso e mi tiravano la pelle, leggere come una piuma. Rimanevo lì disteso e poco alla volta iniziavo a muovere zigomi e mascella. Se lo facevo abbastanza lentamente, sentivo le crosticine di sale che si crepavano. Mollavano la loro debole presa e la tensione sulla mia pelle svaniva. Con la punta delle dita spazzavo via gli ultimi rimasugli. I miei occhi erano ormai asciutti e lucidi. Li chiudevo e sprofondavo in un sonno di piombo.
Ero tornato da due anni quando uno del mio anno si impiccò, un mese prima del suo sedicesimo compleanno. Nel trimestre precedente ci eravamo seduti vicini in mensa ogni giorno. Parlava senza sosta delle sue avventure con gli scout e di korfball. Io ridevo educatamente, chiedendo ogni tanto com’era andata la festa che aveva organizzato nel weekend. Con mio grande dispiacere non trovavo mai niente da poter raccontare io.
A lungo andare mi limitavo ad annuire, ripercorrendo le declinazioni latine nella mia testa mentre lui continuava a raccontare gesticolando e con dovizia di particolari. Verso la fine del semestre iniziai a ignorarlo, sperando che avrebbe sommerso chi sedeva all’altro lato con le sue storie di ragazze e bevute, motivo per cui nelle prime settimane dopo la sua morte mi sentii molto in colpa. Al funerale, dal coro della chiesa, vedevo dall’alto centinaia di persone. Mi stupì che qualcuno che poteva essere tanto amato potesse al contempo sentirsi così solo. C’erano decine di ragazze e mi vergognai della leggera gelosia che provavo. Mi immaginai come sarebbe stato invece il mio, di funerale. Quel pensiero aggiunse uno strato di dolore pungente alla massa informe di malinconia che regnava a scuola da settimane.
Questo luogo era dunque la mia nuova casa. Un paese dove non sembravano vivere ragazze. In cui un ragazzo bello quanto fragile provava un dolore senza fondo e i miei genitori al massimo annacquavano la loro stessa disperazione in birre da mezzo e bottiglie di vino.
Quell’epoca sarebbe durata effettivamente sei anni, anche se ormai avevo dimenticato da un pezzo quella regola che avevo inventato. Era finita con una premessa cauta, immersa nell’incredulità. In una gloriosa sera d’estate venni improvvisamente circondato da ragazze che, per ragioni che mi erano del tutto sconosciute, mostravano sincero interesse. Con la coda dell’occhio vidi scintillare schegge di vetro tra i ciottoli della piazza. Come se, arrivato alla fine di quel tunnel subacqueo, vedessi all’improvviso uno scintillio d’oro e d’argento in superficie. Con le ultime forze che mi erano rimaste in corpo riemersi dalla cavità, spingendomi coi piedi sul fondo dello stagno. Risalii e ruppi la membrana. Strizzando gli occhi, inspirai più a fondo che potevo.
Quella sera, le ultime amiche salutarono e attraversarono la piazza per tornare a casa. Rimasi lì a guardarle. Una coda di cavallo dondolava allegra, le braccia si agitavano euforiche, la loro risata rimbalzò sui muri dei bar giungendo esattamente fino a me. La brezza serale mi accarezzava le guance e le braccia e sentii come un dolce tepore invadere ogni fibra del mio corpo. Ero sopravvissuto ai miei anni di piombo. Non avevo conosciuto una sofferenza immensa, era stato un dolore graduale e duraturo. Mi veniva somministrato in piccole quantità e avevo finito per abituarmici. Durante i primi mesi continuavo a cercare trappole. A volte mi convincevo che fossero stati scambiati il giorno e la notte, che da un momento all’altro mi sarei risvegliato nel vecchio mondo desolato. A poco a poco osai confidare di nuovo nel fatto che ora le cose erano cambiate. Tessuto amorfo e paralizzato che veniva irrorato per la prima volta dopo anni. Parti di me che sembravano necrotizzate ricominciavano a respirare, anche se non conoscerò mai i danni provocati dalla carenza di ossigeno. Come si pesano le serate amare, le estati vuote? Che ombra gettano l’assenza e l’impossibile? Il primo sguardo scambiato con una ragazza. Mani e labbra tremanti durante un’uscita notturna segreta. A casa di tanto in tanto uno sguardo dolce, comprensivo, qualche goccia di saggezza. Tutto quello che venne poi attenuò la sofferenza o scavò solo più a fondo? Cosa si fa coi buchi nell’anima? Un ritardo impossibile da recuperare. A partire da allora quella divenne la mia regola d’oro: arriverò sempre tardi, leggerò ogni situazione sempre con immenso ritardo rispetto agli altri.
Alcuni mesi dopo, esattamente in quella piazza dalle schegge scintillanti, avrei visto per la prima volta la ragazza riccia. Fu a partire da quell’istante che ci credetti davvero: il mio esilio era finito, ero libero.
View Colofon
Original text
"Corridor (Peninsula)" written in Dutch by
Lieven Stoefs,
Other translations
- "Coridor (Peninsula)" translated to Romanian by Andreea Bălteanu,
- "Koridor (Peninsula)" translated to Czech by Klára Němcová,
- "El Corredor (Península)" translated to Spanish by Pablo Martín Sánchez,
- "Коридор (Poluostrvo)" translated to Serbian by Tamara Britka,
- "Koridor (Peninsula)" translated to Slovenian by Lucija Janc Novak,
- "Korytarz (Peninsula)" translated to Polish by Anna Opara,
- "Коридор (Півострів)" translated to Ukranian by Olga Bondarenko,
- "Коридор (Peninsula)" translated to Bulgarian by Elissaveta Manolova Maciel,
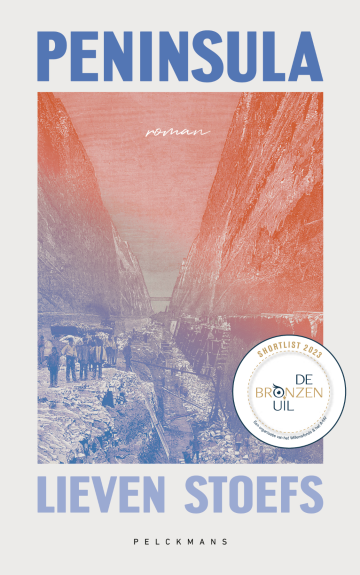
Corridoio (Peninsula)
Translated from
Dutch
to
Italian
by
Matilde Soliani
Written in Dutch by
Lieven Stoefs
This text has been made possible thanks to the collaborative efforts of the CELA network. Are you interested in reading more translated chapters of this writer? Please reach out to us!
More by
Matilde Soliani
You might also like
Nemmeno un minuto Portasar
Translated from
Romanian
to
Italian
by Maria Alampi
Written in Romanian by Cătălin Pavel
9 minutes read
Un ronzio
Translated from
Romanian
to
Italian
by Andreaa David
Written in Romanian by Lavinia Braniște
9 minutes read

Il ritratto
Translated from
Dutch
to
Italian
by Francesco Panzeri
Written in Dutch by Hannah Roels
6 minutes read