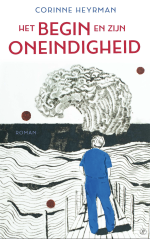I suppose, I said, it is one definition of love, the belief in something that only the two of you can see.
– Rachel Cusk, Outline
Per l’ennesima volta mi impedisce di tirare fuori dallo zaino la mappa dell’i sola.
– Così sembriamo proprio delle turiste, – mi dice.
– Ma è quello che siamo, no? – domando io.
Lei non risponde, ma aggrottando le sopracciglia guarda lo schermo del te lefono. Qualcuno le ha suggerito un’app con cui scaricare le mappe di un’a rea specifica, per poterle usare anche offline. Stando dietro alla freccia verde
sul display, che cambia posizione se siamo fermi e che si blocca quando camminiamo, per il settimo giorno di fila vaghiamo in uno dei sobborghi di Cala D’Or. Lei cambia direzione sempre più decisa, ma Funroute ’69, questa pista da go-kart ricoperta di muschio e mezzo nascosta dalle palme, poco fa l’abbiamo superata per la quarta volta. La pelle inizia a bruciarmi sulle spalle ed è già da un po’ che una invisibile palla demolitrice mi picchia inopportunamente contro la tempia sinistra, come avviene ogni giorno in torno a quest’ora. Lo interpreto sempre più come un monito a lasciare quest’isola il prima possibile.
– Ehi, vieni un po’ qui vicino a me, perché te ne stai lì dietro tutto il tempo?
Faccio due grandi passi e andiamo di nuovo di pari passo. Ho subito paura che al prossimo cambio di rotta inaspettato andrò a sbatterle contro. – Come faccio a sapere dove stai andando? – dico scontrosa. Lei accelera il passo e io farfuglio delle scuse, come se lo scontro che temevo avesse appena avuto luogo.
I supermarket qui non si chiamano supermercado, ma semplicemente su permarket. Sulle insegne campeggiano foto sbiadite di fagioli in salsa di po modoro, formaggi francesi e birra. Complessi residenziali e alberghi a più piani determinano già da sette giorni il nostro panorama. I balconi sem brano canili pieni di orche, delfini e coccodrilli gonfiabili, in paziente attesa che qualcuno se li riporti in spiaggia o in piscina. Noi stoniamo con le nostre Nike e le nostre camicette abbondanti, i nostri capelli raccolti in uno chignon arruffato. Le ragazze qui hanno uno stile più rileccato. Vanno in spiaggia col rossetto sulle labbra e grossi anelli dorati alle orecchie. Di sera portano vestitini a fascia che nascondono il sedere quanto basta a non mettere in imbarazzo i loro padri. Anche io ho portato dei vestitini, ma non li metto. Preferisco fare fronte unico con lei. Così è più divertente, continuo a dirmi. In realtà penso che: è necessario. Ridurre il più possibile la differenza fra me e lei significa enfatizzare il contrasto fra noi due e tutti gli altri presenti sull’isola. Traiamo piacere da un nemico comune, e ridac chiando indichiamo a turno tatuaggi floreali o con faccine di neonato, sca pole e polpacci ustionati, enormi custodie per cellulari di Hello Kitty, infradito decorate con gli strass. Finché possiamo definire ciò che non siamo, nessuna di noi dovrà curarsi del contrario.
Da quando l’ho conosciuta tre anni fa, l’ho vista indossare un vestito una sola volta. Se ne stava nel camerino di V&D con le spalle sollevate come un bimbetto offeso. Armeggiava con l’orlo di pizzo, la zip non si chiudeva fino in cima. Io provavo ad aiutarla ma non voleva saperne di star ferma.
– Può bastare, – disse lei quando provai ad analizzare per bene la si tuazione della zip. – Ne ho avuto abbastanza.
Tirò maldestramente la stoffa di seta dalle spalle, in qualche punto si strappò una cucitura. Il vestitino nero finì sul pavimento come uno strofi naccio buttato via. Lei rimase lì, nel suo reggiseno logoro. E io lì accanto, con il cappotto ancora addosso.
Sull’isola mi sento sempre di più come il vestito che indossa ma che vuole togliersi. Ogni sera ci rigiriamo nel letto fino a che non abbiamo trovato entrambe una posizione che sia tanto confortevole quanto accettabile. Lontane abbastanza da non sembrare troppo intime, abbastanza vicine per continuare a fare le innamorate. Provai a toccarla una sola volta, senza tro vare neanche un po’ di tenerezza. Stava lì come un palo dell’alta tensione. La sua intransigenza mi incitava, perciò accarezzavo, sfregavo, palpavo, e lei lasciava fare ma non cambiava niente. Solo quando andai più giù con la mano, le dita sparirono dietro l’orlo delle sue mutandine, noncuranti, bru sche, fino ad aprire un lembo di pelle, mi chiese di smettere.
Una volta ci rannicchiavamo così vicine che ogni cosa si intrecciava, fino all’ultimo capello delle nostre code di cavallo. Combaciamo alla perfe zione, ci dicevamo, combaciamo così bene. Fino a che non si combacia solo in parte, e poi si combacia male, per poi non combaciare per niente.
Durante il pranzo si rifiuta di nuovo di ordinare, se non in spagnolo. È una questione di rispetto, dice, rispetto per i locals, ma se mi guardo intorno non ho la più pallida idea di cosa possa significare local in questo posto, né chi potrebbe mai apprezzare il suo gesto. Inoltre pare che la cameriera di Churchill’s Tapasbar sia banalmente di Helmond, pare si chiami Eva ma soprattutto che non abbia la minima intenzione di rispondere a quella fati caccia in spagnolo in una lingua che non sia l’olandese. Dopo la seconda volta sospende i tentativi. Si accascia tristemente sullo schienale e continua a fissare la barista, che mentre cammina fa ondeggiare i capelli biondo pla tino dietro le spalle strette.
– Stronza del cazzo, – dico a bassa voce.
Le viene un pochino da ridere ma prova a resistere, si guarda im bronciata le mani sulle cosce, come un bambino testardo. – Madonna che stronza del cazzo.
Lo ripeto più forte, pongo fine in grande stile alla mia indignazione e dal tavolo accanto al nostro vedo due facce ustionate che guardano scan dalizzate verso di noi. Quando Eva di Helmond ritorna, le dico di portarci due mojito por favor, e poi una bottiglia di vino. Faccio più domande che posso. Lei parla allegra, gesticolando un sacco, per dessert ordiniamo tira misù e gelato.
Prima di andare a pagare la tiro verso di me. Mi bacia in modo un po’ impacciato e i nostri incisivi vanno a sbattere gli uni sugli altri, lei si piega in due dalle risate. Lasciamo venti euro di mancia per Eva e uscite dal locale strilliamo un gracias, tornando a casa facciamo tutto il tragitto mano nella mano. Solo quando arriviamo all’hotel, dove alcuni ragazzi sono fermi a fumare contro la facciata, mi stacco da lei. Cammina su per le scale davanti a me, le sue gambe snelle, abbronzate spuntano da sotto gli short. Ho voglia di morderle i polpacci.
Nella hall dell’hotel una ragazza si è addormentata su un cellulare messo in carica. Due ragazzini di una decina d’anni giocano svogliati a ping pong. Una donna sospira ciabattando verso le scale, il suo sarong di un giallo acceso è annodato così stretto attorno ai fianchi che il grasso trabocca da ogni parte. I giorni si incollano uno all’altro, pigri e interminabili, chi ha ancora voglia di distinguerli controlla la lavagna con il programma serale. Ieri party latino, stasera karaoke, domani serata poker.
Nella baia stiamo per l’ultima volta in acqua fino all’ombelico. Sulla super ficie del mare risplende un bagliore madreperlaceo di crema solare. Lei non si azzarda ad andare più in là di così. Andando avanti l’acqua è meno lim pida, e di colpo anche più profonda. Ha paura dei pesciolini, sussulta per le alghe nella piega del ginocchio. Le ho cinto la vita fra le braccia, la stringo a me fino a quando non inizia a rilassarsi. Più in là un gruppo di cinque maschi ustionati hanno spinto in acqua una zattera galleggiante su cui si trovano in due scompartimenti un frigorifero e un impianto stereo. Urlano euforici, e io me li immagino mentre rimangono fulminati in preda alla gioia. Dagli angoli della sua bocca che si incurvano furtivi capisco che anche lei immagina uno scenario simile.
Stiamo in silenzio e contempliamo il mare aperto. Delle persone nuotano in lontananza. così lontane da essere più vicine alle barche che si spostano lente fuori dalla baia che a noi. Il primo giorno ho nuotato an ch’io fino a lì. Mi sentivo libera e lucida mentre a grandi bracciate mi lasciavo indietro la baia, ma una volta in mare aperto quella leggerezza si tramutò all’improvviso in ansia. Nuotai a riva il più veloce che potevo e quando senza fiato arrivai ai nostri teli da bagno lei era infuriata. Mi aveva perso di vista, disse, non era più riuscita a distinguermi dall’acqua, si era preoccupata. Io le chiesi scusa e promisi che non mi sarei più allontanata così tanto. Mentre ero stesa ad asciugarmi accanto a lei pensai che en trambe abbiamo la tendenza a desiderare qualcosa che è fuori dalla nostra portata. Lei sospetta che il mare aperto contenga qualcosa di speciale, ma non si azzarda a nuotare fin lì. Io cerco incautamente il mare aperto, fino a che una paura inconscia mi ricorda di ciò che mi sono lasciata alle spalle. Così non siamo mai nello stesso posto.
Per il resto della settimana nuotai avanti e indietro esattamente al margine del suo campo visivo. Non provai più né leggerezza né ansia.
Durante la nostra ultima notte sull’isola sogno suo padre che mi telefona e dice che lei ha avuto un incidente tornando a casa. La sua auto si era scon trata frontalmente con un veicolo che arrivava contromano. Nel mio sogno mi esplode nel petto un panico così forte che sembra frantumarmi le costole una a una. Dimentico di chiedere se lei sia ancora viva, e corro fuori di casa a piedi nudi.
Mi sveglio in preda ai crampi e mi sento estremamente soddisfatta di aver provato quel panico. A colazione racconto con orgoglio della telefo nata e della mia reazione. Quando riporto il dettaglio dei piedi nudi, mentre le mie mani si muovono irrequiete sulle uova, le viene da ridere. Per conferire al sogno un significato ancora più profondo, digito la voce “au to-incidente” su infosogno.nl, ma faccio appena in tempo a tapparmi in bocca il risultato “se sogni che la persona amata incorre in un incidente, ciò suggerisce un profondo desiderio di separarsi da questa persona”. Sollevo gli occhi dallo schermo del telefono, la guardo mentre taglia in quattro una fetta di pane e marmellata di fragole, e dico che a casa ci sono 21 gradi.
Nell’aereo siamo sedute di fianco sui due lati del corridoio. Io tengo in mano un libro senza leggerlo. Sullo schermo del poggiatesta davanti a lei vedo con la coda dell’occhio che sta cercando di tirare una palla da bowling verso una serie di birilli allineati. Continua a battere e strisciare accanita sullo schermo, ma non riesce a spostare la palla. Ci rinuncia, e inizia a sfo gliare distrattamente fra i film.
Un paio di file davanti a noi una coppia è alle prese coi malumori del loro bimbo. Dal corpicino echeggiano pianti e singhiozzi. Il suono stra volge l’atmosfera di tutto l’aereo, per quanto non sia chiaro se i passeggeri approvino lo stato d’animo del bimbo o se invece sia lui a dare voce alla stanchezza e la noia imperanti. Sappiamo tutti che dopo l’atterraggio non è ancora finita, che all’aeroporto dovremo prima aspettare i bagagli, guidare verso casa, appena arrivati dovremo liberare lo zerbino dalla posta, e che per il resto troveremo tutto esattamente come lo avevamo lasciato.
La gente inizia ben presto a stufarsi di quel pianto, anche lei. Il padre si alza, si getta il figlio in spalla e imbarazzato comincia a camminare su e giù. Lei sospira le prime due volte che l’uomo le passa accanto, ma in pochi istanti è rapita dal film e si dimentica di lui. Ho sempre pensato fosse più bella che mai quando si concentrava, ma più stavamo insieme e più la tro vavo bella quando si concentrava su qualcosa che non ero io.
Fuori scende la notte. Gli ultimi raggi di sole si ritirano dietro l’oriz zonte. Di tanto in tanto lei alza lo sguardo e ci scambiamo un sorriso. Il mio braccio è abbastanza lungo per oltrepassare lo stretto corridoio, e anche il suo, ma nessuna di noi due si muove.