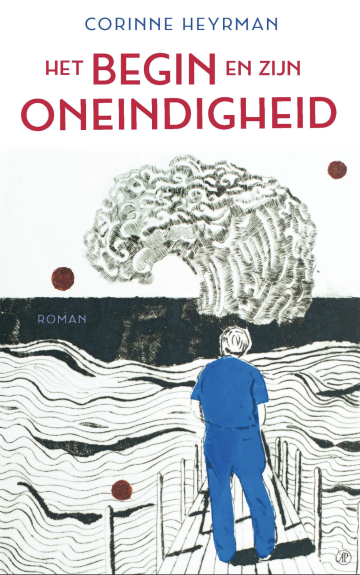Le liste danno una sicurezza di tipo pericoloso, una sicurezza apparente. Attorno ai diciassette anni finii in ospedale per un eccesso di liste, di calcoli, di controllo. D’improvviso il mio corpo prese forme femminili e il mio peso si lanciò al trotto, probabilmente con l’idea di distribuirsi successivamente su tutta la mia altezza, ma a quel tempo questo non lo sapevo ancora e quindi andai nel panico. Il cambiamento fu troppo brusco e mille volte troppo rapido. Nella nostra famiglia siamo cicciottelli, che ci vuoi fare, l’avevo sentito dire molte volte, ma non avrei permesso che succedesse a me. Io sarei stata in grado di prendere in mano la situazione, non accettavo quel “che ci vuoi fare” e smisi di mangiare. Avrei mostrato consapevolezza e forza di volontà.
Invece mi ritrovai in ospedale con cinque ragazze che riuscivo a definire magre, me no. Nello specchio vedevo una ragazza robusta che mi ricordava una balena, anche quando la bilancia segnava meno di quaranta chili. Da quei numeri e soprattutto dal volto pallido di mia madre capivo che dovevo essere magra, ma quando mi poggiavo le mani sui glutei o sulla pancia sentivo qualcosa di molto diverso, molle, strano, rotondo.
“Una sorta di psicosi” la chiamava lo psichiatra Broeckx.
Le cinque ragazze magre e io formavamo una comunità e vivevamo insieme in ospedale. C’erano altri gruppi, composti da ragazzi e anche da ragazze di altre proporzioni, ma non ci entravamo in contatto quasi mai. Il nostro programma prevedeva che i genitori partecipassero il più possibile alle terapie, così da non rendere la distanza troppo grande quando avremmo potuto tornare a casa alla nostra vita, dicevano, come se lì in ospedale ce la fossimo sfilata come una giacca per un po’, per poi rindossarla più avanti. Come se le nostre vite per un po’ non fossero esistite. In quel periodo i dottori ci suggerivano di non andare a far compere, di non farci foto o video, perché in quel momento non eravamo una buona versione di noi stesse. Noi, sei ragazze difettose, non andavamo a scuola, non ci dedicavamo ai nostri passatempi o agli amici. Eravamo in pausa, ci trovavamo in una terra di mezzo.
Ci fu un esercizio in ospedale per il quale io e le cinque ragazze magre ricevemmo una corda per fare un cerchio grande quanto pensavamo che fosse la circonferenza del nostro girovita e poi metterlo sul pavimento. Dopo dovevamo metterci nel cerchio per verificare se la nostra percezione fosse corretta. Con totale concentrazione sedevamo per terra, guardavamo dalla nostra pancia alla corda e viceversa. Per via della nostra malattia facevamo tutto in maniera molto accurata e meticolosa, e così eseguimmo anche questo compito con completa dedizione. I nostri genitori ci guardavano, da un lato.
C’era Mia, che provò a tendere la corda attorno al suo corpo per poi poggiarla per terra nella stessa forma. La sua famiglia era ricca, suo padre era avvocato e ad ogni seduta diventava sempre più impaziente, e continuava a dire che secondo lui il processo di riabilitazione avrebbe potuto essere più efficiente. Sua madre, direttrice di questo o quell’altro ente finanziario, all’inizio del ricovero le aveva regalato un cavallo, che se ne stava solitario sul prato a pascolare dietro alla loro villa, e che Mia quindi non aveva ancora mai visto. Di tanto in tanto riceveva un messaggino con una foto dell’animale, che ogni volta sembrava sempre più sconsolato. “Beauty chiede quando torni a casa” recitava generalmente il testo.
C’era Kim, che si era distesa con grande attenzione sul pavimento. In piedi accanto a lei si trovava suo padre, alto e dinoccolato, e la madre, pallida, entrambi sempre vestiti come se fossero in partenza per un’escursione in montagna. Durante le sedute si mettevano sempre in disparte e si scusavano continuamente, anche a sproposito. Ad esempio quando parlammo del weekend che Kim aveva passato a casa per “riambientarsi”. Kim aveva urlato scontrosa che suo padre aveva passato l’intero fine settimana sul divano a mangiare biscotti. I due tipi dal colorito beige erano indietreggiati, il padre aveva borbottato delle scuse, e allora una madre gli aveva chiesto se fosse vero che aveva mangiato biscotti per tutto il weekend.
“Quanti di preciso, un pacco, due?”
“Se l’ha fatto per tutto il weekend saranno stati almeno due pacchi”, aveva bofonchiato la madre di Kim.
Un altro genitore aveva convenuto che effettivamente erano tanti. Mia madre aveva osservato che qualche volta mangiava biscotti anche lei, e che non era una cosa poi tanto anormale. A quel punto il padre aveva detto che sua moglie esagerava, e che ne aveva mangiato solo un pacco. Insomma, alla fine avevamo passato la maggior parte della seduta a parlare del comportamento alimentare del padre di Kim.
“Non molto efficiente”, aveva osservato quello di Mia.
C’era Fiona, che aveva finito subito il suo cerchio. I suoi genitori avevano un’abbronzatura da lettino, il padre con i capelli ossigenati sulle punte, come se fosse uscito direttamente da un videoclip degli anni Novanta, e la madre con le extension nere lunghe fino al sedere. Malgrado la loro grande attenzione per l’aspetto esteriore, la stanchezza dei loro visi era comunque sempre la prima cosa che saltava all’occhio.
La madre di Zoe non riusciva a trattenersi dall’assisterla. “La circonferenza deve essere più piccola, ancora più piccola”, le urlava dal bordocampo come un’allenatrice. Faceva la psicologa e sembrava vergognarsene, durante il giro di presentazione aveva detto singhiozzando che il suo lavoro era aiutare gli altri, ma che non era riuscita ad aiutare la propria figlia. Fra le braccia teneva l’altro figlio, di cinque anni, al quale la terapia con le corde sembrava un gioco spassoso.
“Michelle”, indicava col ditino.
“Sì”, ribatteva sua madre in tono infantile, “Quella è Michelle”.
Michelle era quella che si trovava in ospedale da più tempo. Aveva passato mesi nella cosiddetta fase della negazione, una fase nella quale non riusciva neanche a concepire di poter avere un disturbo mentale. Così inizialmente era finita in gastroenterologia e poi era rimasta in ospedale a lungo per tutte le analisi e gli esami del caso. Aveva preso in giro i medici senza neanche rendersene conto, convinta com’era che il problema dovesse essere nella pancia e non nella testa. Chiamarla fase della negazione, quindi, non era corretto, “fase della scoperta” sarebbe stato molto più appropriato. I suoi genitori erano entrambi insegnanti e scrivevano compulsivamente in un quadernetto tutto ciò che il personale sanitario diceva. Avevano altri quattro figli, fra i dieci e i vent’anni, che ogni tanto venivano insieme a loro.
E poi c’era mia madre, tutto il tempo col pollice alzato e spesso e volentieri in lacrime. Mi supportava a malincuore, come lo aveva fatto anche durante una gara di corsa a cui avevo partecipato qualche settimana prima. Mi aveva sorpreso vederla lì, di solito non veniva mai, ma quel giorno aveva persino corso assieme a me per un tratto sul lato del percorso. In seguito mi aveva raccontato che l’aveva fatto perché ero così magra che era convinta che sarei crollata.
“Stai andando bene”, esclamava anche lì in ospedale, da dietro la linea di bordocampo, con una voce che affogava nelle lacrime e nel muco.
I genitori erano tutti diversi, per aspetto, visioni e standard di vita, anche se erano tutti bianchi e di classe sociale elevata. E in effetti era un passatempo costoso, riprendersi da un male invisibile. Noi, le ragazze, impegnate con la nostra circonferenza addominale in corda, invece eravamo più difficili da distinguere, perché eravamo ombre. Ombre con lo stesso obiettivo e con gli stessi sintomi, influenzabili dalle idee le une delle altre e per questo sempre più simili l’un l’altra. Era come se poco a poco stessimo diventano una cosa sola, amalgamate in un’ossuta pallina di peluria, sei cuori che pulsavano lentamente e un eccesso di testardaggine. Una palla che avrebbe tanto voluto rimbalzare da tutte le parti, ma che per il momento non era in grado di farlo.
Una volta finito ci chiesero di metterci in piedi dentro alla nostra circonferenza addominale. Ripensandoci a posteriori, lo si potrebbe definire un momento esilarante, ma allora i nostri genitori rimasero a guardare in silenzio i giganteschi cerchi per terra, le loro figlie al loro interno come dei puntini – ci saremmo potute stare dalle tre alle sei volte.
Quando entro nella stanza di mio nonno, lui è in piedi di fronte alla finestra con le mani in tasca, attorno ai suoi polsi c’è una fasciatura sottile. Guarda gli uccelli, le statue, il parco, le personcine che camminano in gruppetti da due o tre senza mai lasciare i sentieri tortuosi. Puoi guardarli quanto ti pare, ma difficilmente si scontreranno, proprio come le auto nel parcheggio. L’intensa luce del sole si proietta su di lui come il faretto di un teatro. Troppo controluce, direbbe un fotografo. Ho letto su internet che esiste un collegamento fra l’arenamento dei cetacei e l’attività del sole. Le macchie e le eruzioni solari interferiscono con il campo magnetico terrestre che le balene, proprio come gli uccelli migratori, usano per orientarsi. Conseguenza: le balene si confondono.
“Come va, nonno?”, gli tocco una spalla con delicatezza. Ho sempre paura di spaventarlo, anche se forse non sarebbe male, potrei liberarlo da quel suo lungo sonno sconsolato.
“Solo”, risponde lui.
“Come dici?”
“Sono solo.”
Da piccola avevo il libro “Senza famiglia” – nel quale il protagonista si sente solo al mondo – mia madre l’aveva messo sullo scaffale della mia stanza perché lei da bambina ne andava pazza. Io non l’ho letto granché, solo quando attorno agli undici o dodici anni, in una fase iniziale della pubertà, tutto attorno a me mi faceva arrabbiare e avevo la sensazione di trovarmi nel bel mezzo di un caos che non riuscivo a gestire. Allora andavo di sopra, mi sedevo contro il mio enorme orso di peluche bianco e prendevo il libro. A ogni crisi interiore mi riproponevo di finirlo, perché il titolo era straordinariamente azzeccato. Ero certa che nel frattempo nessuno avrebbe sentito la mia mancanza. In realtà non andavo mai oltre la prima pagina – con l’inchiostro ormai sbiadito e le parole diventate illeggibili – perché a quel punto mia madre era già accanto a me. Probabilmente dentro di sé rideva di quella figlia che leggeva ostentatamente “Senza famiglia”, ma fuori mi consolava stringendomi in un abbraccio.
“È tutto un casino.” La mia voce era soffocata, tra l’orecchio dell’orso e l’ascella di mia madre.
“Sì”, mi tranquillizzava lei.
C’è una crepa nella vernice sul muro che sembra essersi fatta più grande. Non rispondo a mio nonno, poiché non voglio affermare falsità, dopotutto è vero: è solo. Potrei dire semi-filosoficamente che in sostanza siamo tutti soli, ma non sarebbe giusto neanche questo. Lo siamo tutti, ma lui lo è davvero, in questa camera che ricorda quella di un ostello della gioventù dove si intravede ancora l’inquilino precedente e il prossimo già si fiuta, con una finestra che, non appena inizia a fare buio, restituisce solamente il riflesso di chi guarda. Il riflesso di un uomo di settantacinque anni, un paziente psichiatrico, le mani in tasca, la camicia abbottonata male.
Al piano di sotto, anni prima, dovevo fare ogni settimana l’esercizio dello specchio. Ogni ragazza era in un angolo diverso, con addosso solamente le mutandine. Si faceva molto uso dei diminuitivi perché eravamo molto sottili e fragili e nessuno voleva rendere le cose più grandi di quanto non lo fossimo noi. Una psicologa che parlava al microfono ci incoraggiava a guardarci nella grande parete a specchio. La sua voce ci raggiungeva attraverso gli spiragli sotto alle porte: “Guardate i vostri piedi, osservate la loro forma, il loro colore, le particolarità.” Era un body scan, ma più che una meditazione, ricordava un accoltellamento. “Guardate le vostre ginocchia, soffermate su di esse la vostra attenzione, lasciate che i vostri occhi indugino lì.” Ad ogni parte del corpo una nuova fitta di dolore lancinante. Un disgusto insopportabile. “Andiamo verso le cosce, osservatele, provate a farlo in maniera neutrale.” Io non riuscivo a guardarmi, il mio corpo tremava, i miei nervi ululavano, e così chiudevo automaticamente gli occhi. Quando davvero guardavo, vedevo questo: pieghe di grasso e una pancia bianchiccia e sformata. Vedevo una sola parte del corpo. Il più delle volte sedevo con la schiena contro lo specchio, le ginocchia raccolte e le braccia strette attorno ad esse per il freddo. Nessuno controllava se eseguivi davvero l’esercizio, e quindi la maggior parte delle ragazze faceva lo stesso. Con la nuca contro lo specchio ascoltavamo la voce pacata della psicologa, chiudevamo gli occhi e aspettavamo la fine, deluse di aver fallito ancora, poi ci rialzavamo in fretta così che sembrasse che avevamo fatto tutto l’esercizio.
Allo stesso modo mio nonno, nella sua stanza di quattro metri per sei, si lascia scivolare addosso le voci dei dottori, degli altri pazienti, della sua famiglia, tiene le mani rovinate nelle tasche. Si è seduto contro lo specchio, a fare l’esercizio non ci prova più, non ce la fa più. Io non lo facevo perché pensavo che fosse la cosa migliore per me, lui perché non ha più la forza di fare qualcosa per sé. Lui non è più nessuno. Dove io vedevo solo una pancia, forse lui, nel suo riflesso allo specchio, non vede proprio più nulla.