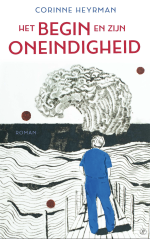Intanto che aspetto Isaac osservo degli uomini di mezz’età che litigano per un parcheggio, famiglie di sei persone che vengono stipate in taxi minuscoli e l’orecchio destro mi fischia a causa di tutte le automobili che continuano a suonare il clacson. L’area di sosta dell’aeroporto è una versione in miniatura del traffico di questo Paese, un preludio alle autostrade caotiche nelle quali la segnaletica orizzontale viene ignorata e vale la legge del più forte.
“Esiliamo i nostri sogni e li rimandiamo a domani e al futuro, ma in fondo non è doloroso?” Le parole in neerlandese sembrano fuori luogo in un parcheggio e in una città come questi. È il modo di annunciarsi di Isaac. Alla primaria ogni tanto il venerdì pomeriggio andavamo al karaoke con l’intera scuola. Ogni classe si esibiva con la canzone che aveva deciso, ma non c’era molta scelta perché la macchina per il karaoke aveva solo un numero limitato di opzioni. Al settimo anno tutte le volte sceglievamo “Wat zou je doen” (“Che cosa faresti”) di Marco Borsato e Ali B. Per Natale avevamo pensato a una coreografia e imparato a memoria l’intero testo della canzone. Ci vestimmo coordinati, con i cappellini indossati di traverso sulla testa e alla fine dell’esibizione ricevemmo un grande applauso dal resto della nostra piccola scuola.
La vecchia Mercedes bianca si ferma, il motore si spegne e Ali B viene interrotto a metà di una frase. Entrambi i finestrini della macchina sono abbassati e vedo che Isaac è leggermente piegato in avanti. La sua testa sembra quasi sfiorare il tettuccio. Non so come me lo ero immaginata. Malgrado tutte le foto che ho visto negli anni passati, l’immagine di Isaac che avevo in testa era rimasta una versione un po’ più alta del suo io quattordicenne, con tanto di baffetti appena accennati e gambe e braccia troppo lunghe.
“Sei diventato più alto”, concludo. Io sono cresciuta prima di lui e quando litigavamo vincevo perché ero più forte e non esitavo a graffiarlo fino a farlo sanguinare. Isaac iniziò a recuperare lo scarto l’anno prima che lui e papà partissero, e alla fine non ci fu più bisogno che si pettinasse i capelli all’insù per sembrare più alto di me. Al nostro quattordicesimo compleanno tracciammo per l’ultima volta i segni che indicavano la nostra statura sulla carta da parati della camera da letto. Isaac misurò la differenza con il suo goniometro e per tutto il resto della giornata festeggiò non soltanto la sua età, ma anche la sua vittoria. Era ufficialmente due centimetri più alto di me.
Mi prende la valigia, sorride. “Sapevamo entrambi che avrei vinto io.”
Dal parcheggio dell’aeroporto all’appartamento dei nostri nonni ci vogliono solo quindici minuti, mi spiega Isaac. “Magari te lo ricordi, con tutte le volte che ci siamo venuti, ma da bambini sembrava sempre che il viaggio non finisse mai, vero?”
“Sì, tipo ore.”
“Se c’è traffico, o un ingorgo, può volerci anche un’ora, ma dalla settimana scorsa le strade sono più tranquille. Tutti quelli che potevano farlo sono fuggiti dalla città e di voli per Beirut non ce ne sono quasi più.”
“È logico, sì.”
Il viaggio in auto mi ricorda una rimpatriata delle elementari, in cui in soli cinque minuti cerchi di farti raccontare da qualcuno che un tempo conoscevi la storia della sua vita, il tutto mentre mastichi una manciata di salatini.
“Allora, cosa fai adesso? Finanza?” un tempo Isaac aveva iniziato a studiare direzione aziendale, o forse economia, o contabilità. Non lo ricordo più. La parola “finanza”, per quanto insulsa, è l’opzione che più verosimilmente mi porta più vicina a una risposta giusta.
Schiocca la lingua, emettendo una sorta di “tuh”, scuote la testa. “Dollari. Le tasse universitarie diventano sempre più care, siamo arrivati a dodicimila dollari all’anno e con il cambio attuale è una follia.”
“Che cosa fai allora?”
“Qualcosa qua e là. I fratelli di un mio amico hanno un distributore di benzina e qualche taxi, lavoro lì quando hanno bisogno di me.”
“Ma riprenderai a studiare? Se torna ad essere più economico?”, “Forse. Hai mangiato in aereo?” Toglie una mano dal volante e mi indica il KFC alla nostra destra.
Tiro via un filo appeso al manico del mio zaino prendendolo fra le unghie del pollice e dell’indice. “La ragazza accanto a me mi ha dato un panino col labneh.”
“Vuoi mangiare?”
Scuoto la testa.
Dentro l’auto, isolata dal mondo esterno, se focalizzo lo sguardo sul cruscotto e mi concentro sulla musica, sedergli vicino e guardarlo mi trasmette una sensazione familiare, come se non avessimo mai smesso di trovarci in presenza l’uno dell’altro. Studio i contorni del suo volto, la gobba sul suo naso, che abbiamo ereditato entrambi da nostro padre, le ciocche ribelli sulle tempie. Il suo viso è il mio viso, ma leggermente diverso. Lui è me, ma leggermente diverso, non c’è nessuna persona sulla faccia della terra con la quale io condivida più corrispondenze genetiche che con lui. Isaac non è uno sconosciuto.
Allo stesso tempo è qualcuno che ho conosciuto in una vita passata, tutto in lui (l’altezza, la pettinatura, la gravità della voce, il modo in cui guida l’auto, il portamento) è diventato irriconoscibile in una miriade di modi diversi. Nella vita in cui ci conoscevamo era un bruco, e ora è una farfalla: ha subito un intero processo dove tutto in lui, la pelle, il cervello, le viscere e le ossa, si è dissolto in una sostanza gelatinosa, che poi ha di nuovo formato un essere umano.
Sono stati fatti degli studi su cosa le farfalle ricordino della loro vita da bruco. Durante la metamorfosi vengono trasferiti solo i ricordi di rilevanza biologica: si conservano solamente quelli che garantiscono che la farfalla sappia cosa è pericoloso e cosa sicuro. Cosa facesse ridere il bruco, cosa lo rendesse triste, quanto amasse gli altri bruchi attorno a lui, tutto questo va perso durante il processo di trasformazione.
“Se dovessi scegliere, preferiresti essere un bruco o una farfalla?” gli chiedo. Cosa ricordi ancora della vita che abbiamo condiviso?
“What the fuck?” Guarda di lato, alza il sopracciglio, poi scuote la testa. “Una farfalla, penso. No, un bruco. Posso scegliere anche qualcos’altro? Un millepiedi o qualcosa del genere? No. Una coccinella arancione. Ecco, sceglierei quello.”
A parte i vetri rotti, nell’appartamento non sembra essere cambiato nulla. Riconosco il divano al centro del salone dalle vecchie foto, anche se è un po’ più sbiadito e la seduta è sfondata. È come se fosse stanco di essere stato tanto a lungo nello stesso posto. Mi chiedo quanto sia profonda l’impronta dei piedini sul tappeto. Sarà ancora possibile recuperarlo con una bella ripulita, o si sarà già del tutto appiattito? Di recente ho visto una serie di video di una ditta che ripara peluche. Quando il tessuto del pupazzo, di solito un orsetto o un gatto, è ormai del tutto consumato dalle notti di pianto e dalle sbavate, estraggono tutta l’imbottitura. Poi tagliano gli occhi di perline con un coltellino e mettono l’involucro vuoto in ammollo in acqua e sapone. Alla fine dei video i pupazzi sembrano sempre fin troppo nuovi, e fin troppo puliti. Non penso che abbracciarli sia così bello come prima.
Gli ultimi intensi raggi di sole del giorno rimbalzano sui frammenti di vetro e vengono riflessi sul muro in mille schegge di luce. Solamente il percorso fra la porta e il divano e il divano stesso sono stati ripuliti dal vetro. Il divano è coperto da cuscini decorativi con frange dorate, al centro c’è una coperta leggera con il disegno di un pappagallo.
“Dormi lì?” chiedo.
Isaac poggia un piede dopo l’altro con attenzione, come un funambolo, le braccia tese per mantenere l’equilibrio: un paio di centimetri a destra o a sinistra e metterà il piede sui frammenti di vetro. Il percorso ha la larghezza di una scopa e riesco a immaginarlo mentre libera il tragitto spingendola dritta davanti a sé, per poi si lasciarsi cadere sul divano, ritenendo la questione risolta.
Isaac fa un cenno verso il fondo della stanza. La porta della camera da letto è aperta. “Di solito dormo lì. Non ho ancora avuto tempo per liberare il passaggio.”
Mentre parlava è salito in piedi sul divano e ora raccoglie la scopa, che è caduta per terra. Con un movimento sciolto me la lancia come due eroi in un film ambientato nel medioevo si lancerebbero una spada. Il manico di legno finisce sul pavimento con un tonfo sordo.
Isaac scende dal divano e si dirige di nuovo a piccoli passi verso la porta d’ingresso.
“Vado di sopra a prenderne in prestito un’altra”, dice. E scompare nel corridoio.
Spazzo le schegge di vetro in avanti come uno spazzaneve creando una scia dritta e stretta dalla porta d’ingresso alla camera da letto. La brezza che attraversa la stanza porta un odore di mare e di cassonetti traboccanti di spazzatura. Il tappeto luccica per i pezzettini di vetro microscopici rimasti impigliati fra le fibre del tessuto. Non so se riusciremmo a tirarli fuori con un’aspirapolvere: magari non c’è abbastanza corrente elettrica e il generatore si spegnerebbe dopo un minuto. Allora ci toccherebbe correre giù per le scale per riaccenderlo sperando che il resto degli inquilini nell’edificio abbia ancora la corrente.
Ricordo ancora come, quando dormivamo qui e non nel paesino dei nonni, tornavamo stanchi e scottati dopo una lunga giornata in spiaggia. Prima di salire le scale, mio padre andava all’armadietto dei contatori appeso appena fuori dal condominio e spegneva e riaccendeva un paio di volte quello di Im Younes, una vicina del piano di sopra, così che in casa sua tutte le luci sfarfallassero. “Per avvisare che siamo tornati”, diceva papà. “Come una sorta di citofono.” Spesso poi, un paio di minuti dopo, la signora Im Younes compariva alla nostra porta. Prendeva me e Isaac per mano e ci portava nel suo salotto dove ci aspettava sempre qualcosa da mangiare, mentre papà veniva schiaffeggiato sul braccio con un acchiappamosche.
Con il vetro che ho spazzato via faccio un mucchietto vicino alla camera da letto ed entro nella stanza. Le lenzuola disfatte sono appallottolate al centro del letto e uno dei guanciali è per terra.
D’estate questa stanza era sempre troppo calda. Dormivamo in quattro nel letto a due piazze, fin troppo piccolo per noi, e spesso ci svegliavamo madidi di sudore. Eppure, preferivo comunque quello al paesino: mangiavamo tutte le sere al ristorante o in piccoli chioschetti e passavamo tutti i giorni davanti al negozio di dolciumi, dove potevo prendere i leccalecca. La spiaggia era sempre vicina e neanche di sera si svuotava mai del tutto.
Di fronte al letto c’è un mobile con alcune cornici a faccia in giù. Le raccolgo una a una per guardarle e riconosco la foto del matrimonio dei miei genitori, foto delle mie zie quando erano ancora adolescenti, foto dei miei cugini e cugine da bambini, e – alla fine – una mia foto. È stata scattata a scuola, credo in terza o quarta elementare; quell’anno avevo un labbro spaccato e un’abrasione sul viso perché ero caduta di faccia sul marciapiede mentre cercavo di camminare sui trampoli nel cortile della scuola. La cornice è spaccata. È l’unica fra tutte le foto che rimetto a posto, al centro dello scaffale più in alto.
Spesso ho l’impressione che i miei nonni esistano soltanto nei momenti in cui penso a loro. Per tutto il resto del tempo, a volte per mesi, sono personaggi secondari dimenticati, pupazzi di uno spettacolo di burattini riposti da qualche parte in fondo a un baule chiuso, un baule di cui non ho la chiave. È quello che mi racconto per sentirmi meno in colpa. Se quando non penso a loro non esistono, allora non ci sono neanche momenti in cui aspettano che il telefono squilli, un messaggio con un “ehi, mi mancate”, o in cui aspettano me. Quella foto, che non so chi abbia messo qui, smentisce questa teoria, e più guardo il viso della me di otto anni, più il nodo nel mio stomaco si stringe. Capovolgo la cornice.