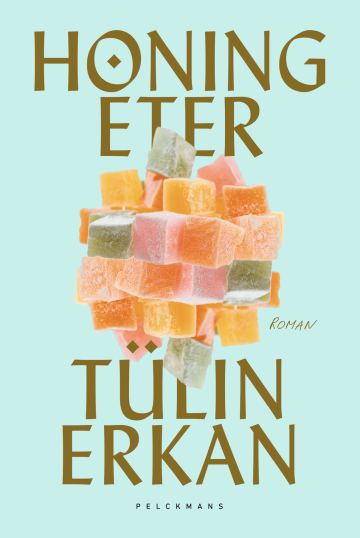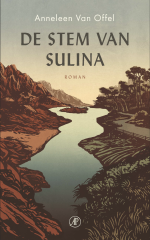• REC
C’è una donna che aspetta. Seduta, le mani intrecciate sul grembo, aspetta. Normalissimo, lo fanno tutti qui. Soggetto sospetto? Per niente. Ma resto concentrato su di lei. Forse per il modo in cui i suoi piedi si pietrificano nel suolo, come se intendesse ancorarsi a questo aeroporto per sempre. I pixel bianchi e neri del mio schermo tracciano un volto. Nel brusio si delineano due sopracciglia dritte e un viso affusolato, come quello di un uccello. Mi sporgo verso lo schermo fino ad arrivare in punta di sedia. La lente registra due occhi cristallini. Si aprono e si chiudono un po’ a fatica, un po’ come le porte scorrevoli del terminal 224. Dovrei forse segnalare un comportamento insolito? Ormai siede lì da molto tempo. Se ingrandisco ancora un po’, le sue labbra sembrano muoversi lentamente: qualcosa le rotola dall’ugola alla lingua, contro i denti, per poi finire con un tonfo tra le labbra. Potrebbe sembrare che pronunci molto lentamente, senza emettere un fiato, la parola ‘roltrap’, scale mobili.
Terminal 226
Mi chiedo se le scale mobili dimenticano i passi. Fino a che punto indovinano il numero di scarpe, il peso, la destinazione di chi sale o scende. E se lo ricordano per la volta successiva. Per cercare di capirlo, sono seduta qui da un bel po’, per l’esattezza il tempo di 572 passanti. Appunto scrupolosamente il loro numero sul mio quadernino, per tenere il conto di ciò che passa di qua. Tengo il conto di quello che passa per tutto il tempo che serve. Voglio pietrificarmi qui e ingoiare l’addio, una volta per tutte. Giro la testa a sinistra e attraverso passeggeri, luci al neon e immagini deformi riflesse negli specchi guardo la falce di luna che tra poco, quando il cielo si colorerà di tinte scure come carta assorbente, farà risplendere le cime innevate in lontananza. Un tempo vulcani attivi, ora dormienti fino al prossimo movimento delle placche tettoniche. Intanto Istanbul gorgoglia come magma.
La vita scorre lenta in un aeroporto, forse perché tutto si ripete in cerchi infiniti: le persone in viaggio, i nastri trasportatori, questa scala mobile. Per poi ricominciare ogni volta da capo. 572 passanti fa mi sono seduta di fronte a queste scale perché la loro cadenza mi tranquillizza. Il meccanismo inghiotte i gradini, li risputa e risale con un clic sordo. Risalire, vorrei saperlo fare anche io.
È iniziato tutto tanto tempo fa: persi le parole. O meglio: le ricacciavo in gola ogni volta. Qualcosa in me si rifiutava di pronunciarle. Poi mi sgorgavano nella pancia e arrivavano fino alla laringe. Lì si bloccavano e rimanevano attaccate al mio palato molle, finché non riuscivo ad emettere altro che aria. A volte erano così tante, le parole che cercavano di risalire, che finivano per formare un nodo spesso che metteva a dura prova i limiti della mia gola. Come quando provi a ingoiare un boccone
troppo grande di pane duro. Avrei voluto riuscire a vomitare quella nauseante poltiglia di parole, liberarmene e basta. Ai tempi dell’università non si notava ancora così tanto. Mi nascondevo dietro a termini scientifici in latino e nella tassonomia della veterinaria, un altro tipo di lingua, con cui potevo convincere i docenti per iscritto. Solamente quando rimanevo da sola in laboratorio con gli animali riuscivo a parlare liberamente e senza fatica. Squittivo con i topi, gracidavo con le rane e ringhiavo con i cani.
Adesso ogni tanto, in presenza di altre persone, riesco a portare una parola fin sulla punta della lingua. E spesso pizzica a tal punto che esce impaziente, prima del tempo, a scatti. Da qualche parte ho letto che è impossibile ingoiare la propria lingua, il che mi tranquillizza.
Che ironia della sorte che un tempo fossi una vera cascata di parole. Recitavo poesie con impareggiabile fervore di fronte a tutta la classe, inventavo canzoncine come se fosse la cosa più naturale del mondo, conquistavo il parco giochi gridando a squarciagola, venivo definita un vero talento per le lingue. Fino a che, non più bambina, la mia lingua materna e paterna smisero di combaciare. Tanto facile mi veniva implorare qualcuno di concedermi un gelato nel caravanserraglio di mio padre quando ero piccola, quanto difficile è ora da adulta ordinare un çay alla taverna locale. Le due lingue semplicemente non corrispondevano più. L’alfabeto turco del resto ha 29 lettere. Quello olandese 26. Ce ne sono tre di troppo o tre in meno. Tre lettere. Tanto bastò per mettermi a tacere.
• REC
Sullo schermo in alto a sinistra ho un’immagine più chiara della sua postura e della sua espressione. La telecamera è in un angolo dell’aeroporto meglio illuminato. I cartelloni pubblicitari della business class di Qatar Airways le risplendono sul viso. ‘Fly with a smile’. Una modella con una fila di denti perfetti e un cocktail in mano le sorride luminosa. Ingrandisco. La donna sullo schermo ha smesso di borbottare e si morde concentrata il labbro inferiore, come se stesse soppesando con cura le parole nella sua bocca. Ha il collo lungo. Porta vestiti decisamente troppo leggeri per questa stagione: pantaloni e camicia scuri, senza giacca. Raccoglie la borsa da terra e la abbraccia appoggiandosela in grembo. Le sue nocche pronunciate si colorano di un bianco candido sul mio schermo. Mi chiedo cosa ci sia lì dentro, dove sia il resto dei suoi bagagli e perché stia spremendo la borsa in quel modo così sospetto.
Un bambino con una riga laterale ordinata, di circa sei anni, scende da solo sulle scale mobili. Non è un soggetto sospetto, ma non ci sono nemmeno adulti nelle vicinanze. Un bambino che si aggira da solo per un aeroporto non è mai un buon segno. Forse dovrei mandare Hasan a dare un’occhiata
per sicurezza? Sembra che gli sia stata inculcata la paura di cadere, visto come si aggrappa spasmodicamente al corrimano delle scale con la manina. Il bambino si dirige timidamente verso la donna con la borsa. Le mani strette a pugno. La donna distoglie lo sguardo, anche se ora è proprio davanti a lei. Scuote la testa in un no impercettibile, con piccoli scatti. Le sue labbra sono serrate. La schiena del bimbo si contrae ancora di più. È troppo giovane per essere madre?
Terminal 226
Chi ha progettato queste cosiddette sedie ergonomiche deve valutare di cambiare lavoro. Cerco di raddrizzare la schiena, una vertebra alla volta. Il freddo del metallo della sedia mi pervade fino alle punte dei capelli. Intanto provo a scaldarmi con la mia borsa. Stringendola abbastanza a lungo, la pelle diventa morbida e tiepida, un po’ come un corpo addormentato sotto a un piumino. Non ricordo quand’è stata l’ultima volta che ho dormito per un’intera notte, per non parlare del fatto che non so da quanto tempo esattamente sono qui. Nonostante ogni secondo sembri importante in un aeroporto, le ore paiono evaporare nell’aria come etere. Qui è sempre sia giorno che notte. Qui le luci splendono sempre mentre fuori si fa buio. Lo so per certo.
Un bambino spunta dal nulla ai miei piedi. Si avvicina troppo, i capelli ben pettinati, occhi grandi come caldarroste.
‘Mère…’
Il diaframma si contrae, involontariamente. Laringe, corde vocali e polmoni si serrano. È sempre così… questo maledetto singhiozzo. Odio perdere il controllo del mio corpo. Con voce strozzata cerco di cacciare il bambino, di delimitarmi, di mettere in chiaro che non posso essere quello di cui ha bisogno. Ma come si spiegano i confini a un bambino? Come gli si spiega che ci si scontrerà per tutta la vita? Confini tra paesi, tra corpi, nei mari, persino nello spazio aereo. Ho letto che ogni paese stabilisce da solo l’altitudine dei propri confini aerei. Come si fa a sapere quanto in alto bisogna saltare?
‘Mère…’ chiede di nuovo.
Francese? Mi mordo le labbra fino a farle sanguinare.
‘Merhaba.’
Panico. Non possiamo farlo, nessuna di noi. Mentre mi guardo intorno alla ricerca di qualcosa, il bambino tenta di controllare il tremore del suo labbro inferiore. Si aspettava altro da me. Che lo prendessi in braccio, che lo consolassi cullandolo dolcemente, forse. O che stringessi la sua mano umidiccia nella mia per andare in cerca della persona che se ne sarebbe presa cura al mio posto. Una madre, una sorella maggiore, un nonno. O un padre? Qui pullula di uomini che possono essere padri.
Un uomo con la testa rasata si precipita verso il bambino e afferra la sua mano con forza. Furioso per lo spavento, come se avesse perso per sempre il piccolo in lacrime. Potrebbe incenerirmi con lo sguardo. L’uomo e il bambino si allontanano da me in fretta. Sembra che pattinino sul pavimento liscio. Qui pullula di padri.
La stretta di mia madre. Riesco a sentirlo ancora oggi, l’arrivo, nel cuore della notte, ogni estate, quando mia madre, mia sorella e io atterriamo al minuscolo aeroporto di Nevşehir-Kapadokya. C’è odore di plastica, cherosene, e di notte che non finisce mai. Come una trinità, madre al centro e figlie per mano, una da una parte e una dall’altra, aspettiamo con ansia il momento di rivederci. E se ci ha dimenticate? Leggo nella la sua mano sudata. Ogni estate. Dobbiamo avere pazienza, aspettare che la nostra valigia azzurra ci scorra davanti e poi come lenti serpenti seguire la coda fino al controllo dei visti. Ogni estate. La paura di non assomigliare più alla fototessera, che i miei capelli si siano allungati troppo, che le mie guance non siano più piene e infantili. E che quindi ci rispediscano in Belgio con il primo volo. Ogni estate. Il sospiro di sollievo soffocato al momento del timbro sul visto. Finite le formalità andiamo a cercarlo. L’aeroporto è circondato da una cinta di uomini: tassisti annoiati, uomini seri, uomini nervosi, uomini assonnati. Tutti immobili in attesa. Ascolto attentamente e sento il silenzio di mio padre, il fumo di sigaretta come spire di nubi intorno alla sua testa. La mano di mia madre molla la presa e morte di sonno lo salutiamo, ma sapendo fin troppo bene che in questo arrivo si annida un addio. Ma ora: lui che mi prende in braccio, l’odore, sempre l’odore, il mio orecchio contro il basso nel suo petto, le mie mani intorno al suo collo. Poi in auto: l’odore familiare dei coprisedili della Volvo sgangherata, il bisbiglìo degli adulti sui sedili davanti, l’ipnotico occhio malvagio nello specchietto retrovisore, blu notte. La consapevolezza che anche questo passa.