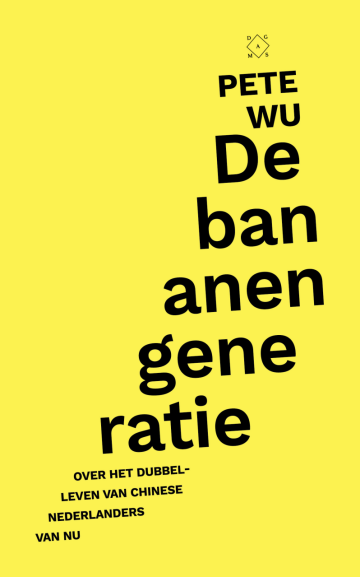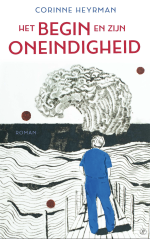L’ultima notte mi sembra di essere diventato troppo grande per il letto che usavo da bambino: gambe e braccia pendono oltre il bordo e ogni volta che mi giro strusciano contro un mobiletto TV rivestito di plastica e su alcuni sacchi trasparenti con dentro piumoni di ricambio; la mia vecchia cameretta è attualmente il ripostiglio dei miei genitori. Non riesco a dormire; dopo tutti questi anni mio padre si ostina ancora a non voler accendere il riscaldamento, mai, in nessuna stagione. Il freddo mi si insinua fra i piedi e si attorciglia prima ai mignoli e poi agli alluci. Scendo dal letto e vado verso la stanza dei miei genitori saltellando da un piede all’altro sul pavimento del corridoio.
“Ti va di restare a parlare un po’, fa?” chiede mia madre quando mi vede, mezzo in neerlandese mezzo in Wenzhouhua, il nostro dialetto cinese. Vado a sedermi ai piedi del letto. Come sempre prendiamo un paio di vecchi album di foto, li sfogliamo e ridiamo delle sue acconciature vaporose, dei miei pantaloni troppo corti, del volto affilato di mio padre – a quel tempo ancora magro –, della lunga giacca di pelle color mattone che indossava a Middelburg – la mia città natale – e che di recente mia madre voleva dare a me (“Indossala e fatti vedere da papà, ne sarà orgoglioso”), ma che è un po’ troppo appariscente per gli standard occidentali, di una foto sfocata di mia madre spaventata da qualcosa fuori dall’inquadratura. Continuiamo a guardarle fino a quando entrambi ne abbiamo abbastanza di ripensare al passato.
La mattina dopo mi aggiro per casa come un intruso smarrito, alla ricerca di qualcosa da mangiare prima di tornare ad Amsterdam. Sono sveglio già dalle sette e mezza. Mio padre ha sempre associato lo svegliarsi presto con il lavorare sodo, per questo non ci sono mai state tende alle finestre nella mia vecchia cameretta. Anche se ormai lui si sveglia verso le undici.
I miei vestiti puzzano di frittura perché ieri ho aiutato di nuovo a preparare le patatine fritte, i kipcorn e le frikadellen nell’olandesissimo snackbar al piano terra di casa nostra, qui a Tilburg. I miei genitori ne tengono le redini ormai dal 1994, ma lo faranno ancora per poco: a breve metteranno in vendita la Caffetteria De Vriendschap e traslocheranno da Tilburg a Rotterdam. Settanta ore di lavoro a settimana iniziano a diventare troppe, e Rotterdam, con i suoi negozi cinesi, sembra fare al caso loro.
Quando me l’hanno detto, qualche tempo fa, ho tirato segretamente un sospiro di sollievo. La caffetteria dei miei genitori è il posto in cui entro sempre con il cuore pesante, un luogo che associo alla mia gioventù e che per questo mi ricorda una prigione, un incubo pieno di maschere a due facce, alzarsi troppo presto, sopravvivere, sgattaiolare in punta di piedi sul pavimento freddo cercando di afferrare ogni occasione per andarmene via.
Questi sono la casa e lo snackbar dove non ho mai potuto essere me stesso, quando ancora mi nascondevo. Il piccolo corridoio che va dalla cucina allo snackbar è dove ho imparato da mio padre che gli omosessuali sono “disgustosi”. Questo è il posto dove gli altri olandesi ci vedevano come “i cinesi della friggitoria”. Qui sono sempre stato ciò che non volevo essere: disgustoso, non olandese. E perciò è qui che ho imparato a vergognarmi di tutto ciò che era cinese e gay, qualsiasi cosa pur di essere un po’ più come gli altri. Non vedo l’ora che i miei genitori si liberino della caffetteria, levino l’ancora e prendano il largo.
Mia madre compare sulla porta, in pigiama, e mi riscalda una grossa fetta di una torta salata fatta in casa, a base di cipollotto e grasso di maiale, una specialità della sua città natale Wenzhou, anche se di solito io faccio una colazione leggera. “Zuo loe! Chi!”, dice. Mangia. Siediti.
Potrebbe sembrare una scena tenera, ma negli ultimi quattro anni sono state ben poche le volte in cui ho parlato davvero con i miei genitori. Ci scambiamo parole cariche di imbarazzo come chiome degli alberi che, pur essendo l’una accanto all’altra, non si sfiorano mai. Il rapporto con i miei genitori è come quello con l’igienista dentale: ogni volta che ci vado mi sento in colpa, preso alla sprovvista, vorrei dimostrargli che so badare a me stesso, ma ogni volta c’è sempre qualcosetta da raschiare via dietro ai molari. Dopo il mio coming-out di quattro anni fa speravo che alla fine avrebbero trovato il tempo per conoscermi meglio. Ma quella conversazione ha solo dimostrato quanto sia grande in verità la distanza fra di noi.
I miei genitori hanno pagato per anni l’affitto della mia stanza da studente, tutti i miei studi e i libri universitari, affinché potessero decidere a quali criteri la mia vita dovesse conformarsi, secondo le loro regole e le loro aspettative. Avere successo e condurre un’esistenza eteronormativa, ad esempio. Forse da quando ho fatto coming-out i miei genitori sanno di più chi sono, ma non più cose su di me. Lasciamo sospese fra di noi cose non dette e restiamo immobili a fissarle. Ultimamente non mi chiedono più se ho una ragazza, ma neanche se c’è un ragazzo nella mia vita.
Faccio colazione in silenzio, in silenzio do un bacio a mia madre e in silenzio vado alla stazione.
Alla stazione centrale di Tilburg mi viene incontro un cinese sulla sessantina. Ha le spalle incurvate, un reticolo di rughe scavate attorno a una cavità delimitata da labbra secche. Procede a piccoli passi con i piedi dentro a un paio di vecchie scarpe da ginnastica sotto ai pantaloni di una tuta Adidas che chiaramente non ha provato prima di comprare. Distolgo istintivamente lo sguardo, ma lui è più veloce di me: il suo sguardo impaurito scatta verso il basso prima di sorpassarmi, lasciandomi intravedere per un attimo la testa pelata, un uovo all’occhio di bue nel quale il tuorlo si è rotto lasciando una piccola pozza gialla.
Mi torna in mente quello che mi ha raccontato Andre Alexander, un inglese di colore che ho intervistato una volta. Viveva a Chengdu, una città della Cina centrale dove un tempo non c’erano molti immigrati e per strada salutava con un cenno chiunque fosse di colore come lui: ti vedo, ti riconosco. Io invece – per la forza dell’abitudine – tendo sempre a un po’ ignorare gli altri cinesi-neerlandesi, forse per paura che qualcuno pensi che siamo insieme. O forse perché, stando loro vicino, temo che la loro cinesità possa contagiarmi.
Da piccolo non conoscevo molti altri cinesi-neerlandesi come me, cresciuti nei Paesi Bassi con genitori cinesi. Anche se, secondo il CBS (l’ufficio centrale di statistica), all’inizio del 2019 i cinesi di prima e seconda generazione che vivevano nei Paesi Bassi erano circa 100.000: il quarto gruppo più numeroso di migranti non-occidentali del Paese. Questo dato comprende i cinesi provenienti da Cina (circa il 75%), Hong Kong e Macau (19%) e Taiwan (4%) per un totale di 96.600 persone. In più ci sono anche gli immigrati cinesi (e i loro figli) che vengono da Indonesia, Suriname, Singapore, Malesia, Vietnam, Myanmar e Laos. È un numero non da poco.
Oltretutto sono qui da prima di quanto pensassi. Commercianti cinesi da Zhejiang (la provincia d’origine dei miei genitori) arrivarono in Europa già alla fine del diciannovesimo secolo passando per la Siberia, i cinesi aiutarono a costruire le trincee nel nord della Francia durante la Prima guerra mondiale, e si stabilirono, tra le altre, in città importanti come Mosca, Parigi, Marsiglia, Liverpool e Londra. Nel 1911 a Rotterdam si registrò l’arrivo di manodopera economica principalmente da Hong Kong e dintorni per sostituire i marinai olandesi in sciopero. In seguito al crollo della borsa nel 1929 la maggior parte di questi lavoratori restò perlopiù disoccupata; dopo la Seconda guerra mondiale solamente qualche centinaio di cinesi sopravviveva ancora qui, grazie alla comparsa della combinazione di ristoranti cinesi-indonesiani. Il successo di questa formula attirò nuovi cinesi e il numero dei loro ristoranti esplose.
I miei genitori arrivarono con i grandi flussi migratori degli anni Settanta e Ottanta. Cioè dopo la fine del regime comunista e isolazionista di Mao Zedong, quando il territorio cinese iniziò ad aprirsi sempre di più al mondo esterno, agli scambi commerciali e alla migrazione. Questi lavoratori stranieri ben presto si portarono dietro le loro famiglie. A quel tempo il ricongiungimento familiare era ancora una ragione molto efficace per ottenere il permesso di soggiorno.
Oggi la maggior parte dei cinesi dei Paesi Bassi vive in grandi città come Rotterdam, Amsterdam e L’Aia, ma sorprendentemente ce ne sono molti anche sparsi nel Paese. Io, ad esempio, sono cresciuto a Middelburg, dopo mi sono trasferito a Hoogerheide, e poi a Tilburg. Da bambino e da ragazzo non mi è mai capitato di parlare per più di cinque minuti con un altro cinese-neerlandese al di fuori della mia famiglia.
Immaginavo i cinesi come uomini d’affari piccoli e grassi in rigidi completi gessati, che camminavano per strada con una calcolatrice in una mano e una mazzetta di banconote nell’altra, urlando cifre al telefono in mandarino-cinese, mai in neerlandese. Le donne invece, nella mia testa, erano tipo geishe che annuivano sempre e si inchinavano a dimostrare la loro sottomissione mentre servivano un piatto di riso con carne di cane. Oppure erano mamme tigri: severe madri asiatiche pronte a distribuire scappellotti con una pantofola mentre i figli imparano a memoria le regole grammaticali di una lingua zulu, suonano il pianoforte e danno scaccomatto a qualcuno; meglio se tutt’e tre insieme.
La parte peggiore è che quando all’interno di un gruppo uno come me è sempre l’unico di qualcosa (nel mio caso a volte “cinese”, a volte “gay”, a volte “rompiscatole di poche parole”), diventa automaticamente il portavoce di quel “qualcosa”. Di solito, ad esempio, guardano tutti me quando si parla di ristoranti e piatti cinesi o di viaggi in Cina, perché tutti hanno di me un’immagine ben precisa. Come una volta mi disse mia madre un po’ per scherzo, un po’ con orgoglio: dentro puoi sentirti occidentale quanto vuoi, ma per il mondo esterno resti un cinese. Per sempre “giallo” fuori e “bianco” dentro. Una banana, insomma.
So che questo tipo di pensieri stereotipati (e interiorizzati) possono essere dannosi. Assicurano la discriminazione, mi fanno vergognare per quella parte di me stesso, e fanno sì che resti alla larga dagli altri cinesi. A tal punto da farmi sentire un intruso smarrito non solo nella casa dei suoi genitori, ma in tutta la società cinese-neerlandese.
Perché dovrei vivere con questa vergogna? Ho sempre vissuto una doppia vita: un’esistenza in cui con i compagni di classe vivevo in maniera più neerlandese possibile, ascoltavo musica pop occidentale e facevo festa, e l’altra a casa dei miei genitori, dove mangiavo “strani” piatti con medusa e cetriolo di mare e aiutavo per ore a preparare la salsa saté e gli involtini primavera; una vita di cui nessuno, fuori, sapeva niente.
Nell’estate del 2016, su richiesta del Volkskrant, ho scritto un racconto su un viaggio in Cina che ho fatto con mia madre. Avevo già fatto coming out da sei mesi, ma lei provò lo stesso a presentarmi una donna cinese a Shangai.
Quando l’articolo fu pubblicato, ricevetti molte lettere e reazioni da altri giovani cinesi-neerlandesi, di diversa istruzione, etero e omosessuali, che si sentivano capiti, che avevano riconosciuto le assurde aspettative dei miei, e che finalmente potevano spiegare ai loro genitori come si sentivano da figli di immigrati cinesi. Facciamo parte di una generazione che è nata e cresciuta qui, che deve navigare fra due mondi, due vite: una nella quale siamo cresciuti e una che abbiamo ereditato dai nostri genitori.
Grazie a quelle risposte realizzai quante cose avessi in comune con una miriade di altre persone, che ci capivamo senza dover spiegare molto.
“Se avessi letto prima la tua storia, quand’ero giovane”, mi ha scritto qualcuno, “allora avrei capito che non ero l’unico”.
Sì, l’avrei voluto tanto anche io, che ci fossero più articoli e libri che raccontavano esperienze nelle quali potermi riconoscere, così da imparare a non vergognarmi di quella mia parte cinese. Ma ormai questi pensieri mi sono entrati nella testa e non possono più essere fermati. Come se avessi svuotato delle scatole e il loro contenuto, quando provo a rimetterlo dentro, non ci sta più.
È tempo per il prossimo passo, penso quando mi giro a guardare ancora una volta il cinese con le vecchie scarpe da ginnastica. Considerato l’imminente trasferimento dei miei genitori dalla casa in cui sono cresciuto nella vergogna, decido che è arrivato il momento di lasciarla andare, quella vergogna. È tempo di capire da dove arriva, nella speranza che chi si riconosce nella stessa situazione (come il bambino che sono stato), possa sentire di non essere solo.
Da “banana”, da figlio di migranti, da essere umano ma anche da giornalista, vedo aumentare sempre di più l’impatto dell’immigrazione e del dover crescere all’interno della cultura dominante dei Paesi Bassi. Allo stesso tempo mi rendo conto anche di quanta poca attenzione ci sia per la seconda generazione neerlandese di provenienza cinese nei media e nella politica nazionale – così poca che persino io, un cinese-neerlandese, ho un’idea stereotipata degli altri cinesi-neerlandesi. Questo deve cambiare. Non conosco così bene nemmeno i miei genitori, e so quali conseguenze questo possa avere sull’idea che ho degli altri cinesi, vale a dire che è unidimensionale. E, probabilmente come ogni figlio, penso sempre più spesso che mia madre e mio padre stanno invecchiando (e che sto invecchiando anch’io) e perciò devo custodire quello che posso ancora custodire, ricordare quello che posso ancora ricordare, vivere, trattenere, subire finché io e loro condivideremo ancora una vita.